L’associazione politico-culturale “Città Futura”
e

in occasione dell’850° anniversario della nascita di Alessandria
presentano

Associazione politico-culturale “Città Futura”
Come eravamo
850° anniversario della nascita di Alessandria

storia e testimonianze
Introduzione
di Pier Luigi Cavalchini
Viviamo in una città bellissima, al centro di un territorio pieno di storia e di luoghi incantevoli. Un’oasi temperata, con le giuste quantità di verde, alternate al giallo, al marrone, ai grigi dei campi, agli scuri delle città. Sotto un cielo sempre differente, a volte grigio ma spesso (molto spesso) luminoso e con un azzurro profondo che notiamo solo al rientro da viaggi in terre lontane. Una città che sta cambiando composizione sociale, con un trend in discesa per quanto riguarda il numero di abitanti e in perenne, inesorabile, salita per quanto riguarda le percentuali di ultrasessantenni. Alessandria e il suo territorio saranno “altro” fra soli trent’anni, con il dieci per cento in meno di persone e con il restante novanta progressivamente sempre più eterogeneo, con storie diverse che ci portano ai quattro capi del mondo. Un territorio con un nucleo abitato antichissimo, ben precedente il XII secolo delle cronache. A Villa del Foro, “frazione” di Alessandria si hanno resti accertati del VII secolo a.C. e, addirittura, tracce di presenze preistoriche risalenti al paleolitico (con pietre scheggiate), così com’è stato possibile rinvenire altri “segni” del mesolitico nel “primo” Cristo, nell’area dell’antica fornace Testa. Di sicuro c’erano ponti in legno di una certa stabilità e robustezza sia sulla Bormida che sul Tanaro. E, strano ma vero, ben prima della mitica “fondazione”, probabilmente già in epoca romana, visto che l’attuale città si estende su parte di quello che era l’antico tracciato della via Fulvia tra Derthona, Forum Fulvii (Villa del Foro) e Hasta (Asti), quella che “porta su” fino alle Alpi e poi alle Gallie. Di quei tempi c’è rimasto poco, ma quel poco dovrebbe ricomparire, rifiorire, rinnovarsi, materializzarsi grazie ad abili ricostruzioni verbali o virtuali, anche perché la tecnica computerizzata ci permette, oggi, meraviglie.
Di solito, quando si vuole cercare qualche traccia “antica” in Alessandria, si ricorre al giro canonico Santa Maria di Castello, Palatium Vetus, area della chiesa di san Francesco, area dell’antica cattedrale, edificio del Tinaio degli Umiliati e area della chiesa di san Rocco. Con qualche puntata nei due sobborghi posti ad est e ad ovest della città: Marengo e Villa del Foro. Ricordando, nei casi fortunati in cui si ha a che fare con “guide” degne di questo nome, che nei “campi” di Marengo, oltre ai resti napoleonici sono stati rinvenuti meravigliosi “argenti” di epoca romana oltre a innumerevoli monete e che, nei pressi dell’antica Forum Fulvii, sono state trovate, oltre a costruzioni di qualità, oggetti preziosi, monete e perfino un amuleto in oro con iscrizione greca che ci invidia mezzo mondo. Di Santa Maria di Castello, della chiesa di san Rocco, del quartiere limitrofo di “Rezolia”, delle antiche porte stupidamente abbattute (tra cui quella storica del comandante Ravanal), della bellissima antica cattedrale tardoromanica rasa al suolo dall’insipienza combinata di famiglie nobili locali e della “grandeur” napoleonica, avremo modo di argomentare.
“Come eravamo” è stato pensato apposta per questo. Una “finestra” del giornale “Città Futura” sempre aperta su come si era e su come si sarebbe potuti essere. Sicuramente meglio con l’antico duomo, con le mura milanesi restaurate a puntino e non abbattute “per far lavorare chi ritornava dal fronte nel 1919”. Senza dubbio in migliori condizioni se si fosse dato più spazio all’architetto Gardella o all’architetto Straneo o anche solo a Venanzio Guerci, mantenendo uno “skyline” adeguato e non irrimediabilmente rovinato da casermoni tutti uguali, più simili al peggior “realismo socialista” che a una città in naturale evoluzione. Una “finestra” con vista su quanto di bello è stato fatto in questi anni dalle associazioni di volontariato, da quelle che si impegnano per l’integrazione effettiva, e per quanto è stato fatto per creare e mantenere lavoro e benessere. Una rubrica (la nascente “Come eravamo”) che potremmo definire meglio “come siamo” o come siamo arrivati a essere quello che siamo oggi, che poi è lo stesso.
Storia
02. I borghi fondativi della città
04. L’organizzazione comunale dagli inizi
07. Verso la contemporaneità; ‘800 e ‘900
01. La nascita di Alessandria
Introduzione
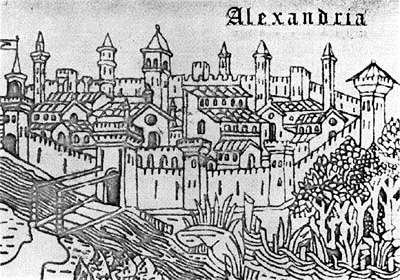 Quest’anno si celebra l’850° compleanno di Alessandria. Già, ma come abbiamo fatto a stabilire la data di nascita della nostra città? Cosa sappiamo di chi l’ha voluta, di chi l’ha osteggiata, di chi l’ha costruita e abitata? Cosa sappiamo del perché è stata edificata proprio dove si trova ancora oggi e cosa sappiamo del perché è stata chiamata così? Per rispondere abbiamo scelto un saggio di Geo Pistarino che conta ben 33 pagine ed è molto complesso. Ma, poiché ci è sembrato centrare tutte le risposte alle nostre domande, abbiamo pensato di riportarle qui, tacendo le parti non congruenti con i quesiti che ci eravamo posti all’inizio.
Quest’anno si celebra l’850° compleanno di Alessandria. Già, ma come abbiamo fatto a stabilire la data di nascita della nostra città? Cosa sappiamo di chi l’ha voluta, di chi l’ha osteggiata, di chi l’ha costruita e abitata? Cosa sappiamo del perché è stata edificata proprio dove si trova ancora oggi e cosa sappiamo del perché è stata chiamata così? Per rispondere abbiamo scelto un saggio di Geo Pistarino che conta ben 33 pagine ed è molto complesso. Ma, poiché ci è sembrato centrare tutte le risposte alle nostre domande, abbiamo pensato di riportarle qui, tacendo le parti non congruenti con i quesiti che ci eravamo posti all’inizio.
Geo Pistarino
La doppia fondazione di Alessandria, Rivista di Storia Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti, 1997
La fondazione di Alessandria, fra la convergenza dell’Orba con la Bormida e quella di quest’ultima col Tanaro, venne a colmare la mancanza d’un grosso centro abitato nella pianura fra Tortona e Acqui. L’operazione venne formalmente intrapresa, stimolata e diretta, più o meno apertamente, dai consoli delle città della Lega, che evidentemente se ne assunsero la responsabilità mancando il beneplacito imperiale. Come d’obbligo, forse essi medesimi scelsero il nome della nuova città? Fu davvero finanziariamente sostenuta, non si sa bene come (prestito? donativo?) dal governo di Genova, come dicono gli Annalisti genovesi, che riteniamo bene informati?
Una risposta del tutto esauriente appare impossibile, data la contraddittorietà delle altre fonti del tempo, narrative e documentarie.
L’imperatore, nel testo del reclamo contro Cremona del 1184, indica esplicitamente i promotori ed autori della fondazione della nuova città, la quale trasse origine de tribus locis, Gamunde vicelicet et Meringin et Burguh: cioè Gamondio, Marengo e Bergoglio …. L’antica curtis di Rovereto venne inglobata topograficamente solo in un secondo momento nel centro demico posto in essere dalle decisioni dei consoli della Lega e dall’azione degli immigrati confluiti da Gamondio, Marengo ed altri luoghi … L’infelice campagna federiciana fece il resto, consentendo il libero afflusso di nuovi immigrati che portò il tessuto demico di Alessandria al complesso degli otto «luoghi» di cui parla il trattato di pace tra Federico imperatore e Tortona, citando gli «homines qui de octo villis infrascriptis apud PaJearh collecti sunt: Marenge, Gamundi, Ouilli, Four, Bergul, Solero, Wargnent, Rouere».
Quale fu esattamente il luogo in cui sorse il nuovo agglomerato demico? Nei primi vent’anni della sua storia la nostra città presenta nelle fonti quattro diverse denominazioni: Alessandria, Cesarea, Palea, Rovereto … Il vero e proprio toponimo dell’area su cui sorse la civitas nova è però quello di Palea che, secondo la più diffusa interpretazione corrente, vuole indicare il luogo palustre; nel nostro caso specifico la petraia fluviale alla confluenza tra la Bormida e il Tanaro, od anche, come mi sembra abbia inteso Francesco Cognasso, il punto maggiore del modesto rialzo del suolo che lo sottrae alle inondazioni e agli impaludamenti.
Quando possiamo collocare la fondazione della nuova città, se ci fu un vero e proprio atto formale, come resta ancora da dimostrare? Quando essa compare alla storia, il 3 maggio 1168, ha già raggiunto una configurazione topografica, urbanistica e amministrativa definita, quale dimostra la sua struttura di governo della comunità secondo l’ordinamento consolare della collettività, di cui tuttavia non conosciamo i particolari burocratici. Certamente agirono nella configurazione dell’assetto civico le suggestioni della Lega; ma non dovettero mancare gli stimoli e le esperienze genovesi dal momento che la Superba si mostrò interessata alla costituzione della nuova città, prima in via privata, poi con l’intervento del finanziamento pubblico.
L’insofferenza per le strutture feudali, che lo scontro tra l’imperatore e gl’insorgenti Comuni ha determinato anche nel ceto agrario, le aspirazioni associative dei nuclei rurali, che la proiezione d’istanze economiche nuove e di ricerca di traffico che pervadono il contado prospettano alla Lega e, di riflesso, alla Repubblica del Tirreno. Opportune, anzi tempestive possibilità di stimolo, d’intervento, di coordinazione. Anche Genova sa, per le esperienze acquisite in Liguria, in Provenza, in Sardegna, in Oltremare, come suscitare fermenti ribellistici e determinare moti più o meno spontanei nella richiesta di nuovi ordinamenti di governo. L’area della confluenza tra la Bormida e il Tanaro, nel cuore del Monferrato dove confinano i limiti di diocesi diverse, di diverse professioni di obbedienza tra papa e antipapa e dove una serie di curtes regie controlla il territorio, ora in sintonia ora in dissonanza con gl’interventi sia marchionali sia imperiali. rappresenta un settore facilmente vulnerabile.
Oggi [la fondazione di Alessandria] a noi appare, ed è nella storia, un grande evento. Allora fu una semplice mossa politico-militare di sfondo economico, dettata dalla strategia del momento, che poteva anche esaurirsi con la vittoria di Federico.
02. I borghi fondativi della città
Introduzione
Abbiamo visto, nel capitolo precedente, come Alessandria sia stata precipuamente fondata intorno ai quattro borghi di Bergoglio, Gamondio, Marengo e Rovereto. Cominciamo dal più importante di tutti, quel Bergoglio, l’unico in sponda sinistra del Tanaro e dunque il primo a subire qualsiasi attacco da parte dei nemici che volessero sfondare le porte e irrompere nell’abitato cittadino. Per questi motivi Bergoglio, nonostante la distruzione subita per fare spazio alla Cittadella, presenta ancora una notevole serie di elementi di approfondimento: Fausto Bima ci presenta il borgo nella sua struttura architettonica di base, nella quale egli intravede la derivazione dallo schema di un preesistente accampamento romano; Gianfranco Calorio ci ritorna invece un’immagine sociale: quella di una specie di posto di frontiera, con regole, consuetudini e abitudini tutte proprie; Carlo A-Valle si inserisce in quest’ultima immagine, piena dei contrasti fra guelfi e ghibellini, facendoci trasparire come a Bergoglio si manifestasse una tendenziale supremazia dei guelfi in virtù della maggiore forza e del maggior prestigio goduti dalla famosa famiglia dei Guasco.
Per il resto dei borghi, invece, si fa qualche fatica a rintracciare notizie su cui si possa risalire al loro passato. Di Gamondio vi riportiamo un testo di Geo Pistarino che cerca di decifrare l’origine del nome, Di Rovereto abbiamo la grande chiesa di Santa Maria di Castello, di cui riportiamo due descrizioni. Per la corte longobarda e poi franca di Marengo ci affidiamo inizialmente alle suggestioni di Giancarlo Patrucco, che fa rivivere le grandi cacce longobarde e i molti agguati compiuti in quelle foreste sterminate e impenetrabili. A chiudere, possiamo presentare infine un tesoro formato di pregevoli manufatti romani rinvenuti mediante alcuni scavi archeologici in loco: “Il tesoro di Marengo”. Porta questo titolo il ponderoso volume che raccoglie gli atti di un convegno tenutosi ad Alessandria il 20 marzo 2010; convegno nel quale si esaminano tutti gli aspetti relativi ai reperti ritrovati nel 1928 presso la cascina Pederbona, dove erano restati sotto terra per secoli: politica, archeologia, arte romana, prassi normative e inevitabili passaggi burocratici che un rinvenimento del genere impone. Ma un tesoro, da che mondo è mondo, porta con sé un misto di astuzie, bugie, versioni contrastanti, imbrogli e omicidi. Qui non ci sono morti ammazzati, ma il resto sembra starci tutto, raccontato nel primo intervento riportato negli atti, a firma Ornella Orbassano. E, con questo, chiudiamo la parte dedicata alla fondazione di Alessandria.
Fausto Bima
Ipotesi sull’origine di Bergoglio, Rivista di Storia, Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti, 1932
Dei sette luoghi che vediamo presenti all’atto della fondazione del Comune di Alessandria nel 1168 Bergoglio è quello di cui le notizie sono più scarse … ciò è dovuto al fatto che nel 1728 Vittorio Amedeo II abbatté il borgo e vi fece l’attuale Cittadella … Sull’origine dunque, fino ad oggi, non è stato detto ancora nulla di attendibile. Io credo però che, fino ad oggi, nessuno abbia mai osservato attentamente una pianta di Bergoglio. La più antica pianta che si abbia risale al 1630 circa ed è un disegno acquerellato montato su tela, riproducente le fortificazioni di quell’epoca.
Una cosa colpisce subito l’osservatore: le vie di Bergoglio sono perfettamente perpendicolari tra loro, dirittissime, larghe; l’insieme del borgo … è rettangolare. Per contrasto, guardando la parte della città sulla destra del fiume … vediamo … un groviglio di vicoli, di viuzze, di vie storte incrociantesi con disordine … Vediamo insomma la caratteristica edilizia della città medioevale …
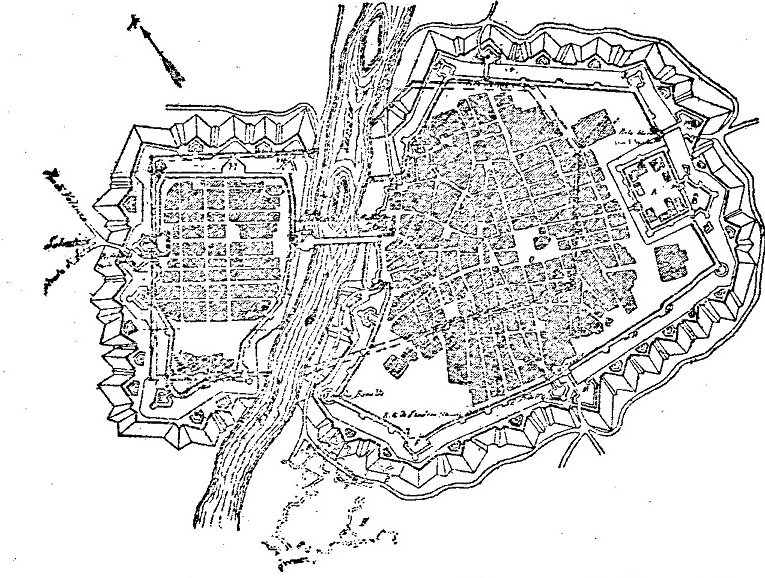
Pianta di Bergoglio del 1639
Disegno acquerellato delle fortificazioni nel sec. XIII
Si potrebbe pensare che fosse un ricetto … sorto contro le incursioni saraceniche del secolo X e XI … Escluso che sia sorto nel medioevo … non resta dunque che l’ipotesi che io sostengo e cioè che Bergoglio sia sorto da un accampamento romano. Non è improbabile pensare che, in una località in cui le vie naturali … si incrociano, strategicamente ed economicamente importante, in cui confluiscono biade e foraggi abbondanti, luogo intorno al quale vi sono vari paesi … la saggia organizzazione romana avesse posto un campo invernale in cui potessero svernare delle truppe.
Sono passati almeno 15 secoli, ma l’aspetto generale è immutato. Qualche edificio alla periferia un po’ smussato, un solo vicolo curvo a un’estremità; al centro la piazza per il praetorium, vi sporge solo da un lato un edificio. E, se tutti questi sono i mutamenti avvenuti in 15 secoli, non possiamo dire che siano tanti e tali da oscurare le caratteristiche che voglio mostrare. Potrà esser oggetto di orgoglio il sapere che quel borgo fu romano, potrà servire questa identificazione a qualche studioso per interpretare notizie di cronisti o leggende e non altro.
Comunque per me sarebbe già gran cosa l’aver raggiunto il vero.
Gianfranco Calorio
Bergoglio. Ricostruzione storico-iconografica del Borgo antico di Alessandria prima della costruzione della Cittadella, Ed. Favolarevia, 2000
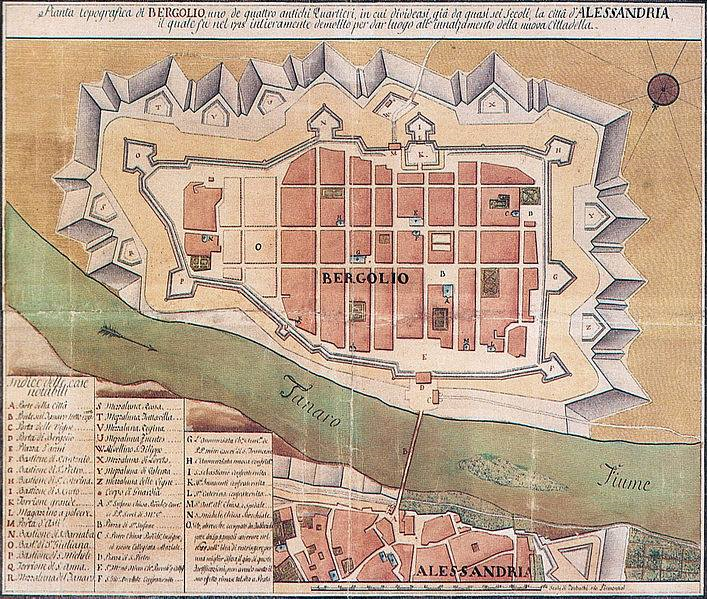
Qualcuno intanto potrebbe domandarsi che interesse può avere ancor oggi Bergoglio, un quartiere da troppo tempo ormai scomparso e dimenticato, sostituito dalla Cittadella, per la demolizione del quale non s’era disperata più di tanto la città … Beh, aldilà dell’interesse degli studiosi che amano scavare nel passato, è quantomeno strano il silenzio che ha circondato la sua fine …
Borgoglio (o Bergolio o Burgulium) risulta esser stato un borgo scomodo: le sue chiese seguivano il rito ambrosiano, era dichiaratamente filo-francese anche quando Alessandria era sotto dominio spagnolo; pare addirittura che per qualche tempo abbia battuto moneta propria; dava asilo ai “ricercati politici” della città e, se misteriose erano le sue origini, non chiarissima fu la sua fine. Per questo è stato necessario un lavoro virtuale di scavo archeologico avvalendoci delle più svariate fonti documentarie:
d’archivio (Consuetudini, Statuti, Instrumenti, donazioni, atti notarili, ecc,);
letterarie (cronache e annali dei molteplici storici locali, visite pastorali, ecc.);
grafiche (planimetrie catastali, piante topografiche, progetti, ecc.);
fotografiche (foto aeree territoriali, ecc.);
dirette (sul campo).
Nella ricostruzione del borgo sono stati analizzati prioritariamente il territorio e l’abitato, con un processo a ritroso nel tempo fin dov’è stato possibile.
Il “territorio è stata indubbiamente la parte più faticosa dello studio, ma anche la più interessante e sorprendente, anche perché ancor oggi, a mille anni di distanza, pur sotto la stratificazione dei secoli, sono coglibili i segni della trasformazione (dall’epoca romana a quella medioevale, rinascimentale seicentesca); toponimi, assi viari, rii, chiese campestri, ecc.
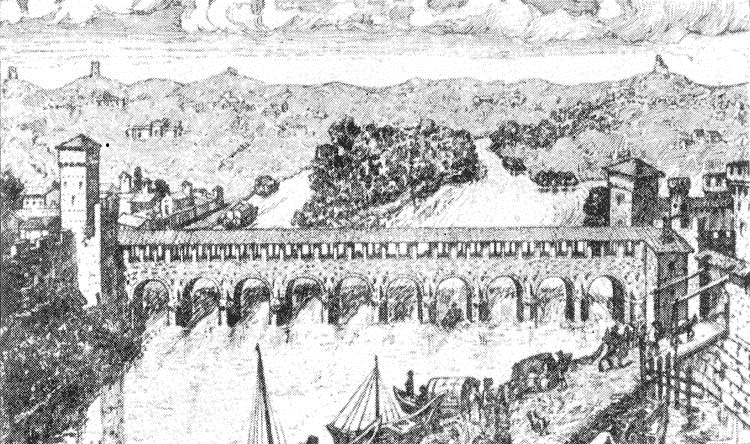
Ponte sul Tanaro del 1453
Per quanto concerne l’abitato (il borgo, per intenderci) questo lo si trovava quasi sempre rappresentato attraverso il semplice disegno del suo contorno (la cinta fortificata), “a fil di ferro” , raramente tramite una dettagliata descrizione del suo edificato interno; veniva ad esserne evidenziata semmai la trama viaria, l’ordito di assi tra loro ortogonali che rimandavano a un lontano passato, senza peraltro che ne fosse riportato l’”insulario” o lo “stradario” relativo, fatta eccezione per la contrada Maestra, asse principale per uscire dalla città attraverso il ponte.
Si è riusciti comunque a comporre per buona parte il mosaico interno, facendo così rivivere gli spazi. Ne è scaturito uno “spaccato d’epoca” che, anche se incompleto, è ritenuto importante dall’autore quale punto di partenza per approfondimenti futuri sul campo.
Carlo A-Valle
Storia di Alessandria (dall’origine ai nostri giorni), Tipografia Falletti, 1855
La famiglia Guasco
Senza tema d’errore, noi possiamo chiamare questa famiglia come prima in Alessandria, vuoi per nobiltà di natali, vuoi per abbondanza di fortune, vuoi per valore, vuoi finalmente per intelletto. I Guaschi vennero dalla Francia in Italia due secoli prima della fondazione di Alessandria e, intorno al mille, avevano già poste le loro stanze nella terra di Borgoglio. dove abitarono sempre, fino a che il villaggio venne distrutto per dare luogo alla cittadella che vi sorge di presente. In Borgoglio i Guaschi avevano acquistate vaste campagne e rizzati forti castelli, cosicché vi stavano con maniere principesche. E noi vedemmo quel Scipione che, nella crociata del millenovantanove, combatteva eroicamente in levante per la fede di Cristo e meritava di essere celebre negli immortali versi di Torquato.
Appena Alessandria sorse, i Guaschi ne furono campioni zelanti e benefici; la loro famiglia si schierò tra le guelfe del comune e, per tutto il tempo in cui duravano le fazioni maledette, fu sempre antesignana del partito, per cui ebbe molte volte a soffrire saccheggi e rovine. Segnatamente nel milledugentotrentadue, nel quale anno il popolo trasse a furia alle sue case e le diede alle fiamme.
l Guaschi ebbero in grado eminente e in ogni tempo il peccato della nobiltà: l’orgoglio. Quindi non sempre posposero i rancori privati al pubblico bene e nocquero molte volte alla patria alla quale insidiarono le forme democratiche finché intieramente le spensero. …
…1 Guaschi furono sempre avversi ai marchesi di Monferrato, cui sovente debellarono: ai Visconti e agli Sforza, di cui ruppero più d‘una volta il giogo, e al dominio spagnolo a cui sempre di cattivo grado si rassegnarono.
All’incontro desideravano e invocavano più fiate il governo francese, al quale fedeli si mantennero infino all’ultimo. E ciò non era per avventura difetto d’amor patrio, avvegnachè non sia delitto di lesa carità cittadina lo scegliere fra le signorie straniere quando un governo nazionale è fatto impossibile.
La famiglia Guasco fu liberale verso la religione all’uso dei tempi e, nel milletrecento, concorse all’erezione della chiesa e del convento di santo Stefano in Borgoglio, arricchendo 1’uno e l’altra di edifizi e di rendite. Nella tirannide di Facino Cane, mentre Alessandria non osava levare la testa, i Guaschi soli e i loro aderenti gli resistevano e molti di loro lasciarono da martiri la vita sul patibolo. Molti, abbandonate le patrie sedi, si dispersero nel Piemonte e furono stipiti di nuove famiglie.
Guasco Alberto fu uno dei più valorosi capitani e dei più onesti cittadini che Alessandria vantasse nel secolo decimoterzo. Egli si trova nel numero dei benemeriti che nel milleduecentosessantasei conciliarono le fazioni guelfa e ghibellina, la prima capitanata dai Pozzi e la seconda dai Lanzavecchia. I Guaschi erano del partito guelfo.
Geo Pistarino
Sull’origine del nome di Gamondio, Rivista di Storia Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti, 1964
Tra i beni che Ugo di Provenza, re d’Italia, dona alla propria sposa, Berta di Svevia, nel 937, compare, per la prima volta nella storia, la corte di Gamondio. Essa rientra in quel complesso terriero di proprietà regia che è situato nel lembo della pianura, oggi fertilissima, un tempo paludosa e malsana, che s’inserisce a guisa di cuneo nella confluenza tra l’Orba, la Bormida e il Tanaro … Col secolo XIII all’antica Gamondio subentra, attraverso un modesto spostamento del centro abitato, l’odierna Castellazzo il cui toponimo romanzo determina la rapida scomparsa dell’antica denominazione.
Quanto sono chiari e sicuri il significato e l’origine del nuovo nome del luogo, altrettanto sono oscuri ed incerti quelli dell’antico, intorno a cui si sono affaticati storici e glottologi dal trecentista Iacopo d’Acqui ad oggi. La voce più antica, isolata nel documento reale del 937, è Gaumundium: in seguito il toponimo suona normalmente come Gamundium, sia nei testi documentari sia nei testi narrativi. É nome locale scomparso, almeno per i centri abitati d’una consistenza anche esigua. Nel secolo X gli possiamo invece accostare una vallis Gaudemundi, nell’Astigiano, di cui ci dà notizia un atto del 980, mentre qualche tempo più tardi incontriamo la stessa voce nell’onomastica personale della zona che c’interessa: un Albertatius Gamondi Sigifredi compare nel 1199; un Gamundinus e un Gamundius de Quargnento nel 1218; un Anricus Gamundus nel 1224.
Gamondi è cognome tuttora diffuso nell’alessandrino e nell’acquese. Ma il nostro toponimo non è limitato all’Italia. In territorio franco-tedesco troviamo un esempio ben più notevole con la località di Gamundias/Gaimundias (l’odierna Sarreguemines nel dipartimento della Mosella), ricordata in documenti merovingici del 706, la quale ricompare come Gumunde nel 1237, Guemunde nel 1263, Gemindt nel 1380, Gemont nel 1471, Sargemunt nel 1577, Zerguemine nel 1632, Guemund nel 1641. Un documento del 1153 cita un abbas Gemundi: oggi Gimont, capoluogo del cantone di Gers.
Qual’é dunque l’origine del nome? Iacopo d’Acqui ha proposto l’etimo di Gaudium Uundi, poetico ma inconsistente. Il Merula, il Lumelli, lo Schiavina, il Durandi sono risaliti all’antico ligure: in particolare il Durandi si è rifatto a una presunta serie Casmonium, Gasmonium, Gusmundium, Gamundium. Il Burgonzi ha pensato a un’origine gotica: da gaium, bosco e mund, potestà o tutela, oppure dal nome della città di Gmund ad est di Stuttgart. Il Canestri ha accolto quest’ultima ipotesi ricordando, a conforto della medesima, la testimonianza del Muratori circa l’uso dei Longobardi di portare in Italia i nomi dei paesi d’origine. Il Gasparolo ha pensato a una derivazione dal germanico Gemeinde.
É indicativo il fatto che un certo numero di autori ha propugnato l’origine germanica del toponimo con argomenti notevoli, di fronte a coloro che hanno pensato a un’origine paleoligure. Siamo anche noi dell’opinione dei primi, ma pensiamo, attenendoci all’etimo proposto dal Vincent per i toponimi del territorio francese, che ci si debba rifare, anzichè a Gaium – mund o a Gmund o a Gemeinde, all’antica voce germanica Gamundi, equivalente di « imbocco », « imboccatura ». Il termine si addice infatti – e si trova riferito – alle località poste all’imbocco di una valle o, come il nostro Gamondio, allo sbocco di un fiume in un altro. Può considerarsi come l’equivalente tedesco della voce « Bocca », largamente diffusa nella toponomastica italiana, soprattutto in area settentrionale.
A questo punto ci sembra legittima una conclusione: trattandosi d’un nome che indica condizione del suolo, l’appellativo di Gamondio preesistette certamente al centro abitato, le origini del quale non possono pertanto ricercarsi né tra i Liguri né tra i coloni latini, ma devono collocarsi nel periodo della penetrazione germanica in Italia durante il basso Impero, o in periodo gotico, o, più probabilmente, in età longobarda.
Lorenzo Mina
Della chiesa di Santa Maria di Castello in Alessandria, Rivista di Storia, Arte e Archeologia per le Province di Alessandria e Asti, 1903
Di tutte le chiese di Alessandria la più antica e la più degna d’essere studiata accuratamente, sia dal lato storico che da quello artistico, è Santa Maria di Castello. I vari guasti e le aggiunte fatte in diverse epoche e i restauri male intesi non ne scemarono del tutto l’aspetto originale antico. Anzi, osservando attentamente, vi si possono facilmente riscontrare le tracce delle varie vicissitudini alle quali questo monumento sacro è stato necessariamente sottoposto.

Santa Maria di Castello
Per dare qualche dato numerico dirò intanto che la superficie occupata dalla chiesa e dal chiostro in totale si può ritenere ammontare in mq 3870 in digrosso, dei quali solo 1350 mq appartengono alla chiesa propriamente detta, che copre un rettangolo di m. 54 x m. 25, e 2520 mq., al chiostro e relative celle e abitazioni. La chiesa è sollevata sul piano della piazza di cinque gradini di 18 cm. d’alzata ciascuno, vale a dire un totale di circa cm. 90. La gradinata dinanzi la chiesa prima non esisteva e si saliva per entrare nell’edificio un solo gradino, ma quando venne abbassato il piano della piazza e aggiunto tutt’attorno uno zoccolo di mattoni a paramento, fu necessario apporvi tale gradinata per accedere al sacro edifizio …
Entriamo nel tempio per la porta maggiore principale. Abbiamo già detto che esso occupa colle sue circostanti mura lo spazio di mq. 1350, fornito da un rettangolo di m. 54 x 25. In questo rettangolo è compresa tutta la chiesa che propriamente si svolge colla sua costruzione principale e centrale su d’una pianta a croce latina di pretto stile Lombardo. Lateralmente alla navata grande centrale stanno due navate minori e più basse, quindi vengono le cappelle aggiunte. Dopo il transetto, volto all’oriente secondo il rito cristiano, è nel centro il santuario od altare maggiore e poi, subito dietro, il coro. Di fianco al santuario, da ambe le parti, sono due grandi ambienti di passaggio per uso delle funzioni e, proprio addossato alla parte sinistra del coro, s’impianta il campanile certamente costrutto dopo.
A cominciare da destra, entrando fino al transetto, si incontrano, l’una di seguito all’altra, le seguenti cappelle:
CAPPELLE DI DESTRA CAPPELLE DI SINISTRA
1. Cappella del Confessionale 1. Cappella del Battistero
2. Cappella di Sant’Onofrio 2. Cappella del Confessionale.
3. Cappella di Sant’Ubaldo 3. Cappella di Sant’Antonio
4. Cappella del Crocifisso 4. Cappella della Madonna del Rosario
5. Cappella di Santa Teresa 5. Cappella di Nostra Signora del Sacro Cuore
6. Cappella del Sacro Cuore 6. Cappella di San Giuseppe
Procedendo a visitarne la chiesa, si viene al transetto. Questo è costrutto proprio normalmente alla navata centrale e corrisponde ad essa e alle due minori. La superficie libera occupata dal transetto, esclusi i muri e i pilastri, è di mq. 144, consistenti in un rettangolo di m. 8 di larghezza e m. 18 di lunghezza. Di più, verso la piazza ha un’aggiunta di mq. 24 (3×8), corrispondente alla porzione aggiunta delle cappelle. Finalmente viene il Santuario o presbiterium che copre, colla sua pianta quadrata di m. 9 di lato, la superficie di mq. 81 ed è sollevato dal pavimento della chiesa di m. 0,80, al quale si accede mediante una gradinata di marmo di 5 gradini. E’ separato dal transetto da una bella balaustrata di marmo antico ed è finito posteriormente dal coro a pianta quasi semi-ottagona, simmetrica rispetto l’asse della chiesa … Finalmente abbiamo le due ali fiancheggianti il presbiterio, di m. 5 per m. 9. Il campanile, a pianta quadrata di m. 4 di lato, è a sinistra incastrato fra l’incrocio del braccio del presbiterio e di quello del lato est del convento.
Antonella Perin e Carla Solarino
Santa Maria di Castello, in “Chiese, conventi e luoghi pii della città di Alessandria”, BCA Studi e ricerche, n. 7, Alessandria, s. d.
La chiesa di Santa Maria di Castello può essere considerata un simbolo della storia urbana di Alessandria. Viene indicata, infatti, come luogo più antico della città in assenza visiva del polo religioso per eccellenza, l’antico duomo. In occasione di interventi di restauro effettuati nel 1887 e di scavi archeologici databili tra il 1970 e il 1971, sono state rinvenute tracce di un edificio preromanico ad aula absidata, ascrivibile al periodo tra l’VIII e il IX secolo. La scoperta conforterebbe il legame storico con l’antico insediamento di Rovereto, documentato sin dall’VIII secolo e ricordato come “curtis regia” del tardo IX secolo. La fase costruttiva romanica, preesistente a quella attuale, iniziò nell’XI e terminò nel XII secolo con la realizzazione del transetto e fu resa possibile grazie alle donazioni di fondi da parte di famiglie alessandrine (conti Canefri).
L’edificazione della chiesa va posta in relazione con le dinamiche dell’insediamento e del popolamento del Borgo Rovereto, sede di mercato, presso il ponte sul Tanaro, difeso dal “castrum” fortificato. All’interno di questo primo nucleo e del suo polo religioso si incrociarono privilegi reali, pretese di gruppi nobiliari e diritti di diocesi vicine.

Parte centrale della chiesa
Riguardo al castello associato al nome della chiesa (scrive Claudio Zarri), “non esiste documentazione iconografica attendibile, ma solo tarde immagini convenzionali con schematiche visioni di edificio turrito”. All’epoca i castelli consistevano, per lo più, in rozze cerchie difensive ed è verosimile che la chiesa fosse compresa in un’area protetta da terrapieni e palizzate.
I religiosi che nella prima fase officiarono a Santa Maria furono probabilmente legati ai canonici di Santa Croce di Mortara (1082). Dopo una fase di decadenza, sia per l’Ordine che per le strutture edificate, si registrò un periodo di rinascita intorno alla metà del XV secolo con il passaggio ai canonici regolari di Sant’Agostino, i Lateranensi detti anche Rocchettini, che nel 1449 incorporarono i canonici di Mortara (bolla di Papa Nicolò V).
In questo periodo alcune famiglie emergenti del quartiere di Rovereto, quali i Bianchi, i Dal Pozzo, i Panizzoni e gli Inviziati, diedero vita alla fase più fiorente della storia della chiesa sotto il profilo architettonico e artistico. Nel periodo 1449-1540 si verificò, infatti, una fase di sostanziale riprogettazione dell’edificio, ossia il rifacimento del campanile, la costruzione dell’abside, della cappella maggiore, delle navate laterali e del chiostro, accompagnata da significativi interventi sul piano della decorazione e della dotazione di dipinti, sculture e arredi.
Nel 1545, la chiesa e il cimitero adiacente vennero consacrati e l’alto rilievo in pietra policroma della “Madonna della Salve” venne collocato nell’ottava cappella interna. Una successiva fase abbraccia circa tre secoli e mezzo di storia in cui si consolida la struttura del complesso conventuale che nel 1629 ottenne il riconoscimento di abbazia dei Canonici Lateranensi da parte di Papa Urbano VIII.
Nel 1798 il monastero venne soppresso e la chiesa ebbe esclusivamente funzione di parrocchia. Quindi la struttura conventuale venne utilizzata come ospedale militare e caserma. Nel 1824 venne ceduta ai Padri Somaschi e, in seguito, all’Opera Pia De Rossi; nel 1834 le suore di Carità aprirono nel chiostro una scuola femminile per indigenti. Negli anni delle guerre di Indipendenza l’amministrazione militare riprese possesso del convento.
In quanto a sculture, dipinti e arredi della chiesa è già stato menzionato il gruppo della Madonna della Salve che veniva indicata, a detta di alcuni storici, come “Madonna dello Spasimo” e solo successivamente Madonna della Salve. Il culto popolare trovò nelle iniziali della parola Salve una sintesi di devozione alla Madonna, facendo sorgere l’espressione “Sempre Alessandria La Vergine Esaudisce.”
Altro documento straordinario è la lapide sepolcrale di Federico Dal Pozzo del 1380, posta nella prima cappella a destra; sullo stesso lato, l’affresco della “Madonna con il Bambino tra i santi Onofrio e Giovanni Battista” del XVI secolo, attribuito a Giorgio Soleri. E, ancora, il monumento funebre di Vespasiano Aulari (1592), nonché il gruppo in terracotta policroma del Cristo deposto nel sepolcro (XVI secolo). In corrispondenza dell’arco trionfale si trova il crocifisso ligneo policromo attribuito a Baldino di Surso (1480). Gli stalli lignei del coro risalgono alla fine del XVI secolo. Merita un cenno il pregevolissimo affresco della sala capitolare, all’interno del chiostro, che rappresenta la grande “scena” della crocifissione. Fu scoperto solo nel 1923, sovrapposto a un altro di precedente fattura.
Giancarlo Patrucco
Foreste, santi e cavalieri
La storia di Marengo si perde nelle pieghe del tempo. Il borgo, infatti, ha origini molto antiche. Ma perché Marengo? Da quale anfratto della storia quel nome giunge fino a noi?
Come quasi sempre accade con gli etimi, le possibili risposte sono parecchie:
- una ci ricorda le vie Marenche, cioè quelle vie che sin dagli albori della civiltà venivano utilizzate come snodo principale tra la pianura e il mare ed erano quindi determinanti per l’economia e per il commercio. La piana di Marengo non si trovava forse alla confluenza strategica dei tre fiumi Po, Bormida e Tanaro? Dunque, non costituiva un ottimo punto di sosta per qualunque mercante dovesse transitare o far transitare merci da quelle parti?
- un’altra suppone che il nome Marengo derivi dall’antica popolazione dei Liguri Marici, stanziatasi in quella zona fino all’arrivo delle truppe romane che – come si sa – delle tribù dei Liguri fecero strage;
- una terza ipotesi è “di scuola”. Essa, infatti, si limita a far notare come il nome Marengo venga dal precedente Maringo o Marinco e il suffisso –ing presupponga un’origine germanica, probabilmente gota.
Noi siamo propensi a considerare valido il collegamento con le vie Marenche o Marinche perché il ragionamento relativo allo sviluppo dei traffici è estremamente efficace. Vorremmo sostituire ai Goti della terza ipotesi i Longobardi, che sempre di origine germanica erano. Però, stentiamo a vedere una connessione tra i Longobardi, famosi per l’attitudine guerriera, e un transito per mercanti. I Longobardi furono piuttosto cacciatori e dunque propensi a rimboschire il territorio in favore del loro svago preferito: la caccia. Così, la pianura padana progressivamente tornò a ricoprirsi di paludi e boschi. Una vasta Silva Urbe il cui eco, nei nomi delle aree boschive, è giunto sino ai giorni nostri: Frascaro, Frascarolo, Bosco Marengo, Rovereto, Tiglieto, solo per citarne alcuni, e la Fraschetta (o Fraschevera), come viene chiamata la zona intorno a Spinetta Marengo ancora oggi.

La Fraschetta nel XVI secolo
Galleria dei Musei Vaticani
Si narra che re Liutprando amasse trattenersi nella corte regia di Marengo, così come in zona esistono molte testimonianze legate alla famosa regina Teodolinda, la quale favorì la conversione del suo popolo ariano verso il cattolicesimo. Paolo Diacono, che dei Longobardi è lo storico di riferimento, narra come in uno dei suoi palazzi fossero affrescati i Longobardi: capelli rasati tutt’intorno alla fronte e lunghi fino alla bocca, divisi in due bande; vestiti ampi, di lino, con balze larghe e di vari colori; calzari di cuoio fermati da lacci, che lasciano scoperto l’alluce; calzoni rossicci di panno per andare a cavallo.
A Marengo si danno anche feste, si organizzano convivi, si celebrano matrimoni, magari forzando un po’ la mano alla storia e mettendo Marengo al centro di eventi svoltisi altrove. Così capita alle nozze di Teodolinda, vedova di Autari, con il duca di Torino Agilulfo, avvenute in realtà nell’oppidum di Laumello.
D’altronde, la zona di Marengo è sempre stata una miniera di aneddoti, a cominciare dal suo territorio: un’unica, immensa foresta, popolata di selvaggina di ogni genere e riservata alle battute di caccia dei reali. Immaginate, dunque, quanti incidenti, agguati, congiure, intrighi politici possano essersi consumati all’ombra di quelle piante, nei secoli. Come la ribellione dell’898, quando Adalberto il Ricco, marchese di Toscana, muove verso Pavia. Il re Lamberto è a caccia a Marengo allorché viene informato della spedizione, ma non esita a rivolgersi contro i nemici, piombando in mezzo a loro mentre sono ubriachi e addormentati e facendone strage
Ma la foresta, oltre la caccia, chiama a ben diversi episodi. Essa, oltre a dar ricovero a una ricca serie di animali, ospitava anche personaggi – diciamo così – un po’ particolari.
Nei dintorni di Villa del Foro, ad esempio, accanto al torrente Belbo viveva un certo Baudolino, di nobile famiglia longobarda. Egli era ricco, ma aveva preferito donare le sue ricchezze ai poveri per vivere da romito, in solitudine e in meditazione.
Pare che un giorno avesse allontanato le oche selvatiche che distruggevano i raccolti e, in un’altra occasione, chiamato dal vescovo, attraversò il Belbo sul suo mantello disteso a mo’ di barca. Una volta ancora poi, mentre il re Liutprando si trovava a caccia e suo nipote Aufaso veniva ferito gravemente, Liutprando mandò a cercare Baudolino affinché lo sanasse. Questi, però, annunciò ai messi del re che era ormai inutile perché Aufaso era già morto.
Baudolino si spense intorno al 740 venerato come un santo. Dapprima venne sepolto a Villa del Foro poi, sorta Alessandria e designato ad esserne patrono, le sue spoglie vennero traslate nella chiesa a lui dedicata intorno al 1180. O, almeno, così si dice.
Ornella Orbassano
Il Tesoro di Marengo: storie e misteri, in atti del Convegno di Alessandria, Palazzo del Monferrato, 30 marzo 2010 (a cura di Marica Venturino Gambari e Alberto Ballerino)
Sono un’insegnante di lettere classiche in pensione e ho avuto il compito di aprire il convegno non in veste di studiosa accademica, ma per esporre una testimonianza personale che, rievocando “storie e misteri” sul Tesoro di Marengo, consenta, se giudicata interessante, di stimolare ricerche e riaprire “prospettive”…
Fissati i limiti temporali tra il 6 aprile (venerdì santo) 1928, giorno presunto della scoperta del tesoro, e il 18 aprile 1936, data della sua consegna al Museo di Antichità di Torino, si tratta di ripercorrere gli eventi sviluppatasi intorno agli argenti in quegli otto anni. La monografia più completa rimane quella di Goffredo Bendinelli (Bendinelli 1937); ad essa le pubblicazioni successive si sono variamente ispirate e anch’io la utilizzerò come testo di riferimento.
La cascina Pederbona si trova vicino a Marengo, lungo la strada statale Alessandria-Genova. Nel 1928 ne era locatario il cav, Romualdo Tartara, che aveva già stipulato un compromesso di vendita … con i sette eredi del fu Giovanni Gabba. La parte della Pederbona spettante agli eredi Gabba, secondo Francesco Tartara fu effettivamente poi ceduta a Romualdo Tartara con atto del 29 agosto 1928 presso il notaio Badò di Alessandria. Sempre la stessa fonte sostiene che, nel citato compromesso, le parti avevano convenuto che l’atto di vendita avrebbe avuto forza giuridica dal giorno del compromesso stesso. Infatti il cav. Romualdo avviò subito importanti lavori. In realtà il passaggio di proprietà non era ancora avvenuto all’epoca della scoperta. Francesco Tartara era uno dei tre figli del cavalier Romualdo, un facoltoso e innovativo imprenditore agricolo e uomo d’affari, esponente di spicco della borghesia alessandrina con attività economico-finanziarie allora in espansione ….
Riassumerò la storia scomponendola in sequenze cronologiche e presentando ciascuna di esse secondo le due versioni di G. Bendinelli e F. Tartara..
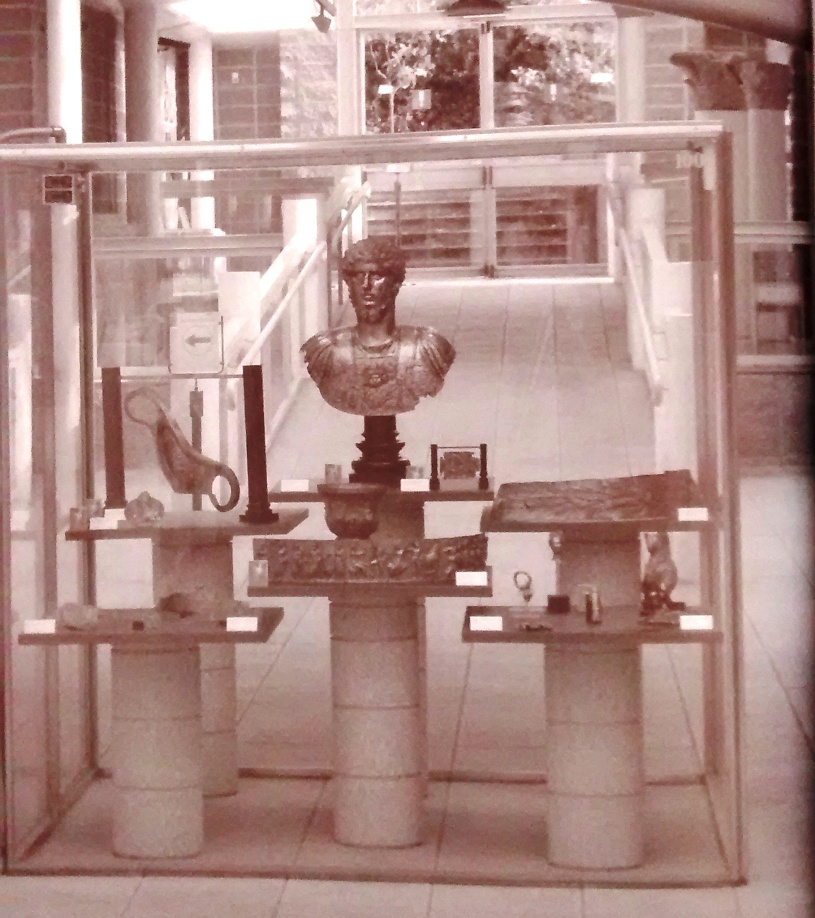 Il
Il
Il tesoro di Marengo esposto nel museo di antichità di Torino
Il ritrovamento
Il 6 aprile 1928 Francesco Tartara guida una squadra di operai in un lavoro di scasso a una profondità di 70-80 cm. Spunta il primo pezzo, il vaso a foglie di acanto … Nell’inaspettato strato di sabbia è impressa la forma di una cassa di legno ormai in briciole. I pezzi metallici vengono recuperati e ripuliti. In giornata Romualdo Tartara avverte il conte Zoppi, Reale Ispettore Onorario delle Antichità … In quel 6 aprile il complesso viene fotografato e il conte Zoppi lo lascia in consegna al Tartara.
Le settimane successive
Nel periodo successivo alla scoperta, alla Pederbona si verifica un via vai di curiosi, abitanti della zona, visitatori di prestigio istituzionale, intenditori, antiquari … Un certo signor Paternò di Spinetta, modesto trafficante d’arte, accompagna alla Pederbona Ferruccio Ildebrando Bossi, noto antiquario genovese, intraprendente e danaroso, che si offre come acquirente di alcuni pezzi per conto di una cliente francese facoltosa e attrezzata per l’espatrio clandestino. La cifra proposta è molto elevata e allettante, ma anche i Tartara all’epoca trattavano affari ad alto livello, infatti il cavaliere non accetta.
Commento
Nel corso del sopralluogo effettuato il 16 maggio con il prefetto di Alessandria e il conte Zoppi, il soprintendente Burocelli vede che il materiale è stato raccolto con molta cura da Romualdo Tartara. Assicura di aver invitato Tartara a far dono allo Stato della parte che gli spetta di diritto. Aggiunge che Tartara non si pronuncia.
Quindi chiede disposizioni per un eventuale ritiro degli oggetti presso il museo civico di Alessandria o presso il museo di antichità di Torino. In risposta il Ministro lo autorizza al trasporto del materiale al museo di Torino, con riserva di poterlo destinare a quello di Alessandria.
Il 31 maggio il conte Zoppi informa il conte Pellati che in serata Romualdo Tartara partirà per Roma con alcuni degli oggetti trovati per conoscerne il valore e sondare le intenzioni del governo riguardo alla legge. Se fino a quel momento Tartara aveva tenuto gli oggetti presso di sé disponendone, lo aveva fatto ignorando apertamente la legge … oppure la normativa magari un po’ ambigua si prestava a interpretazioni elastiche? Venutosi a trovare in una situazione straordinaria, è verosimile che abbia raccolto pareri, stime, consigli, consulenze legali … Si può supporre che da tutti questi elementi egli abbia tratto la convinzione di poter legittimamente disporre degli argenti come gioielli di famiglia ritrovati in soffitta.
4 giugno 1928: consegna degli argenti a Roma, allo Stato. Il materiale è raccolto in due valigie. Alla presenza di funzionari della direzione generale delle Antichità e Belle Arti, si procede all’atto di sequestro. Il peso lordo risulta di 26 Kg.
Il 20 aprile 1935 si giunge alla conclusione delle annose trattative per la stima del tesoro e il pagamento del premio. All’inizio del 1936 viene eseguito il restauro dei pezzi maggiori, il 10 aprile il ministro De Vecchi dispone l’assegnazione del tesoro a Torino … Il peso complessivo degli argenti risulta di 12,855 Kg.
La taccia di trafugatore viene consolidandosi in quegli anni secondo un percorso che parrebbe orchestrato per fare dei Tartara i capri espiatori in una vicenda non priva di ombre … In quel periodo la famiglia Tartara deve occuparsi di gravi problemi economici e legali. Si fa sentire, però, quando contesta il giudizio di “persona non dabbene” riferito allo scopritore e comparso in un opuscolo, ottenendone il ritiro. Tuttavia continua ad essere alimentato il sospetto che gli ammanchi non possano che imputarsi a Romualdo Tartara. Quale sia la loro entità, da quali prove si evincano, quando siano stati accertati nessuno dice. E se nessuna specifica iniziativa legale viene intrapresa nei confronti dei Tartara, la ragione potrebbe essere che non ci sono a loro carico elementi probanti oppure che qualche eminenza grigia non ritiene opportuno spingere indagini e sollecitare testimonianze rischiose. Forse proprio l’evanescenza delle prove ha creato la situazione ideale per chi, in quella insufficienza intrisa di sospetti, riponeva la garanzia della propria insospettabilità.
03. Leggende, assedi, stemmi
Introduzione
Per secoli ci siamo raccontati dell’imbroglio che il contadino Gagliaudo combina all’imperatore Barbarossa con la sua vacca riempita a bella posta di grano. Poi arriva un genio come Eco e alla leggenda di Gagliaudo, nel suo libro intitolato “Baudolino”, ritorna sulla questione a modo suo. C’è Gagliaudo, ma c’è pure Baudolino in prima fila, anche se la nostra tradizione non lo prevede,
Su Gagliaudo abbiamo scelto di farvi il racconto più tradizionale (e come potevamo diversamente, celebrando la storia della città) ma non ci siamo dimenticati di Baudolino, Così, per chiarire meglio la sua figura, abbiamo pensato di riportare le cose al loro posto. Chi era veramente Baudolino: un semplice romito che viveva poveramente nei boschi di Foro (oggi Villa del Foro), oppure vescovo di Alessandria e poi santo?
Santo lo dice il calendario, ma vescovo… Racconta esattamente come stanno le cose Francesco Gasparolo nel suo divertente pezzo: “Il vero Baudolino”. Rimane qualcosa da dire sugli attori veri di questo dramma: l’imperatore Barbarossa e il Libero Comune di Alessandria. Lo facciamo attraverso due testi tratti entrambi da wikipedia. E, per questa volta, gli umili risultano vincenti.
Giancarlo Patrucco
La leggenda di Gagliaudo
 La statua di Gagliaudo
La statua di Gagliaudo
L’assedio ha inizio nell’ottobre del 1174, ma già sei mesi dopo la città è stremata. Ai difensori di Alessandria sono rimasti solo venti chicchi di grano a testa mentre fuori dalle mura l’esercito dell’imperatore ha cibo a volontà.
Vive nel borgo un contadino, Gagliaudo Aulari, con la sua mucca. Era la sola che possedeva, ma era così magra e denutrita da far spavento dopo che, da quando la città era sotto assedio, non poteva più farla pascolare. Fuori, dall’alto delle mura, Gagliaudo guarda i cavalli dell’esercito di Barbarossa pascolare liberi, poi guarda la sua mucca morir di fame.
Mentre è intento a quei pensieri, viene messo al corrente del fatto che il Consiglio dei Sapienti ha in pratica deliberato di arrendersi. Allora Gagliaudo decide di bussare alla porta con il cappello in mano e la mucca al fianco, chiedendo di poter parlare. Non è certo stimato come pensatore, ma visto che nessun altro ha trovato soluzioni, il Consiglio pensa bene di ascoltare ciò che ha da dire. Un piano insomma, che consiste nel riempire la greppia della mucca per alcuni giorni, poi farla scappare mentre intorno le corrono dietro gridandole che la biada non è finita.
Mucca e contadino finiscono ben presto al cospetto dell’imperatore e continuano la manfrina del correre e rincorrere sempre urlando: il grano è la sua biada, ne abbiamo tanto che persino cani e porci lo mangiano, ma questa disgraziata è scappata perché stanca del grano voleva fieno e l’erba fresca del prato”.
Barbarossa esplode d’ira. Poi fa chiamare il macellaio e tagliare in due la vacca. Vedendo anche lui il grano di cui l’animale era pieno fino a scoppiare, si lascia nuovamente prendere dall’ira. Quindi, capendo che il tempo dell’assedio è sprecato, ordina di levare le tende. E’ il 12 aprile del 1175.
Francesco Gasparolo
San Baudolino. Patrono della diocesi alessandrina, Rivista di Storia, Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti, 1909
Fra le carte dell’avv. Bernardino Bobba da me possedute trovasi un curioso biglietto del prevosto parroco di Abbiategrasso del 1733 diretto al Sassi, bibliotecario dell’Ambrosiana, e la relativa risposta: tutto in copia. Questi due documenti sono assai interessanti e il primo, come ho detto, è curioso. Il buon parroco si lamenta che nella sua pieve alcuni parrocchiani (che certamente si volevan bene fra di loro come cani e gatti) si eran ficcato in testa di celebrare in quella parrocchia la festa di san Baudolino il l0 novembre sotto il titolo di patrono dei litiganti. A questa strana pretesa si spaventò il parroco e sembra che, per sedare i bollori di quei singolari devoti, abbia appunto richiesto notizie al Sassi, che le diede cortesemente.
I documenti sono questi:
“Il Sig.r D.re Bibliotecario Sassi vien cordialmente riverito dal Prevosto Pusteria d’Abbiategrasso e insieme supplicato a vedere nei martirologij antichi e moderni, ovvero negli eruditi monumenti del Bollandi o in altri menologi, se si ritrovi annotato sotto li l0 novembre Santo Baudolino Vescovo d’Alessandria, che tali uni pretendono di festeggiarlo in titolo di nuovo protettore de litiganti in questa mia pieve e sono pronti a litigare sino al giorno del giudizio per sostenere questa litigiosa festa. Mi farà gran favore farne diligenza, avendo io tutta la sicurezza nella sua ricca erudizione e copiosa lettura, e si compiacerà consegnare al Signor Bianchi oblato di San Sepolcro le sue diligenti annotazioni.”
Risposta:
“Che S. Baudolino fosse vescovo d’Alessandria è un solenne sproposito, perché questo S. Uomo visse a tempi di Luitprando, come attesta Paolo Diacono Lib. 6. Cap. 38 con queste parole: Huius Regis temporibus fuit in loco, cui forum nomen est iuxta f/uvium Tanarum Vir mirae Sanctitatis Baudolinus nomine, qui multis miraculis Christi gratia suffragante refusit, qui saepe futura praedixit, absentia quoque quasi praesentia nunciavii etc. e Alessandria è stata fabricata, com’è notissimo, a tempi di Alessandro III e di Federico Barbarossa.”
Filippo Ferrario, nel suo catalogo Sanctorum qui non sunt in Martyrologio Romano, alli l0 novembre dice: Alexandriae Statiellorum S. Baudolini Episcopi Urbis Patroni, e nelle note porta questa sol prova ex Tabu/. Eccles. A/exand., quae corpus habet, illumque uti Patronum praecipue veneratur. Questo, però, viene confermato ancor dall’Ughelli che nel tomo quarto, parlando dei vescovi d’Alessandria e di quella chiesa cattedrale, scrive: ibi S. Brandolinus honorifice requiescit, qui temporibus Luiiprandi Regis fertur vixisse, quem hoc tempore ea Civitas ut Divum Tutelarem veneratur, et colit.
Li Umiliati pretendono che questo santo fosse del loro Ordine, e ne fanno la festa alli l0 novembre con questo titolo: S. Baudolini Episcopi et Confessoris Ordinis humiliatorum, come si legge nel loro breviario stampato in Milano l’anno 1483 e nel missale degli Umiliati stampato l’anno 1504. Ancor questo però sembra lontanissimo dalla verità, perché dal tempo di Liutprando fino alla fondazione degli Umiliati vi passarono di mezzo quasi quatrocent’anni. Il Puricelli, nella cronaca manoscritta degli Umiliati, scrive la vita di questo santo, ma è di parere che non solo non sia stato dell’ordine degli Umiliati, ma nè meno vescovo o sacerdote, ma solo laico, e romito nella sua patria chiamata Foro, picciola terra presso il luogo dov’ora è fabricata Alessandria. Nell’anno 1600 fu stampata la vita di questo santo in Alessandria da Archangelo Caraccia, ma questa non mi è mai giunta alle mani.
Dico bene che non so che cosa abbia da fare questo santo coi litiganti, se non fosse forse perché, essendo egli stato acusato di delitto presso i vescovi d’Acqui e di Tortona, fu messa da Dio in palese la di lui innocenza con due miracoli; e veramente a passarla bene nelle estorsioni e cabale solite farsi ne forensi litigij non vi vuole meno di un miracolo.
AA. VV.
Federico Barbarossa, Wikipedia – l’enciclopedia libera.
Federico I Hohenstaufen, meglio noto come Federico Barbarossa salì al trono di Germania il 4 marzo 1152 e fu incoronato Imperatore il 18 giugno 1155.
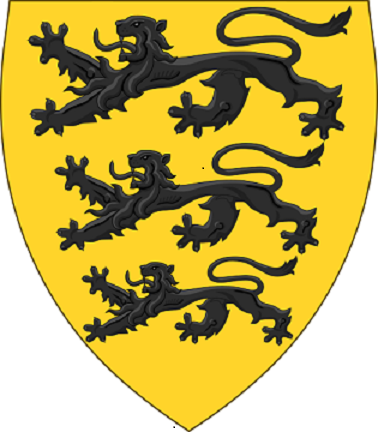
Lo stemma della Svevia
Nel giugno 1158, alla luce dei contrasti di natura ideologica col pontefice e dato che Milano mostrava di agire con una certa autonomia, provvedendo per esempio alla ricostruzione di Tortona, Federico decise per una discesa in Italia (la sua seconda). Sottomessa Brescia, dato inizio alla ricostruzione di Lodi, assediò Milano, obbligandola dopo un mese a sottoporre all’approvazione imperiale la nomina dei suoi consoli.
Milano intanto continuava a rifiutare le direttive imperiali. La lotta allora infuriò, con alterne fortune, su tutta la pianura lombarda, che fu devastata. Nella primavera del 1161, ricevuti rinforzi da Germania e Ungheria, Federico poté porre l’assedio alla città. Gli assediati resistettero con ostinazione per circa un anno: il 10 marzo 1162 Milano fu costretta alla resa e subito dopo cominciò la sua distruzione e i milanesi furono dispersi in quattro diverse località. Distrutte le mura di Brescia e Piacenza, che dovettero accettare i funzionari imperiali, Federico Barbarossa, all’apogeo della sua potenza, fece ritorno in Germania.
Nell’ottobre 1163 Federico scese nuovamente in Italia con un piccolo esercito perché già incalzava la riscossa dei Comuni italiani. Verona, Padova e Vicenza si sollevarono, in ribellione congiunta, e rifiutarono le offerte di pace dell’imperatore, che non disponeva di forze sufficienti per domarle. L’imperatore, anche a causa di una malattia, dovette tornare in patria: la discesa di Federico era stata breve e si era conclusa quindi con un nulla di fatto.
L’assenza dell’imperatore rese più facile ai lombardi di pervenire a un accordo per organizzare una resistenza comune. Nelle città scoppiavano tumulti e a Bologna venne ucciso il podestà imperiale. Federico doveva riconquistare l’Italia. Formò un possente esercito e a ottobre 1166 partì e scese, per la quarta volta, in Italia. A novembre era in Lombardia dove, alla dieta di Lodi, si rese conto che l’ostilità era maggiore che nel passato, le città filo-imperiali erano molto fredde, Pisa e Genova erano in disaccordo. Federico avrebbe voluto dirigersi subito su Roma, ma dovette restare in Lombardia combattendo nelle zone di Bergamo e Brescia, poi si diresse su Bologna da cui si fece consegnare degli ostaggi, quindi, inviata a Roma una parte delle truppe sotto il comando di Rainaldo di Dassel, marciò su Ancona che oppose una resistenza ostinata. Rainaldo stava occupando la campagna romana ed era arrivato a Tuscolo con forze esigue quando i romani gli marciarono contro ma, il 29 maggio 1167, nella battaglia di Prata Porci subirono una disfatta perché nel frattempo erano arrivate le truppe dell’arcivescovo di Magonza che presero i Romani tra due fuochi. Il 24 luglio giunse anche l’imperatore, su Roma fu sferrato un attacco massiccio e il papa Alessandro, il 29, fuggì a Benevento coi pochi cardinali a lui fedeli. Federico era padrone di Roma.
Ma, pochi giorni dopo, i suoi soldati cominciarono a morire colpiti da febbri, probabilmente malariche. Allora decise di riparare a Pavia, insieme a Como l’unica città rimastagli fedele, lasciando lungo la via una scia di morti. Dopodiché, con l’appoggio del marchese di Monferrato Guglielmo V il Vecchio, gli fu possibile tornare in Germania passando da Susa, che gli si ribellò e da cui dovette fuggire.
La Lega nel frattempo diventava sempre più potente, le città e perfino i signori feudali che vi aderivano erano sempre più numerosi e ora il regno di Sicilia e perfino l’impero bizantino l’appoggiavano apertamente. Mentre Milano era stata ricostruita molto rapidamente, per neutralizzare la possibilità di intervento da parte di Pavia e del marchese del Monferrato, la Lega fondò, alla confluenza del Bormida nel Tanaro, una nuova città chiamata Alessandria in onore del papa (1168). Alla fine, anche Pavia e il marchesato del Monferrato aderirono alla Lega.
Nel 1174, risolti i problemi in Germania, Federico radunò nuovamente un grosso esercito e scese per la quinta volta in Italia. Cominciò la sua campagna nel settembre 1174 vendicandosi di Susa, che distrusse, poi prese Asti che si era arresa, così come le città di Alba, Acqui, Pavia e Como. Mosse contro Alessandria che resistette a un assedio di ben 7 mesi, interrotto solo dopo che gli assediati, con una sortita, avevano distrutto incendiandole le migliori macchine da guerra di Federico.

La battaglia di Legnano
Dopo aver attraversato i Balcani Federico, avvicinandosi ai domini dell’imperatore bizantino Isacco II, inviò ambasciatori per concordare il passaggio in Anatolia. Ma Isacco, che temeva i Latini e si era accordato col Saladino, imprigionò gli ambasciatori. Allora Federico inviò un messaggio al figlio, Enrico VI, che con la flotta fornita dalle repubbliche marinare e col permesso del papa attaccasse Costantinopoli mentre lui si avviava verso Adrianopoli.
Allora Isacco venne a patti, così nel febbraio del 1190 fu firmato il trattato di Adrianopoli che permise alle truppe dell’imperatore Federico di attraversare l’Ellesponto. La traversata avvenne nel mese di marzo e, giunti in Asia Minore, dopo aver ricevuto i dovuti approvvigionamenti cominciarono la marcia verso sud, dove furono sottoposti a continui attacchi di bande di Selgiuchidi e furono tagliati i rifornimenti. Ridotto alla fame, l’esercito tedesco attaccò il sultano obbligandolo a mantenere gli impegni presi: concedere loro libertà di transito, rifornirli dei necessari approvvigionamenti e poi, con l’aiuto di guide armene, guidarli attraverso il Tauro sino sulle sponde del fiume Saleph in prossimità della Terra Santa. Ma Federico affogò durante il guado del fiume, il 10 giugno 1190, causando la dispersione dell’esercito imperiale.
Le esatte circostanze della morte di Federico nel fiume sono sconosciute. È ipotizzabile che l’anziano imperatore sia stato disarcionato da cavallo oppure che, stanco della marcia attraverso i monti e oppresso dalla calura, abbia voluto rinfrescarsi e lo shock dovuto all’acqua fredda gli abbia causato un arresto cardiaco, oppure che, appesantito dalla sua stessa armatura e fiaccato dall’intensa calura del giugno in Anatolia, Federico I, data anche l’età, non abbia resistito all’impeto della corrente. Così annegò nelle acque che a malapena arrivavano ai fianchi. Il peso dell’armatura di quel giorno, progettata per essere la più leggera possibile, fu tale comunque da trascinare con sé un uomo in salute in acque poco profonde.
La morte di Federico gettò il suo esercito nel caos. Senza comandante, in preda al panico e attaccati da tutti i lati dai turchi, molti tedeschi furono uccisi o disertarono. Il figlio del Barbarossa proseguì con i soldati rimasti con l’obiettivo di dar sepoltura all’imperatore a Gerusalemme, ma gli sforzi per conservare il cadavere utilizzando l’aceto fallirono. Quindi le spoglie di Federico Barbarossa furono seppellite nella chiesa di san Pietro in Antiochia di Siria, le ossa nella cattedrale di Tiro e il cuore e gli organi interni a Tarso. Solo 5.000 soldati, una piccola frazione delle forze iniziali, arrivarono ad Acri verso la fine del 1190.
AA. VV.
Lo stemma di Alessandria, Wikipedia – l’enciclopedia libera
Lo stemma di Alessandria è antico quasi quanto la sua città. Fu ideato nel 1175 per ricordare la fine dell’assedio di Barbarossa. Lo stemma è sorretto da due angeli ai cui piedi è teso un nastro con la scritta: “Deprimit elatos levat Alexandria stratos” (“Alessandria umilia i superbi ed eleva gli umili”). Pare che questo motto sia stato attribuito da papa Alessandro III alla città che aveva saputo sconfiggere il terribile e superbo Barbarossa.
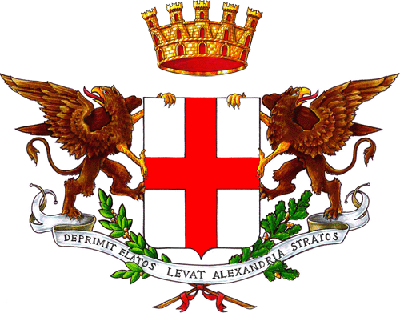
In origine lo scudo argenteo dello stemma era sormontato da una corona principesca, cambiata poi in corona turrita (con cinque merli di torri guelfe, ossia a coda di rondine). Nel 1575 al posto degli angeli vengono disegnati due grifoni (animali mitologici: aquile dalla cintola in su, leoni dalla cintola in giù), ma nel 1600 sono restaurati gli angeli fino al 1811, quando Napoleone fa disegnare uno stemma del tutto diverso (conservato ancora oggi nel museo di via Tripoli) che resta fino al 1814. Da questa data lo stemma di Alessandria torna a essere quello originario, con i grifoni al posto degli angeli e la corona turrita che sormonta lo scudo.
04. L’organizzazione comunale dagli inizi
Introduzione
Si dice sempre che le guerre non risolvono le questioni e anche la lotta cruenta tra le città della Lega e l’imperatore Federico Barbarossa non risolve il punto cruciale: la civitas, cioè il riconoscimento all’autodeterminazione senza con ciò mettere in discussione l’autorità dell’impero.
Alessandria ha ancor meno possibilità degli altri Comuni della Lega perché resta senza riconoscimento imperiale, perché ha opposto resistenza in armi, perché si è permessa di autonominarsi con il nome di uno di quelli che il Barbarossa ritiene come suo peggior nemico.
Per arrivare all’agognata civitas – ci racconta Cognasso – la città non esita ad attirare il papa in un inganno, un imbroglio, dandosi interamente al Sacro Soglio. I tempi si fanno lunghi, il papa si barcamena finché dà il suo consenso solo dopo che la città ha resistito all’assedio. Ma, prima di arrivare alla civitas, anche l’imperatore prende tempo – diciamo così – il tempo di consumare le sue vendette.
Di tempo ha bisogno anche la città per realizzarsi come organismo unitario. Ogni borgo che la compone, infatti, è aduso a pensare per sé, come ci racconta Gasparolo del borgo di Bergoglio che ha sempre avuto una casa comunale entro le sue mura. Così ognuno segue le proprie logiche e le proprie convenienze, conducendo trattative sparse con le altre realtà del territorio.
Ma ci sono forze interne che intendono intraprendere un cammino più unitario, costruendo patti e convenzioni, accordi e alleanze con molte realtà limitrofe, come ci dice Lanzavecchia, vuoi per via della necessità di giungere a un Comune più coeso, vuoi perché in un Comune più coeso si aprono spazi di manovra in cui le famiglie più ricche possono infilarsi per salire la scala del potere. Un elenco dei nomi dei maggiorenti si può ricavare da Carlo–A. Valle nella sua “Storia di Alessandria”.
Tendono a formare unità e omogeneità di comportamenti anche le Consuetudini e gli Statuti, di cui ci parla Mario Viora. Tutto bene, ma sia le Consuetudini che gli Statuti sono comunque viziati dalle preferenze accordate ai mariti e ai figli nei confronti delle mogli e delle madri. D’altronde, per la parità di genere non siamo forse ancora qui oggi, con una legislazione affatto soddisfacente?
Rimane infine da constatare che il percorso di riduzione degli spazi di scelta collettiva si fa sempre più stringente, finché i Liberi Comuni implodono consegnandosi ai protagonisti che tengono in mano il potere come capi delle nuove Signorie. Milano apre le porte alla scalata dei Visconti nel 1277, cosi come Asti e Alessandria rispettivamente nel 1342 e nel 1348.
In questo modo il periodo dei Liberi Comuni transita in quello delle Signorie.
Francesco Cognasso
La fondazione di Alessandria, Rivista di Storia, Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti, 1969/70
(Alessandria e il papa)
Alessandria era nata extra lege, in contrasto con l’imperatore, con la feudalità, e nessuno poteva dare la sanzione giuridica di quel che era stato fatto. Ma la base giuridica i fondatori di Alessandria ritrovarono in un’altra violazione del sistema imperiale: ricorsero alla Donazione di Costantino, dagli imperatori detestata e contestata. Non aveva il papa successore di papa Silvestro, in virtù di quell’atto leggendario ma ben vivo nella tradizione curiale romana e ben valutato come realtà storica, piena capacità di fare leggi e decreti al di sopra dell’imperatore?

Papa Alessandro III
Due consoli di Alessandria, nel gennaio del 1170, erano in ginocchio a Benevento davanti ad Alessandro III. E’ probabile che di questo si parlasse nel convegno dei Rettori della Lega del 24 ottobre 1169, tenutosi a Cremona e al quale fu presente Guglielmo di Alessandria come rettore o come console.
Li ricevette il papa in solenne concistoro. Lo circondavano i cardinali della sua obbedienza: il vescovo di Porto, dieci cardinali preti, cinque cardinali diaconi, i dignitari della corte.
I due consoli, Ruffino Bianco e Guglielmo di Bergamasco, parlarono a nome dei colleghi e di tutto il popolo di Alessandria. E dissero che Alessandria avevano acclamato la loro città in suo onore e che essa ora gli offrivano perché fosse sua e di san Pietro. E per questo era stato acquistato nel recinto cittadino un terreno allodiale libero da qualsiasi legame feudale e che era stato acquistato con denaro offerto da tutto il popolo cd ivi sarebbe stata eretta la chiesa madre degli alessandrini dedicata all’apostolo romano conclamato, perché ignorate dovevano essere invece le chiese delle varie corti legate alle decime, ai tributi verso feudatari, monasteri, capitoli.
Davanti al papa non vi erano nè gamondiesi, nè bergogliesi o marencani o rovoretani, ma alessandrini distinti nelle tre classi dei cavalieri, dei mercatori, dei possessori. Non si poteva pensare che a Benevento andassero dei rappresentanti delle vecchie corti regie: ingiuria all’imperatore e illegalità. Militi, mercatori, possessori rappresentavano la nuova città legale che si impegnava a pagare al suo signore il censo dovuto, tre denari per famiglia quelli che appartenevano alle tre classi, un denaro quelli dell’infimo popolo escluso dalla città legale.
I rappresentanti di Alessandria per fustes, – una verghetta ciascuno (erano due) – offrirono al papa la proprietà dell’allodio e della chiesa futura, poi giurarono fedeltà, misero le loro mani fra le mani del papa a significare il vincolo di vassallaggio che ora stringeva il popolo di Alessandria al suo Signore, giurarono che ogni tre anni nella rinnovazione dei consoli il popolo avrebbe rinnovato il giuramento. Era dunque diventata Alessandria una signoria feudale del papa. Si era giuridicamente usciti dall’impero di Federico. Non ci venne conservata la risposta di Alessandro III all’offerta dei consoli. Certo è che essa fu accettata e il censo alessandrino venne registrato nei registri della curia romana, dove nulla si dimentica.
Libera era dunque Alessandria, ma la sua Libertas papalis era chiusa nella cerchia delle sue mura. Fuori vi erano gli agri fisci che la strozzavano e l’affamavano. Come vivere senza suburbio, senza comitato, senza distretto, senza campagna su cui si avesse giurisdizione, senza diocesi e vescovo da riconoscere?
La loro città doveva avere quella dignità che si credeva dover spettare a una città perfetta, come si diceva a Tortona, doveva avere l’indipendenza religiosa dalle altre città: una diocesi, un vescovo, un capitolo, una cattedra. Innocenzo III, in una sua lettera tanti anni dopo, ricordava la bolla di Alessandro III per l’istituzione della diocesi di Alessandria, creata per le preghiere del clero e del popolo di Alessandria, appoggiati dall’arcivescovo di Milano, Galdino, dai consoli di Milano e dai Rettori della Società. I Rettori non si erano dunque disinteressati delle vicende della nuova città.
La bolla di erezione della diocesi tardò però qualche anno. Solo il 30 gennaio del 1177 Alessandro III scriveva ai suoi « diletti figli clerici della chiesa di Alessandria» e diceva che, « per la novità e la necessità della cosa», non essendovi stata anteriormente nessuna elezione, doveva provvedere, essendo presente il nunzio della chiesa di Milano, da cui Alessandria aveva a dipendere, alla elezione del vescovo di sua autorità «e noi provvediamo per la nostra autorità apostolica ». Questo suo provvedimento non doveva portare pregiudizio al clero di Alessandria; morendo quegli che egli aveva eletto, il clero doveva eleggere liberamente i suoi vescovi futuri, come fanno i canonici delle altre chiese cattedrali dipendenti da Milano.
(Alessandria e l’imperatore)
L’assedio di Alessandria aveva creato gravi preoccupazioni. Gli alessandrini, legandosi con il papa, avevano determinato un conflitto con l’imperatore dal quale non potevano uscirne fino a che fosse perdurato lo scisma. E le città della Lega come avrebbero potuto aiutarli senza venire meno alla politica tradizionale di fedeltà verso l’impero? Così la loro azione militare e il loro intervento ad Alessandria erano stati ispirati a prudenza e si erano affrettati a entrare nel progetto di un’intesa. Ora Alessandria aveva rivelato tutta la fralezza della sua situazione.
Se l’imperatore fons iuris ne dichiarava la illegalità della sua origine, l’impossibilità per lui di riconoscerne l’esistenza, la Società delle città di Lombardia avrebbe dovuto abbandonarla al suo destino, se avessero voluto mantenere fede alle dichiarazioni di lealtà verso l’impero.
Non abbiamo modo di poter seguire quelle discussioni che dovettero avvenire fra i Rettori circa tale problema imbarazzante dove l’interesse e l’onore si trovavano a contrasto. Vi furono dissidi fra le città? L’atteggiamento di Tortona è da ricondurre alla questione di Alessandria? E così è da pensare per Asti? Altre città come Milano, Brescia, Piacenza probabilmente dimostrarono presto la loro simpatia per Alessandria.
 |
L’imperatore Federico Barbarossa
E quando si prese a discutere a tal proposito? Non sappiamo come e quando la questione di Alessandria sia stata dalle trattative di Piacenza portata al palazzo di Norimberga e subito sottoposta all’imperatore. E là la soluzione fu trovata. Di chi fu il merito? Di un sottile leguleio venuto dalla Curia papale? O di qualche giurista della scuola di Rinaldo di Dassel?
Soluzione davvero fine: l’imperatore avrebbe egli creato una sua città, la città dell’imperatore, Cesarea, che sostituisse quella del Papa, Alessandria. L’avrebbe creata anch’esso fra Tanaro e Bormida, vi avrebbe riunito gli uomini dei sette luoghi: Gamondio, Marengo, Bergoglio, Rovoreto,
Solero, Foro, Oviglio e le quaranta famiglie di Quargnento. Di Alessandria più non si doveva parlare, non esisteva più, per Federico non era mai esistita.
La costituzione imperiale del 14 marzo 1183, data dal palazzo imperiale di Norimberga, stabilì le modalità della fondazione della nuova città.
Nel giorno fissato, tutti gli abitanti della città abitata collocata sulla riva del Tanaro, uomini e donne, ne sarebbero usciti e sarebbero rimasti fuori sino a che fosse venuto un nunzio dell’imperatore ad accoglierli, a introdurli nella città e a consegnare questa ad essi in nome dell’imperatore. L’imperatore – avrebbe annunziato il nunzio – fonda questa città dai sette luoghi, Gamondio, Marengo, Bergoglio, Rovoreto, Solero, Foro, Oviglio e le quaranta famiglie di Quargnento, e le assegna il nome di Cesarea.
La situazione di Alessandria era dunque regolata. Scomparso il nome del fondatore, scomparso ogni ricordo dell’assedio del 1174. La situazione di Cesarea poteva essere di modello per tutte le altre città della Società di Lombardia che accettassero quella riconciliazione con l’imperatore che era sottomissione giuridica e adesione implicita all’organizzazione del regno d’Italia progettata ora da Federico.
Francesco Gasparolo
Il palazzo comunale di Bergoglio, Rivista di Storia, Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti, 1911
Il palazzo comunale di Bergolio, uno dei punti più curiosi della storia alessandrina a cui nessuno finora, che io sappia, ha dedicato una speciale attenzione (che assai meriterebbe), è quello dell’amministrazione particolare del quartiere di Bergolio. Questo quartiere, intorno a cui F. Graf ha dichiarato, non si sa il perché, essere più facili le notizie di qualsiasi altro quartiere della città, ha invece una storia specialissima, diversa dalla storia degli altri tre. Una storia, che io credo sia più difficile di quella degli altri, sebbene, forse, non di tanta importanza.

In Bergolio si è conservata più che altrove una marcata differenza di regime locale distinta da quella del Comune alessandrino: si intende cioè circa molte parti di diritto amministrativo. Là eravi un palazzo speciale del governo, dirò così, cantonale; palazzo che ebbe molte vicissitudini. Ivi si radunavano gli anziani e i consiglieri del Comune di Bergolio.
Esisteva pure in Bergolio, per donazione fattane dai Guasco, un palatium vetus a cui si riferisce il seguente documento: ” Essendo stato representato come il Palazzo uecchio datto in pagamento alla Città dal Sig. Giulio Guasco et dalli heredi del Sig. Ottauiano Guasco, ha bisogno di reparatione a fine possi seruire, non mancandoli solo che alcune asse, et far acomodar alcuni solari rotti, et retecharlo di presente, poiche acomodato che sia li potrà alogiar qualsiuoglia officiale, che perciò hanno deputato il Sig. Capitano francesco Ghilino di prouisione et il Sig. Gio. Balosto, quali si pregano insieme con unò de Raggionati a uisitar ditto Palazzo, et con maestri da muro per ueder le cose necessarie per ripararlo et saper che spesa ui anderà, che poi fatta del tutto rellatione si prouederà.»
Questo palazzo vecchio, citato pure in altri luoghi e che veniva dato in affitto, pochi anni dopo minacciava rovina. Perciò, essendosi presentato un compratore, la Provvisione ordinò la perizia per poterne far la vendita.
Renato Lanzavecchia
Alessandria dalle origini agli inizi del sec. XX, Omnia Media Edizioni
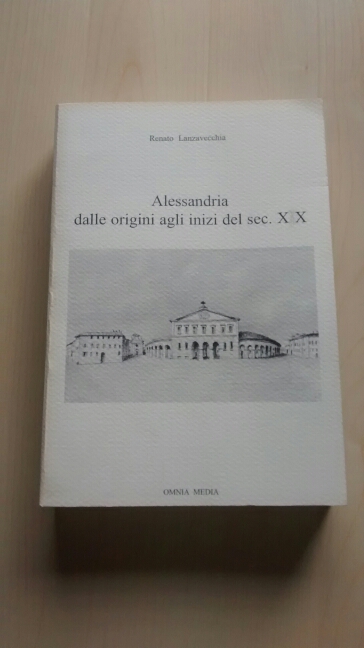
La nuova città, appena sorta, aveva configurato “una sua propria area giurisdizionale, politica, economica, sociale culturale, ecclesiastica, di forte espansione territoriale, di assoggettamento dei villaggi viciniori alla sua autorità. Consolidò castelli e borghi fortificati per sostenere la sua penetrazione antifeudale e difendere posizioni di particolare importanza strategica; soprattutto le vie commerciali che attraversavano il suo territorio. Strinse patti e convenzioni di reciproca difesa con molte terre limitrofe, accordi temporanei e alleanze: il 13 giugno 1178 fu stipulato l’atto di concordia con il marchese di Monferrato, il 10 novembre 1180 pace con i marchesi Del Bosco che danno “in feudum statum terre et civitatis castrum et villam Ponzani cum tota eius curte, et Marenzana similiter”; la concordia homimum de Frixionaria et Alexandrinorum (4 novembre 1179), Ianuensium et Alexandrinorum (5 marzo 1181, con esecuzione dei dazi come pattuito ab antiquo.) Genova aveva contribuito alla fondazione di Alessandria concedendo 1.000 soldi d’oro; hominum de Cavriata et Alexandrinorum (10 luglio 1183), illorum de Mirbello et Alexandrinorum (20 marzo 1184), hominum de Maxio et Alexandrinorum (26 settembre 1190), illorum de Rivalta et Alexandrinorum (26 settembre 1190), illorum de Rivalta et Alexandrinorum (20 ottobre 1191), de Lelma (21 febbraio 1198), illorum de Urba (26 maggio 1198), marchionum de Occimiano (5 luglio 1198), hominum Quargnenti et Alexandrinorum (23 febbraio 1200), concordia domini Otonis de Carreto (8 marzo 1202), domini Vermi de Ceva (24 aprile 1202), domini Punxii de Pulzono (20 agosto 1202), hominum de Montaldo et Alexandrinorum (9 gennaio 1202), Albensium et Alexandrinorum (3 settembre 1203), Alexandrinorum et Astensium (20 febbraio 1203), de investitura Castri Retorti (16 settembre 1203), Carpenti superioris, minoris (17 settembre 1203, de Casis Novis de Sezaina, de Castri Novi (17 settembre 1203), Castri Sexadii (18 settembre 1203), concordia hominum Terdonesium (30 marzo 1203), investitura Rivaltae (9 dicembre 1217), donatio Roche Vallis Urbarum (25 agosto 1273). E questi sono stati gli interventi di maggior rilievo.
Ancora sul finire del XIII secolo la politica del comune di Alessandria, nel mirare a conquiste e a espansioni, indirizzò anche i suoi sforzi, alternativamente, a due punti: combattere il controllo effettivo imperiale delle autonomie comunali – Alessandria fu alleata di Piacenza contro Parma (1194) e di Milano contro Pavia (1211) – e contro i residui del vecchio mondo feudale, alleata di Genova contro il marchese di Incisa (1188), di Asti contro il marchese Lancia (acquisizione del castello di Castagnole, 1198), convenzione con Mondovì (1236). Certo, fu una politica eccessivamente particolaristica. Le alleanze locali fra comuni limitrofi che si crearono e si spensero furono molte e spesso provocarono soltanto contese fra città vicine per questioni di confine: la vita politica si svolgeva attraverso continui tentativi di nuovi raggruppamenti territoriali. Ogni Comune era un organismo politico del tutto indipendente.
Carlo A-Valle
Storia di Alessandria, Tipografia Falletti, 1855

Famiglie nobili del popolo (che partecipavano al Consiglio e all’Anzianato)
Vespa, Perboni, Granari, Stortiglioni, Aulari, Clari, Varzi, Milani, Basgiazzi, Santi, Pettenari, Ghilini, Ardizzoni, Peragioli, Cacciaguerra, Bottazzi, Frascara, Muzio, Falameri, Pietra, Gambaruti, Beineri, Filiberti, Tacconi, Borghi, Leggieri, Forti, Felizzani, Dellavalle, Cermelli, Da Po, Mazzi, Coppa, Peri, Mantelli, Arnuzzi, Arobba, Bobutti, Panza.
Famiglie nobili del popolo (che partecipavano solo al Consiglio)
Trotti, Lanzavecchia, Malvicini, Merlani, Canefri, Castellani, Baratta, Bagliani, Boidi, Martina, Spandonari, Angelleri, Rossi, Gambarini, Calcamuggi, lnverardi, Inviziati, Delpozzo. Arecchi, Marchelli, Bianchi, Guastavini, Sacchi, Guaschi, Squarzafichi, Colli, Scribani, Nani, Porcelli, Accorneri, Cassagnì, Sardi, Regis.
Famiglie che vennero da Quargnento
i Sacchi – i Cuttica – i Guarachi – i Guasta
Famiglie che vennero da Solero
i Guaschi – gli Angelleri – i Grattarola – i Villavecchia – i Gallia
Famiglie che vennero da Oviglio
i Delpozzo – i Lanzavecchia – i Rossi – i Gorreta
Famiglie che vennero da Gamondio o Castellazzo
i Trotti – i Boidi – i Farra i Picchi – i Canteri – i Lamborizi – i Mussa – i Moccagatta – i Conti – gli Astuti – i Prati – i Milani – i Trucchi – gli Spandonari – i Negri – i Ferrari – i Panizza – i Rivalta. – i Longhi – i Pellizzoni – i Barberi
Famiglie che vennero da Marengo
i Gambarini
Famiglie che vennero da Milano
i Belloni – i Carelli – i Gonfalonieri – i Grassi – i Litta – i Mantelli – i Sacchi – gli Scotti – i Colli – gli Ardizzoni – i Piatti – i Braschi – i Botta – i Bossi – i Ghilini
Famiglie che vennero da Genova
i Bianchi – i Borghi – i Bottazzi – i Ferrari – i Grilli – i Muzii – i Porzelli – gli Squarzafìchi
Mario E. Viora
Consuetudini e Statuti di Alessandria, Rivista di Storia, Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti, 1969/70
Alessandria, nel corso della sua storia otto volte secolare, conobbe due complessi normativi importanti: le famose Consuetudini del 1179 e gli Statuti. Le Consuetudini rappresentano la prima affermazione normativa autonoma della città da poco nata; qui sta la loro grande importanza.
Il testo originario non ci è pervenuto. Abbiamo però notizia, da un verbale del consiglio della città datato 10 gennaio 1538, che in quell’anno, essendo andato perduto il testo, si provvide a ricostruirlo valendosi di copie che erano in circolazione. Il testo ricostruito nel 1538 fu poi nel 1547 stampato dal Moscheni in appendice alla edizione degli Statuti da lui pubblicata.

Il testo consuetudinario non si presenta come un corpo organico e coerente: si tratta di disposizioni disparate, relative a materie le più diverse che si susseguono senza alcun ordine apparente. In esse si possono ravvisare analogie, talvolta identità con le norme che ci risultano vigenti in altri luoghi del territorio lombardo-tosco. Il che è più che naturale perché Alessandria sorse in territorio lombardo e fu dalle origini legata a Milano pel trattato della Lega.
Non è possibile fare qui un esame approfondito delle Consuetudini e, tuttavia, un cenno sembra indispensabile per poterne trarre alcune indicazioni di carattere generale.
La Cons. I sancisce che le donne possono liberamente testare sui propri beni parafernali. La norma è analoga ad altre del territorio lombardo. Nel caso di successione intestata, nei beni parafernali della donna defunta succedono in primo luogo i discendenti, indi gli ascendenti con i collaterali (fratelli e sorelle germani della donna, prima degli uterini o consanguinei); in mancanza dei predetti il marito superstite.
Nella Cons. II si stabilisce che la moglie, nel caso di morte del marito, può avere per antefatto solo 5 soldi per ogni libbra che avesse portato in dote al marito.
La Cons. III stabilisce che la madre succede al figlio defunto solo quando mancano i fratelli germani o consanguinei del de cuius o i loro figli o lo zio paterno. In presenza di fratelli uterini del de cuius, la madre divide l’eredità con questi in quota pari. Si tratta di disposizioni ispirate al favor della mascolinità, frequenti nel territorio lombardo e anche altrove, comunque certamente antiche.
Nella Cons. V si pongono misure restrittive per quanto concerne i prestiti ai figli di famiglia, ai quali praticamente si nega efficacia.
La Cons. VI, ispirata al favor agnationis, così diffuso in Italia fin da antico tempo, stabilisce che nella successione ab intestato gli agnati prevalgono sui cognati. Lo stesso troviamo nelle Consuetudini di Milano e negli Statuti di Monza.
Lo stesso favore dell’agnazione ispira la Consuetudine VII: la donna dotata (né si parla di congruità della dote) è esclusa dalla successione paterna e fraterna, salvo che il padre o fratello le abbiano fatto un legato.
La Cons. VIII introduce un limite ai legati che il marito può fare alla moglie: non più di 20 solidi. Anche qui norme consimili si ritrovano in altri testi lombardi.
La Cons. IX disciplina il retratto agnatizio, il quale compete al congiunto prossimo della parentela dalla quale provenivano i beni alienati.
La Cons. XII stabilisce che, nel caso di premorienza della moglie, il marito in mancanza di figli lucra l’intera dote mentre, se esistono figli, quelli e non il marito succedono, fermo l’usufrutto paterno. Anche questa è norma molto comune in tutto il territorio lombardo-tosco.
La Cons. XXII contiene l’elenco degli otto luoghi dai quali fu costruita Alessandria: Gamondio, Marengo, Rovereto, Berfoglio, Quargnento, Solero, Foro e Oviglio. In definitiva pare dunque che la maggior parte delle Consuetudini sia da riferirsi a tempi anteriori al 1179. Eccetto due, che nacquero nel sobborgo di Marengo e vennero estese a tutto il territorio, delle altre è pensabile che fossero già precedentemente comuni all’intera giurisdizione alessandrina.
Nel complesso, si ritrovano come principi ispiratori di varie norme quel favor masculinitatis e quel favor agnationis, che sono così diffusi in Italia già nell’età antecedente, sicché rivelano di essere pienamente intonati allo stadio del diritto maturatosi nel secolo XII. Non mancano però anche le «specie» assolutamente locali. Molto interessanti gli spiragli che talune consuetudini aprono sulla società e sulle economie locali di quel tempo.
Gli Statuti ci sono pervenuti nell’edizione a stampa curata dal Moscheni l’anno 1547. Codici manoscritti di essi esistettero certamente fino alla metà del ‘500, come risulta dalla lettera dedicatoria del podestà Curzio, posta a capo della edizione a stampa, e anche da varie citazioni dell’annalista Schiavina morto nel 1616; ma non sono giunti sino a noi e quindi l’unica fonte di cognizione degli Statuti rimane l’edizione del Moscheni.
Stando a indicazioni contenute negli Statuti stessi, la consolidazione e cioè il riordino in unico testo del materiale statutario fu fatta l’anno 1297 a iniziativa degli anziani del popolo, ossia dei reggitori del Comune, e ad opera dei giureconsulti a ciò deputati.
In qualche caso è possibile determinare l’antichità del materiale legislativo poiché parecchi capitoli conservano la data di emissione, mentre altri presentano indicazioni che consentono di fissarne l’età. Per la maggior parte appartengono al secolo XIII; il più antico reca la data del 1200.
È chiaro che non si può qui procedere a una disamina del contenuto degli Statuti. Molto superficialmente si può solo dire che gli Statuti sono divisi in nove libri: il primo libro si riferisce, grosso modo, al diritto pubblico; il secondo libro (comincia a pag. XLIX, anche se non vi è alcuna
indicazione di inizio) si riferisce principalmente al diritto penale; il terzo libro (comincia a pag. CIII) contiene disposizioni di procedura civile; il quarto libro comincia a pag. CXXII ed è intitolato: De rebus et juribus communis inquirendis. Il quinto libro (comincia a pag. CXLVI) si riferisce prevalentemente alla materia ecclesiastica. Il sesto libro (comincia a pag. CLXXIII) tratta materia economica. Il settimo libro (comincia a pag. CLXXXVIII) disciplina oneri pertinenti al Comune. Il libro ottavo (comincia a pagina CCLVI) si riferisce a varie materie, in particolare all’attività del giudice della Ferrazza. L’ultimo libro, il nono, (comincia a pag. CCCIX), si riferisce a materie disparate e contiene anche statuti particolari relativi ai pedaggi, alla irrigazione dei campi, ecc…
La edizione per le stampe, come detto sopra, fu curata dal podestà Francesco Girolamo Curzio che la dedicò al presidente del senato di Milano Giacomo Filippo Sacco il quale era di famiglia alessandrina. I maestri stampatori Moscheni, di origine lombarda, ma nel tempo della stampa già cittadini alessandrini, appartenevano a una famiglia che in seguito divenne feudataria di Bergamasco nell’Alessandrino. Nell’edizione Moscheni precedono gli Statuti, ivi comprese aggiunte fatte da Giovanni Visconti e da Girolamo che gli successe; seguono le consuetudini del 1179 e infine alcuni ordini dei secoli XV e XVI.
05. Palazzi e chiese
Introduzione
Mentre, come abbiamo visto nel capitolo precedente, la città sta cercando di ottenere quel che brama di più – la civitas – con le lusinghe a Papa Alessandro III e gli ossequi nei confronti dell’imperatore Barbarossa, la battaglia diplomatica si gioca anche “in casa”. Alessandria della Paglia? Alessandria nata dal fango? Sarà. Ma nella plàtea, la piazza in cui gli alessandrini avrebbero voluto intestare il nuovo duomo al Papa, intestazione che deve obbligatoriamente mutare da Alessandro a Pietro per richiesta dello stesso Papa, il duomo c’è e non è di fango o di paglia, bensì solido di buoni mattoni e di bei marmi, con le tre porte riccamente ornate, come ci dice Francesco Gasparolo.
Di fianco, come ci spiega Fausto Bima, c’é il complesso di Palatium Vetus, il municipio di allora. Da un lato si amministrava la giustizia di Dio, dall’altro quella dei cittadini.
Ma le meraviglie di Alessandria non finivano qua. Se oggi vi recate nella zona dove era ospitato il vecchio ospedale militare, angolo via Cavour via XXIV Maggio, da via Cavour potrete inoltrarvi tra l’erba incolta di un giardino intitolato a Michele Pittaluga, dribblare un cartello che dice di fare attenzione, magari superare un gruppetto di pensionati che giocano a carte e, alla fine, intravedere uno scorcio dell’antica chiesa di san Francesco. Dico antica perché è uno dei più vecchi, se non il più vecchio monumento cittadino, visto che la tradizione attribuisce l’inizio dei lavori per il complesso cui la chiesa appartiene addirittura a san Francesco nella visita che fece ad Alessandria.
Meglio, molto meglio della chiesa di san Francesco stanno le 15 tavole ospitate nel museo-pinacoteca della città. Si tratta di un ciclo di affreschi denominato “Le stanze di Artù”. Il suo committente e – probabilmente – ispiratore, è l’alessandrino Andreino Trotti, condottiero di ventura al soldo del marchese Gian Galeazzo Visconti e partecipante alla battaglia di san Giacomo della Vittoria, combattuta nel 1391. Dopo il trionfo, Gian Galeazzo lo ricompensa lautamente e, con il denaro ottenuto, Andreino può acquistare una torre a Frugarolo, quella detta di San Pio V, restaurandola e alzandola di un piano. Poi chiama a sé un artista proveniente dai cantieri viscontei di Pavia e gli commissiona l’esecuzione dell’opera.
Francesco Gasparolo,
La vecchia cattedrale, Rivista di Storia, Arte e Archeologia per le Province di Alessandria e Asti, 1904
Nell’anno 1169 venne fatta l’offerta ad Alessandro III, in un modo specialissimo, di un pezzo di terreno dell’estensione di tre jugeri, il quale si trovava nel centro della novella città, che dal grande pontefice aveva assunto il nome. L’offerta, fatta in nome di Alessandria dai suoi consoli, mirava a far sì che la chiesa, la quale si doveva edificare dagli alessandrini, ricevesse splendore dalla particolare protezione della Santa Sede; protezione che, generalmente, dalla grande madre Roma stendendosi alla figlia novella Alessandria, doveva affermarsi in modo più vivo dal san Pietro di Roma al san Pietro di Alessandria.
Il terreno pare fosse di pertinenza del quartiere di Marengo, precisamente al confine con quello di Rovereto e con quello di Gamondio, sebbene altri creda che appartenesse al quartiere di Rovereto.
La cattedrale fu incominciata quasi subito, dopo di modo che nel 1178 era compiuta quantunque già prima che vi fosse posta l’ultima mano, cioè nel 1175, avesse ricevuto il titolo di cattedrale. Un antico statuto, citato da un altro posteriore che trovasi nel liber statutorum civitatis alexandriae sotto il titolo capitulum talie laborerii sancti petri civitatis alexandrie, ci riferisce essere stata ogni persona obbligata a pagare una tassa per l’edificazione di questo duomo.
Disegno di Luigi Visconti
Il Chenna vorrebbe che questa prima cattedrale non fosse guari sontuosa, essendochè poco tempo dopo sia stata riedificata. Sarà vero: quello però che par certo si è che la riedificazione si impose perché l’antica era angusta, né poteva comodamente servire a una città che in pochi anni erasi rapidamente allargata. Nei primi tempi del Comune il popolo si radunava nelle chiese. Nelle chiese si tenevano le assemblee, i consigli, le credenze; talora sulle sue piazze o intorno ad esse si radunavano gli abitanti per ascoltare e deliberare sui più gravi affari pubblici. Le chiese costituivano il centro della vita politica delle città italiane. La cattedrale veniva propriamente considerata come appartenente al Comune; di fatto, come dicemmo, tutti i cittadini vi concorrevano nell’edificarla anche in forza di una legge generale. I palazzi comunali non servivano, nei tempi più remoti, se non all’amministrazione ordinaria della giustizia e alle assemblee più ristrette.
Di qui si capisce il motivo per cui gli alessandrini ben presto trovarono inadatta la primitiva piccola chiesa principale, atteso l’ammirevole sviluppo che, grazie alla sua ottima posizione strategica, prendeva di giorno in giorno la città. Di fatto, un secolo dopo si imprendeva la fabbrica di una nuova cattedrale. E’ appunto quello che avvenne di tante altre cattedrali: quando le cattedrali incominciarono a servire ad adunanze popolari, si sentì tosto il bisogno di allargarle.
Le notizie circa la struttura di questa seconda cattedrale di Alessandria si possono desumere da tre fatti:
l. da un disegno della facciata; disegno che si può credere conservato tuttora nell’aula capitolare, sebbene non manchino altre copie importanti presso privati;
2. dai diversi storici alessandrini, nonché dai documenti tuttora esistenti negli archivi;
3. dalla stretta relazione che, secondo taluni, si trova fra la vecchia cattedrale, ora demolita, e l’architettura di Santa Maria di Castello, tuttora esistente.
L’architettura della facciata era quale si trova in tutti gli edifici religiosi del secolo XIII. Essa apparteneva a quella maniera di gotico che dal Cordero vien chiamato gotico moderno o posteriore e che precisamente incomincia dalla metà del secolo XIII e va fino a Martino V, mentre il gotico anteriore si protende alla rovina del regno longobardo per opera dell’imperatore Carlo Magno.
Le porte della cattedrale erano tre: quella di mezzo era la più riccamente ornata come, del resto, si usava comunemente. La facciata deve aver patito qualche modificazione nell’abbattimento delle torricelle; abbattimento accaduto negli ultimi tempi, quando i trofei di Casale (l’angelo e il gallo) furono trasportati sul vertice della cupola dell’orologio che trovasi nella facciata del palazzo comunale.
Nell’interno della cattedrale esistevano diverse cappelle. Si fa menzione:
1. della cappella contenente il miracoloso simulacro della Beata Vergine, cappella che nel secolo decimo quarto prese il nome della Salve.
2. della cappella della santa Croce, terminata insieme alla fabbrica della cattedrale, cioè nel 1297. Era tutta chiusa da un’inferriata e si trovava vicino a quella della Salve.
3. della cappella di santa Caterina, di cui è menzione in un’iscrizione riferita dallo Schiavina e dal Ghilini.
4. della cappella di san Giuseppe. Aveva il suo coro e, dietro di esso, anche una speciale sacrestia.
5. della cappella di san Silvestro, che poi mutò nome e si chiamò della Madonna dell’Uscetto.
6. della cappella di sant’Andrea, già della Concezione.
7. della cappella della Santissima Annunciata.
Il tempio doveva essere nell’ interno assai bello. Eranvi pregiate pitture, fra cui quelle di Antonio Maria Semino. Oltre alle insigni reliquie che rendevano venerando il maggior tempio degli alessandrini, meritano menzione speciale i trofei che attestavano le glorie degli antenati.
Il campanile sorgeva a sinistra di colui che guardava la facciata. Esso non formava corpo colla chiesa, quantunque nel secolo decimoterzo lo troviamo per lo più, negli altri luoghi, incorporato. Quando fosse stato incominciato non si può sapere con precisione: la fabbrica del campanile allora non coincideva quasi mai con quella della chiesa. Secondo i nostri cronisti avrebbe avuto principio nel 1292 e, rimasto incompiuto per le guerre sino al 1510, un decreto della città ordinò che fosse condotto a termine.
Il nome di Gagliaudo, l’eroe popolare, è celebre fra gli alessandrini. Secondo le cronache questa statua venne collocata sul campanile nel 1292, trasportata da ignoto luogo ove prima si trovava, essendo scultura del secolo decimosecondo. Si è dubitato e si dubita circa il significato della statua. Comunemente si fa passare per una cariatide, ma senza alcuna prova seria. Si vuole che essa appartenesse a un palazzo dei re longobardi a Marengo. Si dubita persino, sia dell’esistenza dell’eroe alessandrino, sia che avesse veramente il nome di Gagliaudo, sia che siagli stato applicato dalla riconoscenza popolare nel significato primitivo di “gagliardo”.
I trofei adunque cittadini non solo si adunavano attorno alle chiese, ma anche attorno ai campanili: il campanile medioevale aveva alcunchè di profano, che lo pareggiava a una torre comunale. Così sopra la porta del campanile, oltre alla statua di Gagliaudo eravi una rozza scultura in rilievo raffigurante una lupa cavalcata da un puttino, mentre un altro sta davanti scherzando colla belva; scultura allusiva al miracolo del Beato Francesco operato in Alessandria, il quale rese mansueto il fiero animale che infestava 1’agro alessandrino.
Sulla porta del campanile erano pure scolpite le misure: esse servivano di controllo nelle controversie che sorger potessero in tempo di fiera e di mercati, il cui centro era appunto la piazza del duomo.
Fausto Bima,
Palatium Vetus, Rivista di Storia, Arte e Archeologia per le Province di Alessandria e Asti, 1963
Il Palazzo Vecchio del Comune, costruito, insieme al duomo, ai fossati e ai bastioni al momento della fondazione (1I66-68) di Alessandria, ha subìto nei secoli, come era naturale, molte trasformazioni e vicende.
Il nome di “Palatium Vetus” deriva dal fatto che il Comune, nel volgere del primo secolo dalla sua fondazione, aveva avuto la necessità di nuovi locali e aveva scelto, sempre sulla piazza maggiore, quell’area dove ancor oggi sorge il municipio sulla quale costruì quello che si chiamò il “Palatium Novum”, edificio che nel 1297, quando vennero riordinati e raccolti gli Statuti Civici, già esisteva. Nelle cronache del Claro, del Lumelli e dello Schiavina, come negli Annali del Ghilini, mentre ci sono citazioni di lavori alle fortificazioni o alla cattedrale, di quelli dei palazzi del Comune non v’è cenno. Pure lavori ci furono, e aggiunte e rifacimenti, come ben comprovano gli edifici ancor oggi esistenti anche se in parte deturpati e trasformati.
Il Palatium Vetus aveva la facciata principale sull’angolo della piazza con l’attuale via Migliara, si prolungava per un buon tratto in questa via e aveva due corpi trasversali che dall’interno arrivavano fino a via dei Martiri. Nel Palatium Vetus avevano sede gli uffici del podestà e gli organi giudiziari, carceri comprese. Con l’instaurarsi della dominazione spagnola il palazzo venne adibito a sede dei governatori con i relativi uffici e la Municipalità, o Provvisione, si ritirò nelle più modeste stanze del Palatium Novum.
Il Palatium Vetus rimase sede dei governatori anche dopo l’avvento dei Savoia e di Napoleone che nel 1806, in occasione della sistemazione della piazza e dell’abbattimento dell’antico duomo, fece demolire la vecchia facciata originale, con portici sotto i quali si rendeva giustizia e botteghe che sul lato di via Migliara sono ancora rimaste incorporate nell’attuale palazzo e dentro alcune delle quali sono ancora visibili elementi come capitelli, pilastri e volte a crocìera.
La facciata verso piazza, così come oggi si vede, è appunto del periodo napoleonico e ad essa sono murati la lapide commemorativa e uno dei cento cannoni risorgimentali. Per fortuna i lavori di Napoleone si limitarono al corpo di facciata, ma tutti gli altri corpi trasversali e interni sono quelli antichi anche se su alcuni di essi sono state fatte, come era naturale, delle sovrapposizioni, in gran parte ottocentesche.
Caduto Napoleone e tornati i Savoia, il palazzo da sede della prefettura di Marengo tornò ad essere sede del governatore militare e successivamente del comando di divisione. Dopo l’ultima guerra fu destinato a sede del distretto militare. Il palazzo rimase di proprietà del municipio fino al 1856 quando venne permutato su un estimo di centoventimila lire con il terreno, sempre sulla piazza, su cui oggi sorge l’attuale palazzo della Banca d’Italia. In quell’occasione vennero scorporate dal demanio militare una parte delle due ali trasversali verso la via dei Martiri, acquistate dal banchiere Vinca che attuò una trasformazione, per fortuna superficiale, degli edifici ad uso abitazioni. Una parte dei negozi prospicienti via Migliara da tempo non erano più del comune o del demanio ma appartenevano al monte di pietà; un’altra parte rimase ed è ancora del demanio.
AA.VV.
Chiesa di San Francesco, Opuscolo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, s. d.
Nella “Vita II” di Tommaso da Celano (n. 1200), primo biografo di San Francesco, al capitolo XLVIII è scritto “Mentre si recava a predicare ad Alessandria di Lombardia, fu ospitato devotamente…”.
Scrive il Chenna: “Vi ha certa tradizione che il convento di Alessandria sia stato fondato dallo stesso san Francesco, Padre de’ Minori Conventuali, nell’occasione che egli fu in Alessandria, (nel 1210 secondo il Ghilini, ma nel 1220 secondo il Lumelli) durante il lungo viaggio intrapreso per andare ad evangelizzare i mori della Spagna e del Marocco”.
Nel 1290 la chiesa era già forse perfezionata, giacché papa Nicolao IV con Breve del 13 dicembre dell’anno medesimo concesse indulgenza per chi si fosse recato ad “ecclesiam fratrum Minorum de Alexandria per visitarla, ed in essa orare”.
Non è certo che l’edificio a cui si riferiscono questi documenti sia quello tuttora esistente, o piuttosto una precedente struttura della quale alcuni vogliono rintracciare qualche segno nell’odierna sacrestia.
I lavori dell’attuale chiesa dovettero iniziare nel medesimo sito allo scadere del XIII secolo per volere del nobile Guglielmo Inviziati e furono portati a termine nei primi decenni del ‘300 a seguito di una donazione di re Roberto, figlio di Carlo d’Angiò, che dotò il convento di beni per il mantenimento dei religiosi.
Al secondo decennio del XIV secolo dovrebbe risalire la costruzione del campanile (basamento 8 x 6 metri) e di una cappella forse dedicata a san Ludovico, entrambi voluti dal patrizio alessandrino Antonio Boidi.
Disegno di Luigi Visconti
Le caratteristiche architettoniche dell’edificio confermano la datazione del primo ‘300, essendo un’elaborazione degli ideali gotici francesi attraverso i più equilibrati rapporti dimensionali caratteristici della tecnica tradizionale locale.
L’edificio è suddiviso in tre navate da slanciati pilastri a fascio, sormontati da capitelli cubici smussati alla base, talvolta arricchiti da stilizzate foglie d’acanto e da decorazioni zoofitomorfe.
Fino al XIX secolo l’interno presentava la spazialità delle chiese a sala, per la quasi coincidente altezza d’imposta delle volte delle tre navate.
Dalla facciata all’abside corrono 56 metri. La navata centrale è larga circa 10 metri, quelle laterali 5 metri. La navata centrale termina in un’abside quadrata, ricostruita alla fine del ‘700. Sui fianchi dell’edificio si aprivano una serie di cappelle con relativi iuspatronati e sepolture.
Il mattone a vista caratterizza tutto l’aspetto esterno della chiesa mentre il prospetto laterale, verso via san Giacomo della Vittoria, mantiene parti della decorazione in cotto della fascia sottogronda; appare ben conservato anche il campanile, scandito da una serie di archetti pensili ogivali su registri sovrapposti.
La facciata su via XXIV Maggio (larga circa 22 metri), è ancora leggibile nelle sue linee essenziali, divisa in tre campi da quattro contrafforti. Presenta in quello centrale il portale ad arco a pieno centro. Il frontone doveva risultare rialzato e terminare a capanna, logica conseguenza della forma originaria del finestrone, ancora adorno della decorazione in cotto ma tagliato dal cornicione.
Con la soppressione degli ordini monastici il convento di san Francesco divenne proprietà del demanio. Il decreto emesso a Saint Cloud il 23 Germinale – anno XI (1803) lo destinò a caserma di cavalleria. L’edificio fu quindi tramezzato orizzontalmente (1816) con la costruzione di un voltone e del soprastante pavimento, all’altezza di 5,80 metri rispetto al piano terreno. Più tardi venne costruito un “cavedio” (chiostrino) nella parte centrale, per la presa d’aria e luce dal tetto. Scopo di quell’intervento fu recuperare spazio allestendo i magazzini al piano terra e i dormitori al piano superiore.
Su ordine di Carlo Alberto (1833) l’intera struttura divenne caserma e ospedale militare, ma la facciata come pure gli interni subirono un visibile deterioramento.
Cesare Bertea, soprintendente ai monumenti del Piemonte, con lettera del 1° dicembre 1919, notificò che in forza della legge n. 364 del 20 giugno 1909, la chiesa di san Francesco aveva un grande valore archeologico e architettonico e che perciò sarebbe stata sottoposta agli articoli 2 e seguenti della legge sopra citata e art. 1- Legge 23 giugno 1912 n. 68. Con questo provvedimento si avviò la storia della chiesa di san Francesco come bene da tutelare, essendo di proprietà del Comune di Alessandria.
Fausto Bima, nel suo intervento al congresso di Storia dell’Architettura svoltosi a Torino nel 1957, disse: “tenuto conto che Alessandria per vicende militari è stata depauperata di molti monumenti e che la chiesa di San Francesco, se restaurata, costituirebbe una valorizzazione artistica e urbanistica del centro cittadino, invito il congresso a formulare un voto di incoraggiamento a tutte le Autorità ed Enti competenti per la valorizzazione di questo insigne monumento storico religioso”. A chiusura dei lavori il congresso accolse la proposta all’unanimità.
L’intervento, che avrebbe riportato la chiesa al suo antico splendore, non è mai stato effettuato.
AA. VV.
Gli affreschi delle stanze di Artù, informazione a cura delle sale d’arte comunali
Le Sale d’Arte comunali sono oggi aperte al pubblico nei nuovi locali ristrutturati dell’edificio che ha ospitato fin dalla seconda metà dell’ottocento il museo, la pinacoteca civica e la biblioteca di Alessandria.
Il percorso museale, rinnovato negli arredi e nelle strutture espositive, intende proporre al pubblico alcune delle più importanti opere e oggetti d’arte appartenenti alle collezioni del museo e della pinacoteca civica. La nuova sede, suddivisa in quattro sezioni espositive, oltre a proporre una riflessione sull’identità civica della città che vede le sue radici nel medioevo e nella civiltà comunale, accoglie lo splendido ciclo di affreschi ispirati alle storie di Artù. L’ottocento rivisitato attraverso il fascino della pittura di Giovanni Migliara e il novecento rappresentato attraverso l’opera dell’alessandrino Alberto Caffassi, anticipano l’esposizione di opere d’arte contemporanea confluite nelle collezioni a partire dagli anni ‘20. Quest’ultima sala viene inoltre utilizzata per le mostre temporanee.

Descrizione del materiale esposto:
Si tratta di un ciclo di affreschi, commissionati alla fine del XIV secolo da Andreino Trotti, condottiero e membro di un’importante famiglia alessandrina, per festeggiare la vittoria ottenuta nel 1391, al fianco di Gian Galeazzo Visconti, contro le truppe francesi. Gli affreschi si situano successivamente a questa data e prima del 1402, anno di morte di Galeazzo Visconti e del Trotti medesimo e vennero con ogni probabilità eseguiti da un artista proveniente dai cantieri viscontei di Pavia che deve aver avuto come modello e guida un codice illustrato delle storie di Lancellotto e di Artù. Il ciclo è uno degli esempi più antichi di “camera Lanzaloti” (così in epoca medievale venivano chiamate le sale decorate con tali soggetti) che si sia conservato ai nostri giorni e testimonia il notevole successo riscosso dall’iconografia arturiana in quel periodo. La fonte letteraria degli affreschi è il celebre romanzo “Lancelot du Lac”, il più famoso dei testi della saga cavalleresca di re Artù, tratto dalla “Vulgate Arthurienne” di Chretien De Troyes.
In origine, le quindici scene del ciclo decoravano le pareti della grande sala di rappresentanza della Torre Pio V di Frugarolo (AL) che fu prima curtis carolingia, poi castrum e mansio fornita di hospitium dei cavalieri gerosolimitani e in seguito divenne residenza signorile di Andreino Trotti. Dopo l’esito favorevole dell’impresa militare, il Trotti poté ampliare le sue proprietà e apportò importanti modifiche alla torre, innalzandola di un piano.
Della sala decorata si erano praticamente perse le tracce documentali quando fu ritrovata, nel 1971, nella torre ridotta a rudere e colombaia, fra infiltrazioni d’acqua, in condizioni disastrose. Ma la bellezza degli affreschi fece scattare una mobilitazione che consentì di staccarli e, al termine di un lungo e delicato processo di restauro, di presentarli al pubblico in una mostra nel 1999-2000 che poi venne resa permanente. Alle scene del ciclo si aggiunge un sedicesimo frammento raffigurante una “Madonna in trono con bambino”.
Lancillotto è riconoscibile dalla sigla “L” dipinta vicino a lui; Galehot ha sempre lo stesso cappello e una corta barbetta bionda come dettava la moda del tempo; Ginevra ha una lunga treccia bionda che le scende lungo la schiena, mentre la Dame de Malohaut porta i capelli sul capo intrecciati con un nastro.
06. Il mondo si complica
Introduzione
Passato il periodo eroico dell’assedio, seguito da quello fulgido della crescita e dei bei palazzi, Alessandria si sveglia agli inizi del ‘300 in un mondo che si fa sempre più grande, difficile, complicato. Al travaglio delle faide interne per la conquista del potere cittadino, spese anche fittiziamente nelle contrapposizioni tra guelfi e ghibellini, fanno da contrappunto le aspirazioni alla crescita di grandi famiglie in molte delle maggiori città dell’epoca. Tutto ciò porta alla conseguenza di una corsa all’accentramento del potere nelle mani di pochi soggetti in grado di affermarsi con la forza delle armi, sostenute da quella del potere economico-finanziario. Si vanno moltiplicando così governi di tipo assoluto, che svelano ben presto il loro nucleo autoritario smantellando rapidamente il patrimonio pluralistico che, pur con tutti i suoi limiti, aveva rappresentato il vanto dei Liberi Comuni.
Contribuisce a definire la complessità del quadro politico di riferimento anche la penetrazione in Italia di potenze straniere come quella degli angioini ad esempio, cui seguiranno aragonesi, francesi, spagnoli, savoiardi, che beneficeranno largamente delle divisioni interne, spesso fittizie anche in questo caso.
Di tale quadro così complicato e così variabile ci rendono alcuni aspetti significativi i testi che qui abbiamo selezionato e che sono tutti composti per l’occasione.
Cominciamo da un lavoro di Giorgio Marenco sulla politica delle guerre e delle alleanze che coinvolgono gli alessandrini. Proseguiamo con due brani di Filippo Orlando dedicati alla battaglia di Alessandria del 1391 ed entriamo nel mondo dei condottieri di ventura ancora con Giorgio Marengo, seguito da Roberto Maestri che ci racconta chi era Facino Cane, di quei condottieri il più famoso.
Concludiamo con un caso eclatante. Secondo il racconto che ce ne fa Girolamo Ghilini, si tratta di Guglielmo VII il quale, dopo aver scorrazzato in lungo e in largo per le campagne di Alessandria e averne anche acquistato il controllo, ora si trova alle mani con un distaccamento militare comandato dal generale Alberto Guasco d’Alice, dietro cui – si dice – c’è l’influenza della famiglia dei Visconti, signori di Milano, e il denaro degli Astesi.
Catturato, in un modo che nel racconto di Girolamo Ghilini fa sorridere (la collana d’oro), viene imprigionato nella buia segreta che in Alessandria sta sotto il Palazzo del Pretorio, dove muore di lì a poche settimane. Segno che, in quell’epoca di cambiamenti, sembra essere messo a rischio anche il vecchio regime feudale.
Giorgio Marenco
La Politica della Guerra e delle Alleanze nel XIII secolo Alessandrino
La storia politica di Alessandria nel corso del XIII secolo è strettamente legata alle vicende militari. Infatti questo periodo, come tutto il medioevo, é caratterizzato da una forte instabilità, tanto che in novant’anni (1200-1290) quasi la metà (42 anni su 90) risultano popolati da eventi bellici che coinvolgono gli alessandrini e il loro territorio.
Per gli uomini dei nostri giorni la guerra è un qualcosa di lontano e il concetto stesso di “nemico” esprime, nell’immaginario collettivo, l’idea di un individuo diverso per razza, religione e cultura; allo stesso modo la percezione corrente della storia medievale attribuisce grande rilevanza ai conflitti tra Oriente e Occidente, dimenticandosi però che la maggioranza delle lotte di quel tempo furono combattute tra cristiani abitanti in paesi vicini.
Nel XIII secolo la minaccia per Alessandria arrivava da Acqui, da Asti, dal marchese del Monferrato, e la politica “estera” (in un contesto dove San Salvatore era già Monferrato e quindi “estero”) si concretizzava attraverso accordi economici e militari con i quali le parti si impegnavano ad una reciproca difesa. Ma, essendo il territorio politicamente frammentato in tante città, si creava un fragile e complesso intreccio di rapporti pieni di deroghe ed eccezioni: ad esempio nel 1202, quando Alessandria stipula un’alleanza con i marchesi del Carretto, di Ceva e di Ponzone, si impegna ad aiutarli laddove fossero assaliti, ma ha la cura di precisare che l’accordo non avrebbe avuto valore se ad attaccarli fossero stati gli astigiani con i quali Alessandria era a quel tempo alleata.
Di contro, Asti non si fa grossi problemi di fedeltà quando, nel 1225, accetta il denaro genovese per entrare in guerra al fianco dei Liguri che stanno combattendo contro gli alessandrini: i legami cambiano in ragione delle opportunità, magari per approfittare di un momento di debolezza del vecchio alleato che – di colpo – si trasforma in una facile preda.

Gli assetti possono modificarsi nel giro dello stesso anno, come nel 1282 quando Alessandria inizia una campagna militare contro Cremona alleandosi ai Pavesi ma, per discordie insorte durante la missione, questa fallisce e nel giro di pochi mesi gli alessandrini entrano armati nel territorio di Pavia, sconfiggendone l’esercito e inseguendolo fin dentro le mura della città.
Alle divisioni esterne vanno poi assommate quelle interne: per lunghi anni le famiglie di Alessandria, divise in fazioni, si contendono con faide sanguinose le cariche del potere cittadino. In molti periodi le famiglie soccombenti vengono addirittura costrette ad abbandonare la città per salvare vite e averi e, una volta fuoriuscite, esse concludono accordi e alleanze separate per combattere al fianco di coloro che fanno incursioni e razzie sul territorio alessandrino. Così si regolano ad esempio le famiglie di parte ghibellina che si alleano con l’imperatore (1238), con Asti (1248) e con il marchese di Monferrato (1255), portando le armi contro i loro stessi concittadini.
La religione, com’é noto, risulta una componente molto importante all’interno della società medioevale, eppure anche questo elemento non pare costituisse ostacolo a intraprendere politiche aggressive nei confronti dei paesi confinanti: quando Alessandria (1215) assale e distrugge Casale Sant’Evasio, sembra normale che anche la chiesa locale sia saccheggiata e le reliquie dei santi ivi custodite vengano sottratte per arricchire le chiese alessandrine. E’ un sentimento religioso forte, ma che distingue senza pietà “noi e gli altri” invocando la protezione dei santi e di Dio anche nelle lotte contro altri cristiani; ne è esempio clamoroso la devozione particolare di Alessandria alla figura di san Pietro: per tutto il periodo di edificazione del duomo che era stato dedicato al santo (1170-1297), ogni volta che la città andava in guerra contro i vicini il primo soldato ad essere iscritto al ruolo militare per la città era proprio san Pietro che, in quanto combattente, si vedeva attribuito uno stipendio per ogni giorno di guerra. Stipendio che veniva poi liquidato in favore della fabbrica del duomo.
Il lungo elenco delle incursioni e dei saccheggi non riesce a esprimere l’idea di quali violenze, stupri e razzie dovette sopportare la popolazione civile che, peraltro, era già gravata dal peso di periodiche inondazioni, carestie e pestilenze che minacciavano le basi di un’economia fondamentalmente agricola. Fra il 1271 e il 1275, nel corso dell’ennesima guerra contro Asti, i soldati dell’una e dell’altra parte devastano con cadenza annuale le campagne, bruciando case, saccheggiando raccolti e, in mezzo a tutto questo, viene da chiedersi con quale coraggio, con quale paziente ostinata rassegnazione i contadini trovano la forza per riprendere tutte le volte a coltivare il suolo, pur nella consapevolezza che il loro lavoro sarà probabilmente distrutto l’anno successivo.
I cronisti hanno tramandato ai giorni nostri i nomi delle nobili casate, di marchesi e generali, identificando in essi i protagonisti che combatterono guerre ed eroiche battaglie, ma sarebbe stato veramente bello se un bizzarro narratore ci avesse riportato anche soltanto il nome di una qualunque famiglia di povera gente che, a fronte di tali difficoltà, conducesse una vita senza scrivere la storia, ma tracciando col proprio lavoro pagine di autentico, umano eroismo.
Filippo Orlando
La battaglia di Alessandria (1391)
Via san Giacomo della Vittoria ad Alessandria è una strada lunga e stretta affondata nel centro storico, nell’incastro di vie delimitanti il vecchio ‘recetto’ medievale della città. Al centro circa del percorso viario, addossata alle altre case di antico segno gentilizio, la chiesa di san Giacomo, costruita per onore della vittoria militare degli alessandrini a danno degli angioini, avvenuta nell’anno 1391. Di tutto questo gli alessandrini ormai hanno perso memoria. Bisogna, infatti, tornare alla fase finale del basso medioevo italiano, nel XIV secolo, quando il conflitto mai sopito fra impero e papato dilaniava le signorie del nord Italia, signorie che erano troppo economicamente floride per essere pienamente soggiogate dai grandi poteri ‘universali’, in lotta ormai secolare e troppo militarmente deboli per non schierarsi a favore di uno dei contendenti dominanti la scena.
L’Italia del Basso Medioevo è dominata dallo scontro fra papato e impero, fra guelfi e ghibellini, scontro che dilania il tessuto sociale delle città e prepara l’età delle signorie e delle compagnie di ventura. E’ in tale contesto che matura lo scontro militare detto ‘Battaglia di Alessandria’. La lotta fra guelfi e ghibellini farà da sfondo alla lotta, ormai molto accesa a fine trecento, per il dominio del nord d’Italia.
Nel giro di pochi decenni si succedono varie guerre e battaglie. In tali conflitti, nel nord Italia prende il sopravvento il signore di Milano Gian Galeazzo Visconti. Quest’ultimo si allea, nel 1387, con il signore di Padova Francesco Novello di Carrara, al fine di conquistare le città del veneto e Verona stessa, dominata da Antonio della Scala. L’alleanza con Francesco Novello avrebbe dovuto portare Verona ai Visconti e Vicenza al Novello, ma Gian Galeazzo, approfittando della sua superiorità militare, spodesta le città degli Scala e le città del Novello rompendo con quest’ultimo ogni alleanza. Il gioco spregiudicato porta in dote ai Visconti Padova, Belluno e Feltre, cedendo Treviso alla Repubblica di Venezia.

Gian Galeazzo Visconti
Ormai Gian Galeazzo Visconti è il più importante sovrano del nord della penisola italiana. Nasce così una lega contro il Visconti che tiene insieme Novello di Carrara, la Repubblica di Firenze, Stefano III di Baviera e Giovanni III D’Armagnac. Il Visconti risponde a questa nuova lega, nata per contrastare le sue mire di espansione, chiedendo a Carlo VI di Francia l’arbitrato sulle contese italiane. Le ostilità si aprono nel 1389 con la lega anti-viscontea, guidata dal mercenario inglese Giovanni Acuto che, partendo da Padova, muove alla conquista della Lombardia. Dalla Francia il Conte D’Armagnac, attraversando le Alpi, entra nella pianura piemontese conquistando vari castelli. E’, tuttavia, a Castellazzo che le truppe del D’Armagnac vengono respinte da un contrattacco degli occupanti, causando alle truppe francesi la perdita di numerosi cavalli e tende da campo. Nel frattempo Gian Galeazzo Visconti, per organizzare un esercito efficiente che contrasti l’avanzata nemica, è costretto a vendere Serravalle Scrivia per 22000 ducati alla Repubblica di Genova.
Il capitano di ventura assoldato dal Visconti è Jacopo Dal Verme, nato a Verona nel 1350 e passato al soldo e ai servigi della Repubblica di Venezia e dei signori di Saluzzo, degli Scaligeri e dei Visconti. Morirà poi, dopo aver rotto con i Visconti di Milano, appena ritornato ai servigi militari della repubblica di Venezia, colto da malore nel proprio letto nell’anno 1409.
Torniamo adesso alla battaglia: il conte D’Armagnac giunge alle porte di Alessandria e la pone sotto assedio. Alcuni cittadini alessandrini, avuta notizia dell’arrivo delle truppe viscontee del Dal Verme, vanno incontro al condottiero per informarlo dell’esatta posizione delle truppe francesi asserragliate presso Alessandria. Giovanni III D’Armagnac conta su un’avanguardia di mille cavalieri, molto stanchi per le precedenti scaramucce, e sul valore di capitani d’arme come Rinaldo Gianfigliazzi, Giovanni Ricci, Aimery di Severac, Giovanni Dudain, Mottino della Pezza e François d’Albret.
Le truppe viscontee del Dal Verme sono organizzate con almeno 2000 cavalieri, 4000 fanti e numerosi balestrieri. Vi sono valorosi condottieri e nobili, come Ugolotto Biancardo, Brandolino Brandolini, Leonardo Malaspina, Ceccolo Broglia, Anderlino Trotti, Calcino Tornielli, Benzio Buffazzi, Tommaso Ghilini, Paolo Savelli, Antonio Balestrazzo, Filippo da Pisa.
Lo scontro decisivo avviene nei pressi di Castellazzo il 25 giugno del 1391. La battaglia dura complessivamente tre ore, nelle quali la cavalleria del duca D’Armagnac si difende dagli attacchi in maniera valorosa, cercando più volte di non farsi accerchiare dalle soverchianti truppe nemiche. Ma la stanchezza dovuta alle scaramucce militari dei giorni precedenti e le capacità di direzione del Dal Verme, oltre che la disparità enorme delle forze in campo e la bravura inesorabile dei balestrieri, (ai tempi arma micidiale contro la cavalleria), hanno ragione delle forze francesi che sono letteralmente sgominate. Cade, sotto un colpo che lo porterà alla morte, pure Giovanni III D’Armagnac. La disfatta militare è netta, ma non decisiva per le sorti dell’intero conflitto. Certamente il Visconti impedisce agli angioini e al duca di Baviera di invadere il proprio territorio, ma non riesce a ottenere una vittoria definitiva per la primazia sull’Italia e su Firenze in particolare. Essa giungerà solo negli anni successivi.
La pace viene firmata l’anno successivo nel 1392 e Gian Galeazzo Visconti restituisce Padova a Francesco Novello da Carrara, ma si assicura il controllo di Bassano, Belluno e Feltre. Nella sostanza la signoria milanese non risulta ridimensionata e continua ad accarezzare il sogno di riunificare sotto di sé l’intera Italia settentrionale. Il primo maggio 1395 il Visconti ottiene, inoltre, dall’imperatore Venceslao IV di Boemia, il titolo di duca di Milano, l’anno successivo quello di conte di Pavia e nel 1397 quello di duca dell’intera Lombardia.
Filippo Orlando
La costruzione della chiesa di san Giacomo della Vittoria
Dopo la brillante vittoria delle truppe viscontee e degli alessandrini guidati da Jacopo dal Verme sui francesi del duca D’Armagnac, grazie al clamore suscitato dall’episodio militare è lo stesso condottiero veneziano a prendere l’iniziativa per la costruzione di una chiesa celebrante l’importante episodio bellico. Ricorrendo al bottino conquistato, il Dal Verme compra alcune case e poi le fa abbattere, recuperando così lo spazio utile alla costruzione del monumento. Il nuovo luogo di culto viene denominato “San Giacomo della Vittoria” per celebrare così il conflitto concluso con successo e il capitano di ventura che aveva guidato le truppe in battaglia.
Ovviamente, nessuno dei vincitori si preoccupa del destino di quelle famiglie “sfrattate” dalle legittime abitazioni senza guardare troppo da vicino dove sarebbero andate e se il poco dato sarebbe stato sufficiente a garantir loro una sistemazione adeguata a quella che avevano.
E’ la guerra, direte voi. Già, ma prima di tutti gli altri penano i poveretti. Come sempre.

La chiesa di San Giacomo della Vittoria
Della vecchia struttura trecentesca purtroppo non resta molto, la facciata attuale è di epoca successiva e la chiesa è stata oggetto di restauri e rimaneggiamenti continui lungo il XIX e XX secolo.
La prima costruzione ecclesiastica è terminata all’inizio del ‘400 e sulla facciata a sinistra della porta che dal ponte sul Tanaro conduceva dentro le mura di Alessandria viene apposta una scritta in latino che così recitava:
MCCCXCI die Julii In Festo Sancti Jacobi Alexandrina Juventus In Conflictum Posuit Comitem Armeniacum In Castris Constitum Existente Capitano D. Jacobo Verme 1391
mentre sull’architrave della chiesa è invece apposta un’altra scritta in latino:
“Anno Xti MCCCLXXXXI die XXV Julii festo S. Jacobi Apost. Alexandrina Juventus Duce Jacobo Vermensi Exercitum Comitis Aremoricoe profligavit et templum hoc, inde Aedificatum Divo Jacob dicavit, quod ab hac Victoria de Victoria appellatur.”
“Anno di Cristo 1391 il giorno 25 luglio festa di San Giacomo Apostolo la Gioventù Alessandrina Duce Giacomo Dal Verme sconfisse l’esercito del Conte d’Armagnac e questo Tempio di poi edificato al glorioso San Giacomo dedicava e da questa Vittoria della Vittoria nomava.”
I rimaneggiamenti lungo i secoli sono stati tanti, come detto. Nel 1500 l’edificio è rifatto secondo i gusti dell’epoca, inglobando le aree della costruzione originaria. Diventa nei decenni ospedale e magazzino, sede di un convento e pure di una caserma dei carabinieri. Infine, la chiesa torna ai Padri Cappuccini. Sono costoro a cercare i finanziamenti per un primo restauro del tetto e della facciata negli anni 1869-1871. Ma il tetto viene solo puntellato, in attesa che un contenzioso fra il comune di Alessandria, la curia vescovile e i Padri Cappuccini arrivasse a decidere su chi toccava la responsabilità dei lavori necessari. La situazione si sblocca solo nel 1923, quando il restauro è finalmente finanziato dalla banca Alessandro III e da padre Agostino Pernacchia dei Padri Serviti.
Traiamo da una edizione specializzata in bellezze paesaggistiche italiane questa descrizione della chiesa di San Giacomo della Vittoria:
La facciata è caratterizzata da elementi che rimandano allo stile rinascimentale: la suddivisione in due fasce orizzontali – di cui quella superiore aperta da un grande rosone – sormontate dal timpano, la scansione in verticale data da lesene scanalate, il portale di ingresso inquadrato da colonne su alto basamento e incorniciato da spesso cornicione a fascia. Ai lati del portale d’ingresso sono i bassorilievi di due Santi.
La chiesa di san Giacomo della Vittoria è un gioiello storico-artistico, simbolo architettonico per la città di Alessandria dell’epoca rinascimentale. Oggi si presenta ad aula unica con volta a botte e abside poligonale mentre le pareti perimetrali sono scandite da tre archi per lato; il rivestimento marmoreo dei pilastri è riconducibile a un intervento novecentesco. La volta presenta motivi decorativi ad affresco e cornici in stucco dorato riconducibili agli anni ’50-’60 dell’ottocento.
Giorgio Marenco
Capitani e condottieri
La figura del capitano di ventura è tra quelle che ha riscosso maggiore successo nell’immaginario collettivo, evocando l’immagine dell’uomo a cavallo, vestito d’acciaio, capace di risolvere la battaglia con coraggio e genio tattico.
La storia reale, come spesso accade, disegna un quadro differente per comprendere il quale non si può che partire dal concetto stesso di “condotta”. Si tratta di un tipo di contratto il cui impiego non era limitato al campo militare ma che, all’epoca, veniva utilizzato anche per affidare lo sfruttamento di una concessione mineraria o per gestire l’appalto di esazione delle imposte.
Un datore di lavoro (locator) prendeva in affitto un imprenditore (conductor da cui condottiero) che si impegnava a svolgere un certo lavoro mettendo a disposizione personale specializzato, attrezzature e un’idonea struttura organizzativa; il tutto in cambio di un compenso e per un periodo di tempo predeterminato.

Il condottiero, dunque, non era semplicemente il capo di una banda di armati, ma il titolare di un’impresa militare che poteva essere assunto:
“a soldo disteso” quando insieme ai suoi uomini era inserito in un esercito più grande con precisi rapporti gerarchici,
“a mezzo soldo” quando gli era assegnata una zona geografica e un incarico di massima, lasciandogli l’autonomia di guerreggiare “… a suo bell’agio le terre, sovra le quali era mandato”,
“in aspetto” quando, cessate le ostilità, riceveva comunque del denaro per restare a disposizione del signore di turno il quale si assicurava in tal modo una protezione senza correre il rischio, in futuro, di ritrovarsi a combattere proprio contro quel condottiero che aveva precedentemente ingaggiato per la sua bravura.
Il contratto di condotta dettagliava con precisione tutti i contenuti della prestazione: si diceva quanti uomini dovevano esser messi a disposizione, con quali armi e armature, con quanti cavalli e carriaggi e con quali ufficiali. Si stabiliva come sarebbero stati ripartiti il bottino e i riscatti per i prigionieri e a quali condizioni il condottiero e i suoi uomini, laddove catturati, avrebbero potuto essere riscattati. Si fissavano inoltre penali e multe per ogni inadempimento e indennizzi per il materiale ammalorato in battaglia, per i feriti, per i morti, per i cavalli persi o “magagnati”.
Il contesto contrattuale ci aiuta a comprendere l’origine di quella che nei tempi odierni è rimasta una pratica diffusa di tutti gli eserciti, ossia la “rivista militare”: una sfilata dei soldati in pieno assetto di combattimento. Oggi tale attività ha un carattere celebrativo e si svolge in occasione delle feste nazionali, all’epoca faceva invece parte degli accordi: il condottiero doveva portare tutti i suoi soldati, cavalli e attrezzature in un certo luogo, in un dato giorno, affinché chi lo aveva ingaggiato potesse controllare materialmente che aveva messo in campo le forze e gli armamenti pattuiti.
Ma la vita della compagnie di ventura non si esauriva nelle attività militari le quali, per essere realizzate, richiedevano la presenza di una collaudata struttura logistica. Smessa l’armatura, il condottiero doveva procurarsi degli esperti arruolatori (per rinfoltire le sue truppe), fabbri, maniscalchi e falegnami (per manutenere le attrezzature e le armi), medici, cuochi e una consistente schiera di garzoni chiamati a svolgere i ruoli più disparati (badare ai cavalli, montare gli accampamenti, condurre i carri, ecc.). Occorrevano poi notai e contabili che si occupassero di dare la paga ai soldati, di gestire gli acquisti e organizzare la vendita del bottino che andava messo sul mercato quanto prima possibile dato che il suo trasporto e la sua custodia appesantivano gli spostamenti dell’esercito.
Era proprio la mobilità (insieme alla disciplina e all’addestramento) il punto di forza delle compagnie di ventura italiane, che privilegiavano le truppe a cavallo in grado di spostarsi da uno scenario all’altro per sorprendere il nemico. La battaglia campale, se possibile, veniva evitata preferendo indebolire l’avversario con rapide incursioni alle quali seguivano distruzioni e saccheggi; in questo modo il signore dei luoghi devastati non solo avrebbe perduto ricchezze, ma avrebbe dovuto concedere alle medesime località l’esenzione dei tributi se non voleva che gli abitanti emigrassero altrove. Ma meno tributi voleva dire minore possibilità di ingaggiare soldati ed ecco così che col saccheggio si riduceva la forza del nemico senza avere la necessità di affrontarne l’esercito in campo aperto.
Nel corso dei secoli l’imprenditore militare ha continuato, in forme e contesti diversi, a restare in auge e oggi se ne contano diversi esempi: negli Stati Uniti la “Academi” è una compagnia militare privata che addestra ogni anno oltre trentamila tra mercenari, militari e agenti di polizia, stipulando contratti in ogni parte del mondo. La differenza è che questi moderni imprenditori sono manager seduti dietro a una scrivania e non scendono sul campo di battaglia, in armi, alla testa dei loro soldati a differenza di quanto fecero i loro colleghi del passato e che, almeno in questo, onorarono la fama che la leggenda ha loro tributato.
Roberto Maestri
Facino Cane “Signore” di Alessandria
Una storiografia sabauda ottocentesca – tradizionalmente ostile al Monferrato – ci ha tramandato un ritratto decisamente negativo di Facino Cane, descrivendolo sommariamente come un personaggio violento, sanguinario, privo d’istruzione e di senso dell’onore e, anche nel novecento, il torinese Nino Valeri nella sua biografia del condottiero ne restituisce un’immagine simile.
Nel 2012 ricorreva il sesto centenario della morte di Facino Cane e il Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato” intraprese un lungo percorso celebrativo per approfondire, attraverso un’indagine esaustiva, la figura del condottiero: Facino era l’uomo assolutamente negativo ritratto negli ambienti sabaudi – e così raffigurato anche da un coevo convegno tenutosi a Casale – oppure, appartenendo Facino ad una “storia monferrina” volutamente dimenticata (e a volte mistificata), la sua figura era stata volutamente tramandata in quel modo? “I Marchesi del Monferrato” hanno provato a dare una risposta al quesito attraverso il volume “Facino Cane. Sagacia e astuzia nei travagli d’Italia tra fine Trecento e inizio Quattrocento” edito nel 2014 e che raccoglie i frutti della complessa indagine.
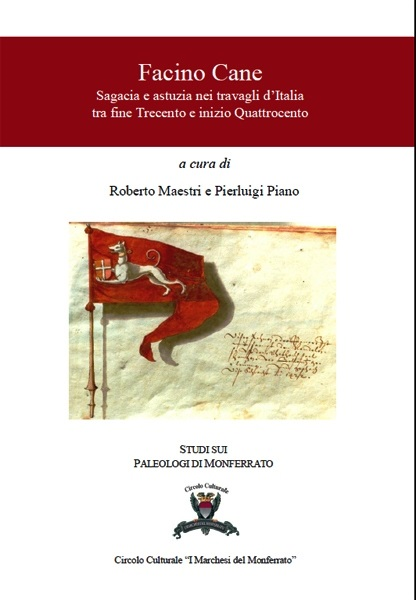
Facino era sicuramente un “uomo del suo tempo”, apparentemente non diverso da altri condottieri a lui legati: Ottobono Terzi, Pandolfo Malatesta, Jacopo dal Verme….
Indagare Facino non è stato, non è, non sarà mai un compito facile; pochissime sono le certezze e tra queste non compaiono né la sua data di nascita né il luogo: nel primo caso possiamo solo presumere che avvenisse intorno al 1360, mentre per il luogo non esistono documenti che confermino che il Cane sia nato a Casale, dove risiedeva il ramo principale della sua famiglia; ma Facino apparteneva ad un ramo minore dell’illustre casata.
La presa di Alessandria da parte di Facino resta una delle sue imprese militari più eclatanti, seconda forse solo alla presa di Bologna compiuta sei mesi prima e il cui comune denominatore è rappresentato dalla figura del duca di Milano, Gian Galeazzo Visconti, principale committente del Cane già dall’epoca della “guerra di Mantova” del 1397, impresa in cui combatté anche un illustre condottiero alessandrino: Andreino Trotti.
Le vicende di Facino Cane e di Alessandria si incrociano nel settembre del 1403. Facino aveva espugnato Bologna per conto di Gian Galeazzo Visconti, che lo aveva insignito del titolo di governatore della città.
“Ad Alessandria nel mese di settembre i guelfi, comandati da Gabriele Guasco, si erano impadroniti della città e avevano innalzato la bandiera francese degli Orleans: il presidio della cittadella (che sorgeva sull’attuale sito di piazza Matteotti), rimasto fedele al governatore Zanotto Visconti, morto il giorno dopo esservisi rifugiato, stava per arrendersi agli assedianti.
Il Guasco, con l’aiuto di trecento cavalieri, comincia a bombardare le mura della cittadella, ma i ghibellini viscontei resistono e l’unica possibilità di costringerli alla resa è quella di prenderli per la fame, speranza in parte delusa in quanto i ghibellini del terziere di Bosco riescono a introdurre di nascosto molta farina. Ma, nonostante questo stratagemma, alla fine di settembre i viscontei sono ormai disposti a trattare la resa con il Guasco.
La situazione si evolve improvvisamente: il 21 settembre Facino, con seicento cavalieri, raggiunge Alessandria, entra in Cittadella e avvia il contrattacco; i guelfi non sono in grado di opporsi e il Guasco è costretto a rifugiarsi in Bergoglio mentre i Trotti e i del Pozzo riparano a Castellazzo Bormida e Oviglio..
Alessandria è saccheggiata per otto giorni e, dopo aver represso nel sangue ogni resistenza, Facino rivolge le sue attenzioni a Bergoglio, ancora nelle mani del Guasco, iniziando a bombardarne le mura e costringendo il 21 settembre gli occupanti alla resa e ad abbandonare la città; Gabriele Guasco si ritira in Asti e successivamente in Francia. Agli abitanti di Bergoglio è imposta una taglia di 22.000 fiorini d’oro: il pavese Pietro Corte, che ha l’incarico di riscuotere la multa e si rivela infedele nella riscossione, è decapitato.
Il bottino, frutto del saccheggio della città, è acquistato da mercanti di Pavia, di Casale e di Valenza, che lo trasportano lungo il Tanaro cresciuto per le recenti piogge.
Luminarie e suono di campane a Milano festeggiano per tre giorni la vittoria di Facino. Caterina Visconti, duchessa di Milano, e il figlio Giovanni Maria Visconti, duca di Milano, il 28 ottobre danno in pegno a Facino l’usufrutto di Valenza con il suo castello e il castello di Monte per 45.000 fiorini, di Montecastello con il suo castello per 8.000 fiorini, di Breme per 7.000 fiorini, come compenso degli stipendi arretrati dovuti a lui e ai suoi uomini.
Facino fa riesumare – dalla cattedrale di San Pietro – le reliquie di Sant’Evasio, patrono di Casale, e dei Santi Natale e Proietto e le fa portare prima a Borgo San Martino e, quindici giorni dopo, le trasporta solennemente nel Duomo di Casale.”
[R. Maestri, Facino Cane…, pp. 33-34]
Purtroppo non disponiamo di documenti utili a chiarirci quali furono i rapporti tra gli Alessandrini e il Cane; com’é noto, l’archivio comunale di Alessandria (come quello Visconteo) risultano, a causa di incendi, mutili dei documenti del periodo e di nessun aiuto sono le successive cronache alessandrine, compresa quella del Ghilini che contiene alcune evidenti inesattezze cronologiche. Certo, i rapporti non dovevano essere ottimali se, a distanza di un solo anno dalla presa della città, il condottiero dovette tornare nel territorio alessandrino per sedare un tentativo di ribellione:
“Mentre opera nel Pavese, Facino è informato di una nuova ribellione nell’alessandrino; di conseguenza assale, inutilmente, la fortezza di Castellazzo Bormida, ma occupa Gamalero, Borgoratto, Castelspina, Oviglio, San Leonardo, Campaneam e Fresonara, mentre Portanuova gli resiste e resta nelle mani dei dal Pozzo. Domenico Trotti è catturato a Stradella – messa al sacco in nome di Facino – ed è condotto nella rocca di Borgo San Martino”.
[R. Maestri, Facino Cane…, p. 37]
Alessandria costituì per Facino la base operativa per le sue imprese in Lomellina, dove distrusse tutti i castelli esistenti – escluso quello di Lomello – nel tentativo, riuscito, di debellare ogni forma di resistenza al suo potere da parte delle famiglie aristocratiche del territorio.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla storiografia sabauda, Facino si distingueva sensibilmente dagli altri condottieri coevi: non era “solo” un mercenario da assoldare per conquistare o sottomettere località riottose, egli aveva un disegno ben preciso: costruirsi un suo Stato, un territorio cuscinetto tra il ducato visconteo, la contea dei Savoia, la repubblica di Genova e il marchesato di Monferrato. In pratica, Facino occupava territori di confine rivendicati dai vari potentati: si inseriva in situazioni complesse come un arbitro, una figura temuta ma rispettata e autorevole. Anche Teodoro II Paleologo, marchese di Monferrato, quasi coetaneo e a lungo finanziatore del condottiero, dovette accettare l’ambiguità della situazione.
Nel disegno di formazione del suo Stato, perseguito dal 1403 al 1412, Facino – nobilitato dalla titolatura di “Conte di Biandrate” – aveva previsto che Alessandria e Pavia rappresentassero le due località di riferimento per amministrare un territorio esteso dalle coste del Lago Maggiore all’Oltregiogo.
Facino disponeva non solo di un suo esercito – la cui entità poteva variare da poche decine di uomini alle migliaia che, ad esempio, lo accompagnarono nell’impresa su Genova del 1409 – ma di un impianto amministrativo composto da notai, contabili, legali, che lo aiutavano nella gestione di un consistente e sempre crescente patrimonio, formato non solo da “denaro” ma anche da immobili, come risulta da diversi contratti di acquisto che, diversamente da altra documentazione “misteriosamente” scomparsa, sono stati reperiti in alcuni archivi.
Dopo la morte di Facino Cane – avvenuta nel marzo 1412 nel castello di Pavia – Alessandria non dovette apprezzare particolarmente il ritorno al completo controllo visconteo. Infatti, nel gennaio 1415 offrirà le “chiavi della città” a un altro illustre monferrino: il marchese di Monferrato Teodoro II Paleologo, già capitano di Genova.
Restano tracce della presenza di Facino in Alessandria? A mio avviso sì, e in bella evidenza.
Presso la sala conferenze di Palatium Vetus (restituito alla cittadinanza dalla benemerita opera della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria presieduta da Pier Angelo Taverna) possiamo ammirare in un affresco, collocato sull’arco della seconda colonna di destra, la curiosa raffigurazione di un cane, in atteggiamento evidentemente ostile, collocato come cimiero per un elmo chiuso, il tutto posto al di sopra di uno scudo scaccato di nero e di argento.
Il disegno del levriero mi ha suggerito un collegamento dello stesso con Facino. Infatti, esaminando la bandiera del condottiero appare evidente come si tratti dello stesso cane, in altre parole di quel levriero che, come nella raffigurazione della bandiera, indossa un collare ed è presente anche sul sigillo del capitano di ventura.
Lo scudo appartiene alla famiglia bolognese Pepoli e, in particolare, al conte e capitano di ventura Taddeo Pepoli, che fu governatore e podestà di Alessandria dal 1374 all’ottobre 1375. Come precedentemente ricordato, Facino fu governatore di Bologna in nome di Gian Galeazzo Visconti. I Trotti, rientrati in Alessandria, dopo la morte di Facino Cane, commissionarono l’affresco che ricordava: Trotti Andreino (le lettere T e A) e il bolognese Taddeo Pepoli la cui famiglia era stata cacciata da Bologna, nel 1403, da Facino Cane e, proprio ad una “vendetta postuma”, si riferirebbe il braccio che nell’affresco tiene “al guinzaglio” il condottiero. Quale altra motivazione avrebbe giustificato una rappresentazione pittorica collegata ad una fugace podesteria di un bolognese se non la comune “tirannia” di Facino Cane subita da entrambe le città?
Girolamo Ghilini
Annali di Alessandria, Milano, 1666, pagg.49/50
Mentre Guglielmo era impegnato in campagna contro i Visconti, i Guelfi Alessandrini, in parte indotti da odio e malevolenza verso il marchese, in parte stimolati dagli astigiani, deliberarono con l’occasione opportuna della sua assenza di levare dal collo della patria il duro e insopportabile giogo della sua servitù e della sua tirannia, per ridurla alla primigenia, antica libertà. Perciò, collegatisi con alcune città vicine che molto aborrivano il tirannico dominio del marchese, operarono in modo che tutto il popolo alessandrino, sollevato con gran tumulto, pigliò coraggiosamente le armi e, con l’aiuto che da ogni banda gli fu dato dai confederati, i quali speditamente in buon numero, chi a piedi chi a cavallo, conversero in Alessandria, si pose all’ordine per uscire in campagna. E, perché alla perfezione di così valoroso e potente esercito altro non mancava che un generale, fu fatto in necessità così grande e in occasione di tanto rilievo, con voto e consenso universale dei soldati, Alberto Guasco d’Alice, uomo con gran pratica d’armi, d’esperienza e in particolare molto amato da quasi tutta la città di Alessandria sua patria.
Con quel ben unito e ordinato esercito entrò egli animosamente nel Monferrato, saccheggiando e ruinando il tutto con ogni libertà militare; onde il marchese, sbigottito e quasi abbandonato da se stesso, lasciò da parte tutti i negozi e con la sua soldatesca, la quale era assai in buon numero, inviossi con gran prestezza verso Alessandria. Frattanto, gli alessandrini che di già con l’esercito erano arrivati alla terra di Castelletto, alla nuova della venuta del marchese fecero alt per poco spazio di tempo; dipoi, essendo molto desiderosi di combattere, non vedevano l’ora di far giornata col nemico e perciò andarono con gran coraggio ad incontrarlo. Affrontatisi presso la terra di San Salvatore ambedue gli eserciti, fu con tanto animo e ardire dagli alessandrini cominciata la battaglia che il marchese, dopo aver, valorosamente combattendo, sostenuto un pezzo il loro impeto, sopraggiunto dalla gran quantità dei collegati fu costretto a voltar le spalle alla scaramuccia e ben presto sopra di un cavallo fuggirsene.

Guglielmo VII
Ma subito il generale Alberto, seguitandolo con una spedita e animosa squadra di cavalleria, dopo aver posto in rotta e ruina tutto l’esercito nemico, alli 10 del mese di settembre, vivo lo fece prigione, trattenendolo con una collana d’oro che gli gettò al collo mentre fuggiva e legato con una catena di ferro lo condusse vittorioso e trionfante in Alessandria, dove fu dato in stretta custodia finché fu fatta una sotterranea cassa, foderata d’intorno di tavole, nella quale due giorni dopo la sua prigionia fu miseramente rinchiuso.
E’ opinione che quella cassa fosse fatta dove adesso si vede il palazzo dei governatori di questa città, nel qual luogo era in quei tempi fabbricato il pretorio.
07. Verso la contemporaneità; ‘800 e ‘900
Introduzione
Un titolo così impegnativo sembrerebbe suggerire l’esigenza di affrontare l’approfondimento di questi ultimi due secoli congiuntamente, attraverso una complessa lettura di ciò che vi avviene guardando alle cose alessandrine. Da una parte Napoleone, la battaglia di Marengo e i moti piemontesi del 1821; dall’altra, le vicende più interne alla città, arrivando, via via, ai bombardamenti della 2^ guerra mondiale, all’alluvione del Tanaro e all’Università.
Per la verità, abbiamo anche provato a seguire questo itinerario, ma ci siamo presto accorti che, se da un lato lo svolgimento di alcuni di questi avvenimenti si esaurisce all’interno dell’uno o dell’altro secolo, molti altri non si lasciano facilmente rinchiudere in un secolo, ma tracimano dall’uno all’altro. Così abbiamo modificato registro espositivo, iniziando dai fatti salienti dell’800 e chiudendo con quelli relativi al ‘900, ma inserendovi in mezzo avvenimenti che iniziano in un secolo e proseguono nell’altro, Alcuni dei quali, certamente, destinati ad una presenza anche successiva, ancora tutta da vedere e da scrivere.
In questo modo, comunque, confidiamo di aver fornito al lettore una disamina coerente ed esaustiva degli avvenimenti in questione. Per cercare di ottenere questo risultato, abbiamo approfittato della competenza e a volte della pazienza di tutti coloro che ci hanno consentito di raggiungerlo, cui va da queste pagine il nostro ringraziamento più sincero.
Procedendo nella raccolta dei loro contributi, però,è apparso sempre più evidente come, dopo un ‘900 da protagonista, Alessandria sia andata via via smarrendosi, perdendosi nelle secche di un’inazione che perdura tuttora e chiudendosi in se stessa, incapace di inserirsi nei grandi circuiti di sviluppo che le sono passati solo accanto, relegandola a un ruolo di marginalità. Basta pensare allo stato dello smistamento ferroviario, una volta secondo solo a quello di Bologna, oppure alle tristi vicende del teatro, che sembra ormai perduto, e a quelle della Borsalino, ben evidenziate dall’abbattimento della sua famosa ciminiera.
Che dire poi dell’alluvione? Qui, nel 1994, sembra metterci la coda anche il diavolo. In una città già depressa di suo piomba un’inondazione di un’entità mai vista. L’acqua scende a valanga su interi quartieri, quelli più vicini al Tanaro, anche se tracima pure la Bormida. Un disastro che pesa ancora.
Insomma, non ce n’è andata bene una. Ma riuscirà Alessandria a fare un passo avanti, migliorando i suoi fondamentali? Per Alessandria c’è ancora spazio e – magari – un pizzico di gloria?
Speriamo di sì, però non tocca a noi dirlo. Noi abbiamo appena concluso un lavoro da storici. Gli storici non cambiano la storia. Questo tocca ai politici e noi, davanti a loro, ci ritiriamo.
Comunque, eccovi i testi. Così, potrete giudicare da soli.
Jacques Marquet, Signore di Norvins
La battaglia di Marengo, Fratelli Fabiani, Bastia, 1834
Melas, che teneva il suo campo fra il Po e il Tanaro … aveva richiamato da San Giuliano il generale Ott, che partendone lasciò una semplice retroguardia a Marengo, piccolo borgo, celebre però nei fasti militari della Francia. Il 12 giugno, l’esercito francese … fiancheggiava la Scrivia. La divisione Lapoype aveva ordine di raggiungere Desaix …
Il resto delle nostre forze, sparse sui vari punti della Lombardia, serviva a bloccare e contenere i diversi corpi austriaci. Il quartiere generale si trovava a Voghera. Era il primo console nell’aspettazione d’incontrare l’esercito dell’Austria nelle pianure di San Giuliano. Il 13 le traversa senza resistenza, e fa scacciare da Marengo cinquemila uomini dal generale Gardanne, che gl’insegue fino alla Bormida, ma non può guadagnare la testa del ponte. Noi prendemmo la posizione fra questo fiume e Marengo, alla Petrabona.

Napoleone con gli uomini di Desaix, dopo la morte del generale
Dovemmo naturalmente credere che Melas non fosse disposto alla battaglia, allorché abbandonava gli sbocchi di Marengo, così facili a difendersi, e che dirigeva sul fianco le sue operazioni tanto sopra Genova, dove gl’inglesi avrebbonlo senza ostacolo provveduto di tutto, che sopra l’Alto Ticino dov’egli avrebbe stabilito i suoi punti di comunicazione coll’Allemagna, e finalmente sopra ambe le rive del Po, dove con facilità avrebbe potuto aprirsi un passaggio e una marcia.
Ma Bonaparte, che ha il dono di discernere tutte l’eventualità al primo colpo d’occhio, manda le due divisioni Desaix a Castel Nuovo di Scrivia e a Rivalta per osservare le ali dell’esercito nemico e concentrare i corpi di Lannes e di Victor fra San Giuliano e Marengo. Sono queste divisioni, disposte per gradi paralleli onde tenersi in guisa tale pronte a tutti i movimenti che potrebbero divenir necessarii, e perché così ogni divisione di ala possa divenire al bisogno testa di colonna.
Il corpo di Boudet, situato a Rivalta sotto gli ordini di Desaix, doveva comunicare al corpo di Massena e di Suchet, che si erano indirizzati sopra Acqui. Il dì seguente, 14, il primo console rimase attonito di vedere, a quattr’ore del mattino, l’esercito austriaco sboccare pel lungo passaggio della Bormida e per le paludi che sono in quei dintorni. Cinque ore appresso soltanto potè esso avanzarsi in tre colonne, ed era composto di quarantamila uomini all’incominciamento dell’azione quando il nostro ne contava appena ventimila per la maggior parte coscritti. L’esercito che comandava Melas era interamente formato di vecchi soldati. Il corpo di Victor, essendo stato vigorosamente attaccato e respinto indietro, entrò in linea quello di Lannes dalla parte dritta e, dopo alcuni vantaggi, fu costretto di seguir la sinistra che ritiravasi.
Ma il punto più importante dell’azione che doveva decidere della giornata era per Bonaparte di sostenere la sua diritta e per Melas di respingerla. Il primo console, conoscendo che il favorevole evento della battaglia dipendeva dalla comunicazione che la sua diritta assicurava col resto dell’esercito, fece prontamente avanzare nel mezzo della pianura quella vecchia guardia, stata per lungo tempo il terrore dell’Europa, ma che, giovine allora, fè datare la sua gloria dalla giornata di Marengo.
La posterità conservò a lei quel bel titolo di baluardo di granito che il vincitore stesso le conferì. Gli assalti più terribili dell’inimico vani sono contro l’immobilità di quell’eroica legione; la sua valorosa resistenza accorda il tempo alla divisione Monnier di giungere: spinse questi una schiera in Castel Ceriolo e l’esercito francese trovassi in un ordine quasi inverso a quello della mattina, per gradi regolari, l’ala diritta innanzi, ferma mai sempre al punto essenziale della prima linea di battaglia, coprendo la sua comunicazione più importante e occupando colla sua sinistra il cammino per Tortona.
L’azione si mantenne in questo stato sino all’arrivo della divisione Desaix. Melas, al contrario, aveva indebolito la sua sinistra per accrescere la sua diritta, che inutilmente estendevasi sino a Tortona. Previde il primo console tal movimento, con quella solita sua abilità nel penetrare i disegni dell’avversario sul campo di battaglia. Erano già cinque ore e la divisione Lapoype non compariva; ma giunse Desaix sul campo di battaglia alla testa della sola divisione Boudet. Nelle mani di Bonaparte rinforzo simile andava a divenire lo strumento della vittoria e l’esercito ha già penetrato il pensiero del suo capo. Stanco da una lunga e sanguinosa ritirata, esso vede con l’istinto di una aspettativa, che il suo eroe non ha giammai tradito, le soldatesche di Desaix coprire la sua sinistra e, da ciò incoraggiato, ripete con gioja il grido dell’attacco generale ordinato sopra tutta la linea. Il generale Zach, che oltrepassa quella degli Austriaci, s’inoltra sulla strada maestra con una colonna di cinquemila granatieri, incanutiti nelle battaglie.
Desaix, il bravo Desaix, corre ad incontrarlo con quindici pezzi di cannone e cade colpito da una palla che lo rapisce alle speranze della Francia e all’amore dei soldati. Per un rapporto stranissimo di fatalità, nel momento medesimo l’illustre Kléber, suo amico, spirava nel Cairo sotto il pugnale di un assassino. Ormai non restan più celebri guerrieri, oltre a Bonaparte, che Moreau e Massena. Il coraggio di Desaix sopravvive nella sua divisione, la quale vuole con memorandi fatti illustrare la morte del suo capo; gettasi con incredibile furore sul nemico cercando vendetta e vittoria. Nondimeno Zach resiste quantunque solo in mezzo a quella vasta pianura; ma il giovine Kellermann corre rapidamente colla sua cavalleria ad attaccare il fianco sinistro della colonna invincibile, la disordina, la sparpaglia e i cinquemila granatieri che la compongono vengono in nostro potere.
Sino da questo istante Desaix è largamente vendicato, la nostra linea vola in avanti e ha riconquistato in meno di un’ora il terreno disputato con tanta pertinacia sin dalla prima aurora. L’esercito nemico, attaccato alle spalle, fugge precipitosamente. Melas tenta invano di sostenersi in Marengo; la sua infruttuosa difesa contribuisce a dare il nome di questo villaggio, prontamente preso da Bonaparte, alla famosa battaglia che cangiò la sorte dell’Italia, quella della Francia e dell’Europa intera. I Francesi inseguono gli austriaci fino a dieci ore della sera e non si arrestano che alla Bormida: cinquemila morti, ottomila feriti, settemila prigionieri, trenta cannoni e dodici bandiere sono i trofei della battaglia di Marengo.
La dimane, allo spuntar del giorno, Bonaparte fece attaccare la testa del ponte della Bormida; ma, contro ogni credenza, l’inimico dimanda di aprir trattative! Qualche ora dopo i generali Berthier e Melas hanno concepito la famosa convenzione d’Alessandria, in forza di cui rientra in nostro dominio tutto ciò che in Italia avevamo perduto in quindici mesi, tranne la città di Mantova.
AA. VV.
I moti del 1821, testo tratto da Disco Net
Dopo la caduta di Napoleone le potenze vincitrici, riunite in congresso a Vienna, si impegnarono a ristabilire in Europa le autorità e gli equilibri presenti nel continente prima della rivoluzione francese e dell’impero napoleonico; il principe di Metternich e gli altri plenipotenziari presenti al congresso presero tutte le misure necessarie per far dimenticare ai popoli europei i venticinque anni di rivoluzione e per prevenire un’analoga situazione in futuro. In Francia e in Spagna i sovrani assoluti ripresero il loro posto: Luigi XVIII in Francia e Ferdinando VII in Spagna. In Italia, l’Austria reintroduceva la propria sovranità nel lombardo-veneto, mentre nel Regno di Sardegna e nel Regno delle Due Sicilie le popolazioni locali dovettero subire le tendenze reazionarie dei rispettivi sovrani.
In apparenza l’ordine sembrava ristabilito, ma nella realtà, nelle menti degli intellettuali e del popolo, gli ideali e i nuovi pensieri introdotti dalla rivoluzione francese non si erano affatto sopiti. Tra i liberali iniziarono a prendere forma delle società segrete, un sistema di lotta già presente nel secolo precedente, ma che assunse grandissima importanza nell’Europa post-congresso di Vienna. Queste società segrete altro non erano che delle libere organizzazioni alle quali aderirono uomini di cultura, giovani, militari, borghesi e anche artigiani, che si riunivano per discutere di politica all’insaputa delle autorità. Gli affiliati a queste società utilizzavano riti e segnali particolari del tutto simili a quelli in uso presso le professioni e i mestieri. Esse erano numerose e di diversa tendenza, ma la cosa più importante era che queste associazioni erano unite fra loro da una fittissima rete di contatti interni, il che permetteva lo svilupparsi di un comune pensiero democratico clandestino. La più importante e diffusa delle società segrete del periodo della Restaurazione fu indubbiamente la Carboneria, così detta perché i suoi affiliati utilizzavano i simboli e i rituali della professione dei carbonai: essa propendeva per un ideale democratico-costituzionale di tipo moderato e fu maggiormente attiva in Italia e in Spagna e ebbe un ruolo fondamentale durante i moti rivoluzionari del 1820-21.
Il primo evento di grande rilievo accadde in Spagna l’1 gennaio del 1820: reparti dell’esercito spagnolo, mobilitati per andare a sedare alcune sollevazioni popolari nelle colonie americane, si ammutinarono nel porto di Cadice durante le fasi di imbarco. Questi reparti, seguiti poco dopo da numerosi altri reparti militari, si opposero al regime repressivo instaurato da Ferdinando VII fino a rendere inutile ogni opposizione regia. Il re si vide costretto a reintrodurre la Costituzione e a concedere ai rivoltosi una camera elettiva.
Gli avvenimenti spagnoli segnarono l’avvio di una serie di ribellioni in tutta l’area del Mediterraneo e la Carboneria mobilitò tutti i suoi soci italiani e spagnoli affinché sobillassero le popolazioni.
Pochi mesi dopo la rivolta militare, in Spagna, in Portogallo e nel Regno delle Due Sicilie scoppiarono le sollevazioni popolari che in breve costrinsero i relativi sovrani a concedere a loro volta una Costituzione.
In questi casi la costituzione fece molta fatica a rimanere salda per la ferma opposizione del re, per gli interventi di Metternich tendenti a salvaguardare l’equilibrio raggiunto al termine del Congresso di Vienna, ma soprattutto a causa degli scontri interni tra i moderati e i democratici. La Sicilia, desiderosa di affrancarsi dal Regno di Napoli, dopo essersi rivoltata con l’appoggio del popolo si trovò sola a dover affrontare la durissima reazione napoletana: dopo una breve resistenza, la rivolta venne sedata e molti patrioti siciliani persero la vita. Questo evento non fu sufficiente a calmare le speranze dei liberali lombardi e piemontesi che, con il sostegno della Carboneria, stavano progettando la cacciata degli austriaci dal suolo italico. I piani sovversivi dei lombardi vennero però scoperti e i carbonari Silvio Pellico e Pietro Maroncelli vennero catturati e condannati da un tribunale militare al carcere duro da scontare nella fortezza dello Spielberg, il famigerato carcere punitivo che si trovava nella città di Brno, nell’attuale Repubblica Ceca.

Silvio Pellico
Diversi furono invece gli avvenimenti in Piemonte, dove i moti ebbero inizio nel mese di marzo del 1821 e portarono all’abdicazione del re Vittorio Emanuele I in favore del proprio fratello Carlo Felice, in assenza del quale assunse la temporanea reggenza Carlo Alberto, da tempo in contatto con le società segrete, il quale concesse una Costituzione simile a quella spagnola. Richiamato all’ordine dallo zio Carlo Felice, legittimo re di Sardegna, Carlo Alberto assunse il comando delle truppe piemontesi sconfiggendo a Novara i volontari liberali comandati da Santorre di Santarosa.
Nonostante la loro fragilità e il fallimento, i moti rivoluzionari scoppiati in Spagna, Italia e Portogallo risvegliarono la preoccupazione delle potenze conservatrici del Congresso di Vienna che, su suggerimento del ministro austriaco principe di Metternich, decisero di passare alla controffensiva: il 23 marzo del 1821 l’esercito asburgico raggiunse il regno delle Due Sicilie sedando la rivolta e restituendo il trono al legittimo re Ferdinando I, che per vendetta adottò durissime forme di repressione. Nel frattempo la sommossa veniva domata anche in Portogallo, dove il re ordinò l’esecuzione di moltissimi rivoluzionari.
I moti rivoluzionari del 1821 ebbero come scopo principale l’ottenimento di una Costituzione, obiettivo non raggiunto principalmente a causa del modo troppo duro e deciso che i liberali adottarono per proporsi nei confronti dei sovrani e che portò a una contrapposizione di mentalità insolubile.
Guglielmo Schiavina, Carlo A. Valle
Andrea Vochieri, Annali di Alessandria, Alessandria, Stamperia Barnabè e Borsalino, 1861
Dopo aver svolto gli studi classici nella città natale si iscrisse all’Università di Torino, dove si laureò in legge. Tornato ad Alessandria, cominciò ad esercitare l’attività di avvocato. Entrato in contatto fin dai tempi dell’università con esponenti delle idee liberali di stampo mazziniano, cominciò ben presto a manifestare le proprie idee, partecipando attivamente ai moti del 1821. Costretto ad abbandonare gli stati sabaudi, si rifugiò a Barcellona.

La casa natale di Andrea Vochieri
Rientrato in Italia nel 1823, in seguito aderì ancora più approfonditamente alle idee mazziniane, entrando a far parte della Giovine Italia sin dalla sua fondazione. Scoperta la sua attività di proselitismo, rivolta in particolare alle truppe dell’esercito della Regia Armata Sarda, fu arrestato il 1º maggio 1833. All’interno della Cittadella di Alessandria vi è la cella dove venne rinchiuso, dotata di catene per i piedi attaccate al muro. Sottoposto a un processo sommario, nonostante fosse un civile, fu giudicato da una corte marziale e condannato alla pena capitale mediante fucilazione il 20 giugno. La sentenza venne eseguita due giorni dopo.
Il suo testamento spirituale fu una lettera trovata nella sua cella, che diceva:
| “Miei figli, questo è l’unico tesoro che vi lascia vostro padre prima di morire per la sua patria. Moglie mia, conserva questo scritto ad eterna memoria di tuo marito e fa che sia d’insegnamento ai miei figli ed amici. Italiani fratelli, io muoio tranquillo perché, quantunque calunniato e tradito, seppi tacere per non compromettere alcuno dei miei fratelli. Io muoio tranquillo perché non ho voluto riscattare la mia vita dal tiranno piemontese, come mi venne offerto, con il tradimento e con lo spergiuro. Io muoio tranquillo perché vero e costante figlio della Giovine Italia. Infine io muoio o Italiani, imprecando con l’estrema mia voce a tutti i despoti della terra e loro alleati. Infiammatevi a unirvi e a sacrificare il vostro sangue per la libertà, indipendenza e rigenerazione della infelice nostra patria.“ |
Nicola Parodi
Vestigia degli Umiliati in Alessandria
Gli Umiliati in città furono presenti in Alessandria dal 1189 al 1571, data dello scioglimento dell’Ordine. Le capacità e le competenze dell’Ordine contribuirono alla crescita dell’economia locale e permisero agli Umiliati di accumulare ricchezze e assumere molte importanti funzioni nell’amministrazione del Comune.
Potremmo pensare che il motto dello stemma della città “Alessandria umilia i superbi ed esalta gli umili” abbia portato fortuna per lungo tempo all’Ordine. Anche la venerazione di san Baudolino fu incoraggiata dagli Umiliati che, secondo alcune fonti, organizzarono il trasporto del corpo del santo dalla chiesa di santa Maria di Foro in una nuova chiesa in città che fu dedicata proprio a san Baudolino.
La fagia (struttura organizzativa formata da diverse case dipendenti da una casa madre) alessandrina introduce nuove tecniche per la lavorazione dei tessuti e diventa fonte di nuove risorse economiche per la città. Così, grazie alla capacità di mediare e convincere le parti cittadine ad operare nell’interesse di tutti, accresce la propria importanza nella vita comune. I contatti commerciali permettono di fondare nuove case tanto che, nel primo quarto del XIII secolo, dipendono dal preposto alessandrino le case di Acqui, Asti, Casale, Tortona, Alba, la chiesa Opificio di Santa Marta e san Germano a Genova e la chiesa di san Donato a Firenze.
Gli Umiliati sono presenti in Alessandria fino allo scioglimento dell’Ordine, avvenuto nel febbraio del 1571 ad opera dell’unico papa alessandrino: san Pio V. L’opportunità viene fornita da un attentato all’arcivescovo di Milano, san Carlo Borromeo. I beni dell’Ordine sono incamerati dalla Chiesa e, pare, anche utilizzati per finanziare la guerra contro i Turchi culminata nella battaglia di Lepanto.
L’importanza dell’Ordine, oltre che dal ruolo nella politica cittadina e dai numerosi possedimenti nel contado, è testimoniata anche dal possesso di sei chiese in città. Tra queste resta la chiesa attualmente dedicata a san Rocco già intitolata a san Giovanni del Cappuccio. La chiesa, danneggiata durante la guerra di successione austriaca, ha subito interventi di ristrutturazione che ne hanno modificato la struttura originale.

Campanile della vecchia chiesa di san Rocco
Nell’isolato di cui fa parte la chiesa, compreso fra via Lumelli e piazza san Rocco, si trovano i resti dei laboratori medievali e un’ampia sala per le attività manifatturiere nota come Tinaio degli Umiliati. “L’edificio è detto “tinaio” in quanto forse nelle vasche (o tini) avveniva la colorazione dei tessuti “umiliati” che sui mercati europei avevano allora ottimo mercato. Il Tinaio è suddiviso in due navate da pilastri cilindrici con capitelli cubici, smussati alla base, che reggono volte a crociera a spigoli vivi. La struttura risale al secolo XIII e ancora si impone per l’ampiezza di circa 300 mq per la sua solidità e le sue linee severe. Si tratta di un seminterrato, ma con l’inizio a livello strada, a cui si accede da via Lumelli.
In questo locale si svolgeva forse l’operazione della torcitura e, forse, vi erano installate delle “gualchiere” che sfruttando l’energia idrica fornita da una diramazione del canale della Rosta parallela a via Lumelli, eseguivano meccanicamente la follatura dei panni-lana” (da “Alle radici di Alessandria” pubblicato da Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria).
Purtroppo, visitare i resti del Tinaio non è operazione facile perché si trovano nel cortile di una struttura privata e nessuno si preoccupa di rendere fruibile ai cittadini o ai turisti il monumento.
Nell’ottobre 2004 la sezione alessandrina di Italia Nostra ha promosso un convegno dedicato agli Umiliati in Alessandria. Per avere maggiori informazioni è possibile consultare gli atti del convegno a cura di Romeo Cavanna.
La cittadella
Testo originale di Guido Ratti
“C’era una volta in Lombardia – se anziché storia, fosse una fiaba – una città attraversata dal Tanaro e conosciuta come Alessandria della Paglia, unita da un ponte coperto con il ricco e popoloso quartiere al di là del fiume, Borgoglio (fig. 1)
1 – Alessandria agli inizi del ‘600: a sinistra la cittadella spagnola (attuale piazza Matteotti), al centro il ponte coperto sul Tanaro (con i mulini natanti a valle) e a destra Borgoglio colla caratteristica struttura romana da castrum o altomedievale da borgo nuovo (da La Cittadella di Alessandria. Una fortezza per il territorio)
ma un giorno, a causa di una guerra e di una pace lontane un re di fresca nomina mise le mani su Alessandria della Paglia ”[1] e nulla fu più come prima: Vittorio Amedeo II di Savoia non si accontentò delle chiavi della città e del solito Te Deum in Cattedrale col vescovo, decurioni e nobiltà tutti in ginocchio a giurargli fedeltà. Il rituale consueto non bastava perché l’Alessandrino (con Valenza e il Monferrato, la Valsesia e la Lomellina) rappresentava il primo passo significativo verso quella pianura padana cui i Savoia miravano dal 1563, quando Emanuele Filiberto aveva trasferito la capitale da Chambéry a Torino: in questo contesto storico e geopolitico – e per un monarca certo che la potenza dello stato consistesse soprattutto nel numero e nelle dimensioni delle sue fortezze – Alessandria, incrocio chiave delle comunicazioni est-ovest e sud-nord nell’Italia nordoccindentale, aveva un valore simbolico almeno pari a quello strategico. Per questo occorreva “marchiare” la nuova “proprietà” con fortificazioni che oltretutto trasmettessero all’esterno l’immagine di uno strato ricco, efficiente, determinato.
Il passaggio di Alessandria sotto casa Savoia nel 1713 dopo sette anni di occupazione, fu ben più traumatico di quanto la storiografia alessandrina abbia lasciato e lasci trapelare. Innanzitutto perché legami e vocazioni economici delle origini (cioè con Milano e, in misura minore da metà del ‘500, con Genova) venivano troncati irreversibilmente; in secondo luogo perché la denominazione “Territori di nuovo acquisto” comportava di fatto l’esclusione dalle alte cariche dello stato monopolizzate dalla nobiltà degli “antichi regi stati”; e infine perché da un sistema di autonomie locali di impronta feudale si passava coi Savoia in un complesso statale fortemente accentrato che proprio nei “Territori di nuovo acquisto” sperimentava quel percorso di ammodernamento strutturale che si sarebbe concretato con le Regie Costituzioni e con il Catasto sabaudo. Ma il trauma più evidente inferto ad Alessandria dal cambio di “padrone” (e il più incisivo sul lungo periodo), fu il vulnus urbanistico – inedito e per fortuna unico nell’Europa moderna – che cancellò la morfologia originaria e la struttura socio-economica della città a cavallo del fiume per costruire la più grande fortezza di pianura del continente.
Nel primo ‘700 l’abitato di Borgoglio costituiva – per estensione e per popolazione – grossomodo un terzo della città più popolosa del Piemonte dopo Torino. Secondo i responsabili sabaudi delle fortificazioni Ignazio Bertola e Francesco de Willencourt incaricati di periziare le opere di difesa stanziale nei territori di nuova acquisizione, la cinta di Alessandria e Borgoglio era in pessime condizioni e talmente ampia da rendere eccessivamente oneroso il loro ripristino e adeguamento: fra le diverse opzioni prospettate dai suoi ingegneri, Vittorio Amedeo II nel 1728 optò per il progetto innovativo di Ignazio Bertola (fig. 2) che – per non violare gli impegni assunti con l’impero d’Austria – mascherava la trasformazione in fortezza come potenziamento degli argini per difendere il borgo dalle piene del Tanaro. Dopo quattro anni occorsi per l’elaborazione dei progetti esecutivi e la soluzione dei numerosi problemi tecnici, per i primi espropri e per gli appalti, nel 1732 iniziarono i lavori con il Bertola in veste di progettista e supervisore e il Willencourt in loco come responsabile operativo.
2 – Alessandria e la Cittadella intorno al 1728 (da Una Cittadella per l’indipendenza) in una china conservata nell’ISCAG e attribuita a Bertola in cui appare per la prima volta il progetto della fortezza. All’interno della cinta di Borgoglio sopravvissero almeno un paio di chiese e una parte di palazzo Guasco con alcuni civili che sarebbero stati espulsi solo a fine secolo dai francesi.
Pur essendo leggibili matrici riconducibili a Vauban, de Coehoorn, Rossetti e allo stesso Bertola padre – il progetto bertoliano (fig. 2) abbandonava il principio delle geometrie regolari osservato dai predecessori per adattare la forma della cinta all’ansa del Tanaro in un esagono ellittico strutturato in modo che il nemico proveniente da occidente (cioè dall’interno del Piemonte) non potesse mai puntare direttamente sul fronte verso la città perché coperto dal fiume mentre le porte interna ed esterna sulla strada d’Asti erano coperte da una via di collegamento a zig-zag, all’occorrenza allagabile, controllata su ogni centimetro dal fuoco degli assediati. Nel contesto progettuale e nei contrasti tra ingegneri e architetti che si susseguirono per quasi tutto il ‘700 tanto su problemi e soluzioni tecniche di dettaglio, quanto su questioni di fondo (come la localizzazione del perno delle difese stanziali sabaude nel quadrante sud-orientale del Piemonte) è sempre passata sotto silenzio – anche sul piano storiografico, prevalentemente gestito da storici militari o delle architetture militari – la funzione meramente simbolica della nuova fortezza: cioè il fatto che la localizzazione della Cittadella sulla sponda sinistra del Tanaro – da questo difesa e al tempo stesso separata dalla città – discendeva da logiche e considerazioni conservative tipiche dell’ars pugnandi settecentesca che prescrivevano la resa onorevole, ovvero senza conseguenze sullo stato di servizio dei comandanti, alla prima breccia. Frapponendo il fiume e la città tra la fortezza ed il nemico, prevedibilmente proveniente dall’esterno del Piemonte cioè da oriente, si complicava alquanto la vita di quest’ultimo, rallentandone i movimenti e vanificando posizionamento e efficacia delle sue artiglierie di assedio. Tale posizione costituiva inoltre, in caso di tumulti o rivolte in città o nel contado, un rifugio sicuro per i soldati e per le autorità sabaude (come avverrà durante i moti del 1821).
Mentre gli abitanti di Borgoglio si ricollocavano tra San Michele, Valmadonna, Valle San Bartolomeo e nella zona degli Orti – l’esodo si protrasse fino a fine ‘700 perché le casse statali avevano diluito nel tempo espropri e indennizzi -, iniziavano le demolizioni nelle aree perimetrali e la conversione di diversi edifici in magazzini e strutture di servizio per muratori, carpentieri, tecnici e militari addetti all’elevazione della cinta verso la campagna; sul Tanaro si iniziò con la costruzione di un imponente argine in pietra e murature – un vero e proprio molo – a difesa delle piene e dell’erosione del fiume e, secondo Bertola, per consentire l’allagamento dei fossati come ulteriore strumento di difesa. Alle soglie degli anni ’40 le opere esterne erano state completate consentendo alla Cittadella di affrontare la prima (e praticamente unica in circa 300 anni) “prova del fuoco” tra l’ottobre 1745 e il marzo 1746 quando, contestando il diritto di Maria Teresa d’Asburgo al trono d’Austria sostenuto invece dai Savoia, “I Spagneuj unì aj Franseis – A soun staje sout sinch meis – Pr’ fè nen ch’ij Fanfalouch – E peuj vedse astà su’n such – … … – Con la soua gran Armada – A stasio fé i Panada, – A l’an mai voujù bougiè – D andè sout anpò a nufiè – Ai smiava anpò d angrus – D’acoustese al fià di brus – Riservand, ch’ai steis a coeur. – D raspiné da maroudeur – Cula povra Sitadela – Sensa gnanc desverginela.”[2] Comunque non si trattò d’un assedio davvero duro perché i “gallispani” (che volevano indurre Carlo Emanuele III ad abbandonare Maria Teresa d’Austria) una volta occupata la città non sprecarono uomini e mezzi per la Cittadella che, pur ridotta da ultimo senza polvere e munizioni, sotto il comando del governatore Isnardi rimase l’unico baluardo sabaudo in Piemonte: liberata dall’assedio a marzo grazie alla controffensiva austro-piemontese, ebbe un peso senz’altro rilevante nell’esito delle trattative di pace di Aquisgrana che fruttarono a Carlo Emanuele III il Vigevanese fino al Ticino, l’Alto Novarese e Voghera con l’Oltrepò pavese fino a Bobbio.
Benché incompleta, la Cittadella di Alessandria si era quindi rivelata un investimento estremamente redditizio: questo nonostante le inesauribili guerre di ingegneri e architetti militari (Borra, Pinto, Michelotti, Papacino d’Antoni, ecc.) per contendere il primato del Bertola o per assicurarsene la successione; nonostante le perduranti discussioni tecniche e strategiche che perlomeno dagli anni ’70, avevano evidenziato tanto le criticità strutturali (come l’impraticabilità del sistema d’allagamento e l’eccessiva elevazione delle opere interne rispetto al piano di campagna) e il costo proibitivo degli adeguamenti, quanto l’opportunità di uno spostamento del perno delle difese stanziali sabaude ad oriente, a Tortona. Tutto questo avveniva mentre le nuove leve tecniche militari, cogli occhi rivolti alla Prussia di Federico II, iniziavano a dubitare dell’efficacia bellica delle grandi opere di difesa stanziale e ipotizzavano un esercito e una guerra fondati da un lato sulla mobilità e sulla specializzazione delle unità, dall’altro sull’istruzione e sull’addestramento degli uomini. Tra ipotesi, dubbi, pareri e controversie (anche sulla reale importanza delle singole fortezze e sull’opportunità di continuare a rafforzarle) trascorsero oltre vent’anni allo scadere dei quali – nel nuovo contesto disegnato nel 1796 dalla prima campagna napoleonica d’Italia – la Cittadella finì in mano ai francesi per effetto del trattato di Cherasco: per poco però, perché nel luglio ’99, dopo un assedio di soli 3 giorni i francesi capitolarono consegnando la fortezza al generale Bellegarde comandante dell’offensiva austro-russa. Breve la prima occupazione francese, brevissima – neanche un anno – quella degli imperiali che restituiranno Alessandria e la sua fortezza a Napoleone all’indomani stesso della battaglia di Marengo.
Dire che con l’età napoleonica per Alessandria cambiarono quasi tutte le funzioni e le coordinate può sembrare un’ovvietà, ma non lo è se si considera che Piemonte e Liguria in questi tre lustri scarsi non furono più suolo d’Italia, bensì XXVII e XXVIII Divisione militare della Grande Nation, e non stato satellite come il resto della penisola; se si considera che Alessandria fu sede del Dipartimento di Marengo con legami diretti con Parigi e non più con Torino; se si considera che ad Alessandria spettò il ruolo di chiave nevralgica (magazzino doganale e centro smistamento merci) del nuovo asse economico Savona-Milano, del collegamento cioè tra Francia meridionale e Viceregno d’Italia che nei progetti del prefetto di Savona Chabrol de Volvic avrebbe dovuto abbinare un percorso stradale terrestre e ad una via d’acqua con un sistema di chiuse per superare l’Appennino fino ad Alessandria; se si considera che l’esagerata fortezza di Bertola nata per esternare le ambizioni dei Savoia, nella visione strategica imperiale doveva crescere ancora fagocitando labitato civile per diventare la porta sud-orientale della Grande Nation, una sterminata fortezza da 100.000 e più uomini; se si considera che in Cittadella venne aperta una scuola per ufficiali d’artiglieria e del genio dove insegnò Giovanni Plana; se si pensa che per effetto di questi progetti l’insediamento urbano di Alessandria avrebbe dovuto spostarsi un po’ più a est, per rinascere come Ville des Victoires più o meno sull’area dell’antica curtis regia carolingia di Marengo …..
Non si trattò solo di progetti rimasti sulla carta. A livello di infrastrutture (bonifiche e comunicazioni) e di assetti amministrativo e militare in effetti molto andò nella direzione voluta da Parigi anche perché uomini come Chabrol de Volvic a Savona e François de Chasseloup Laubat in Cittadella appartenevano alla cerchia dei più stretti collaboratori e consiglieri di Napoleone (l’uno dalla campagna d’Egitto, l’altro fin dalla prima campagna d’Italia); e molto autorevoli o comunque vicini all’imperatore erano anche alcuni dei prefetti succedutisi a capo del Dipartimento di Marengo come Federico Campana e Jean Pierre Ducolombier.
La Cittadella fu il settore oggetto degli interventi più invasivi e determinanti sul lungo periodo: quelli che avrebbero condizionato insomma la storia alessandrina e in buona misura anche del Regno di Sardegna perlomeno nel XIX secolo. In effetti col ritorno dei francesi la vicenda umana e urbana di Borgoglio – in qualche modo convissuto con la fortezza, pur se progressivamente eroso, nel corso del ‘700 – si concluse: dopo il 14 giugno 1800 non fu più una fortezza in sembianze di quartiere urbano, ma solo ed esclusivamente una fortezza, la Cittadella. Da lì iniziava anche quel processo di delocalizzazione in città dei servizi e delle servitù per la fortezza (magazzini, caserme, ospedali, stalle e fienili, uffici, bordelli, sussistenze diverse, panifici e officine, ospedali, corpi di guardia, ecc.) che avrebbe ridefinito la morfologia urbana e la struttura sociale ed economica di Alessandria dell’800 e del ‘900 fino ai giorni nostri: se la fortezza settecentesca aveva fagocitato un buon terzo della città, con la città-caserma ottocentesca erano gli altri due terzi ad uscirne sconvolti.
Il progetto di fare di Alessandria una piazzaforte paragonabile a Lille, Strasburgo o Metz (e, in chiave offensiva, una base logistica per le operazioni militari nel quadrante italiano e verso l’Europa sud-orientale) derivava dalla tendenza alla dilatazione dei sistemi di difesa stanziale tipica ancora nell’800 delle scuole del genio e delle fortificazioni francese e sabauda. L’ipotesi di far fronte ad attacchi da est come da ovest indusse Chasseloup non solo ad ammodernare e a sviluppare la Cittadella sabauda, ma anche a coprire Alessandria con una nuova e più larga cinta fortificata e a ipotizzare la costruzione d’una seconda fortezza pentagonale sul sedime della vecchia cittadella spagnola (Porta Genova). La copertura del complesso difensivo delle due cittadelle sarebbe stata garantita da bacini allagabili derivati dal Bormida a est e dal Tanaro a ovest, mentre una corona di opere avanzate nella campagna avrebbe tenuto il più possibile lontana la linea di fuoco delle artiglierie nemiche (fig. 4 – Le due Cittadelle).
4 – Le due cittadelle (1808) – Il progetto di Chasseloup Laubat (da Una Cittadella per l’indipendenza) oltre al rafforzamento della cinta muraria della città e della Cittadella con opere avanzate, prevedeva la deviazione del Bormida per coprire la nuova Cittadella pentagonale (a destra): una complessa opera esterna oltre il canale avrebbe dovuto fornire un’ulteriore copertura per la seconda Cittadella. Nel disegno (a destra, al centro, cioè a nord) si nota la scomparsa degli Horti occupati da nuovi bastioni e l’enorme complesso di opere distaccate in gran parte realizzate
Le note di un viaggiatore francese passato da Alessandria nel 1806 da sole spiegano come e perché – pur se l’idea della seconda cittadella venne abbandonata nel 1808 – il rafforzamento delle cinte murarie di Cittadella e città, la costruzione di opere esterne e distaccate, l’allargamento della spianata e la progettazione di nuovi sistemi di allagamento (mai tuttavia sperimentati davvero per timore di provocare il collasso dei bastioni) potè procedere con un’accelerazione straordinaria. “Alexandrie est la place la plus forte de l’Italie. On travaille depuis plusieurs années aux fortifications et cette ville sera bientôt le plus sûr rempart de la France. La citadelle en est très étendue. Nous allâmes la voir le 13 mai. Mille huit cent forçats napolitains y travaillent. (… …) Ils se révoltèrent il y a peu de temps et voulurent s’échapper, mais ceux qui parvinrent à sortir furent noyés dans le Tanaro qui passe sous les murs d’Alexandrie. On fusilla les plus coupables”[3].
Quando i francesi erano entrati in Cittadella dopo il ritiro del generale austriaco Melas nel giugno 1800 avevano trovato pronti i quartieri San Tommaso e San Carlo, il Palazzo del Governo e l’Ospedale: quando lasciarono Alessandria nel 1814 s’erano aggiunti la Salle d’Artifices e il Magazzino viveri che andavano a completare tanto le strutture funzionali interne quanto il carré della piazzaforte nella loro forma pressoché definitiva (fig. 5 e 6).
5 – Le fortificazioni di Alessandria e della Cittadella nel 1811 (da Una Cittadella per l’indipendenza).
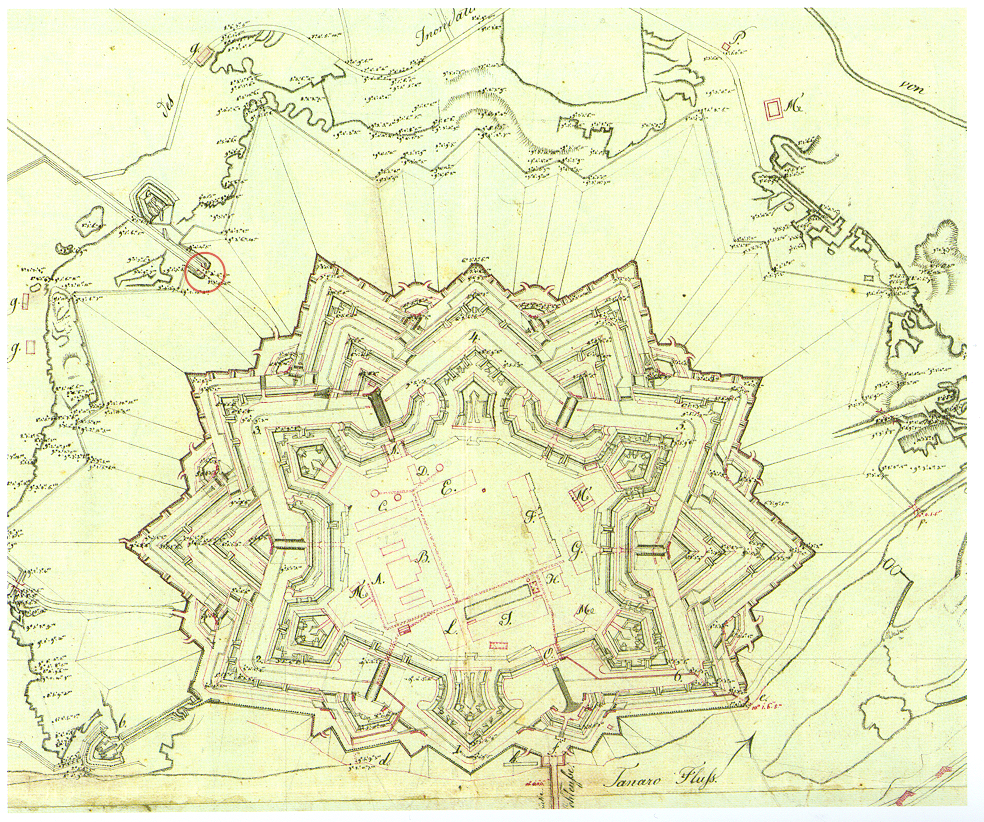
6 – La Cittadella nella Restaurazione in un rilievo austriaco risalente probabilmente al 1815 quando gli Austriaci avevano presidiato per circa un anno la fortezza (da Una Cittadella per l’indipendenza).
I vari quartieri erano in grado di ospitare circa 3000 uomini cui si aggiungevano nell’ospedale un migliaio circa di posti-letto: in più c’erano gli spazi dei grandi sotterranei dell’ospedale verosimilmente utilizzati dai francesi come dormitori per i mediamente 1500-2000 galeotti impiegati come manodopera per le fortificazioni della Cittadella e della città. Non solo: il processo di militarizzazione della città avviatosi consisteva anche nelle limitazioni o nell’erosione degli spazi per gli usi e le attività civili, ma incideva soprattutto nella struttura sociale stessa di Alessandria con una crescita abnorme rispetto al passato di mestieri legati alla fornitura di servizi per il settore militare: carrettieri, lavandaie, sarte, caffettieri, affittacamere, prostitute, ecc. A differenza di quanto era avvenuto nel ‘700 quando diversi viaggiatori pare non si fossero neppure accorti d’essere transitati attraverso una fortezza, ora tutta Alessandria appariva “surely a fortress – a sentire l’inglese Chetwode (1802) – and remarkable only for the sieges which it has sustained”. Per il francese Petit Radel (1811) “on distingue de loin la citadelle, qui depuis près de dix ans a été singulièrement fortifiée. Les forces sont réparties dans tout le contour de la ville; autant il s’en manifeste au dehors, autant il y en a de cachées au-dessous … les rois de Sardaigne, sentant de quelle importance était la conservation d’une pareille place, en rendirent la forteresse très respectable: … trois mille hommes y travaillent journellement; les conscrits réfractaires et les gens de chaîne y roulent la brouette”. E negli anni ’40 neppure i colori vivaci delle mises delle donne della guarnigione per il ballo di Santa Barbara patrona degli artiglieri – segnala un’altra guida francese – riuscivano a dissipare la cupa atmosfera creata dalle “ouvrages redoutables de la forteresse“[4].
L’eredità del periodo napoleonico segnò il destino della piazzaforte nell’800 per diversi motivi. Innanzitutto perché il Regno di Sardegna usciva dal ventennio “rivoluzionario” con un bilancio più che positivo: con l’acquisizione della Liguria era divenuto il secondo stato della penisola per estensione e per popolazione ed era l’unico ad avere conservato il proprio esercito e quindi a poter gestire autonomamente difesa e politica estera: perciò Vittorio Emanuele I, alla conclusione della rentrée imperiale dei 100 giorni nel 1815, ritrovatasi al rientro nei domini aviti una fortezza decisamente perfezionata e potenziata rispetto a quella lasciata nel 1796, non pensò neppure un istante a procedere alle demolizioni peraltro marginali che Vienna pretendeva; al contrario i suoi ingegneri, provenienti dalle scuole del Genio del primo impero, svilupparono idee e progetti almeno in nuce predisposti dai colleghi francesi per far fronte ad un quadro strategico paradossalmente identico perché, come per il primo impero, il nemico dei Savoia era l’Austria. Ed ecco che la Cittadella presidiata dagli austriaci per contrastare ipotetici rigurgiti rivoluzionari o bonapartisti, nel 1815 veniva ad assumere un valore simbolico straordinario: i “regnicoli” in genere (non solo i giovani ufficiali formatisi nelle guerre imperiali ma anche i più vecchi memori del “tradimento” asburgico del 1799) percepirono il presidio difensivo austriaco come umiliante occupazione militare.
Tra la restaurazione e l’unità d’Italia il sistema fortificato di Alessandria (fig. 7) venne gestito dal Genio i cui progetti firmati da Chiodo, Podestà, Sobrero, Bordino, Staglieno, Barabino, Menabrea, ecc., in larga parte rimasti sulla carta anche perché la strategia basata sulle grandi fortezze stava tramontando per i costi della manutenzione e degli ammodernamenti: così i piani di allagamento vennero dichiarati inutili e definitivamente abbandonati solo dopo il 1857): per le grandi piazzeforti di pianura collocate in nodi strategici delle comunicazioni il futuro prevedeva il riutilizzo operativo come basi logistiche. Cioè quello che avvenne per la Cittadella e che spiega tanto le attenzioni per la manutenzione del ponte sul Tanaro quanto l’abbattimento della sua copertura nel 1848 ad opera di un col. Como che “ordinò – narra Pietro Civalieri – che si discoprisse il nostro caro antico e maestoso ponte sul Tanaro… Tutti gli Alessandrini ne furono afflitti, e tutta l’armata rientrando poscia biasimò quell’atto vandalico ed inutile… Il Re stesso se ne rimase dolente“ [5].
7 – Alessandria nel 1851 Nella litografia si vedono le servitù imposte dalla città militare alla città civile: nel circuito murario (lo stesso del sec. XV nonostante la popolazione con oltre 30.000 unità fosse più che triplicata) edifici e isolati in grigio scuro e nero all’interno dell’abitato sono in gran parte pertinenze e servitù militari (cui si aggiungono tutte le case e i terreni a ridosso delle mura oltre le quali l’abitato civile non poté espandersi fino al 1906). La linea nera in alto, fuori dalle mura è la ferrovia mentre nel quadrante basso a sinistra si nota su porta Genova la nuova piazza d’armi al posto della secentesca cittadella spagnola e, sotto, la pianta a X dell’ergastolo da poco costruito.
Una storia sfortunata quella del “nostro caro antico e maestoso ponte sul Tanaro”che – secondo voci ricorrenti nella storiografia locale – sarebbe stato scoperchiato nel 1848 non per le inconsistenti ragioni difensive addotte, bensì per cancellare la vergogna del 9 marzo 1821 quando la copertura aveva celato alle guardie alla porta Reale l’arrivo dei soldati ribelli che le avevano così sopraffatte riuscendo ad impadronirsi della fortezza. A fine ‘800 poi, troppo stretto per le esigenze del traffico militare e di quello civile (la strada per Asti continuava ad attraversare la fortezza come ai tempi di Bertola), il ponte quattrocentesco fu demolito e sostituito a poca distanza da uno nuovo inaugurato nel dicembre 1891: sempre che non si volesse far sparire anche l’ultimo testimone di quel marzo del ’21! Comunque, dopo 100 anni questo nuovo ponte Cittadella (che intanto era riuscito a superare brillantemente diverse alluvioni, bombardamenti e persino l’intensificazione esponenziale del peso di un traffico passato dai modesti carriaggi a trazione animale agli autoarticolati), verrà accusato dalla vox populi d’esser stato la causa prima della terribile esondazione del 1994: la diga che avrebbe costretto il Tanaro ad uscire dall’alveo per allagare i quartieri di Borgoglio, Rovereto e Orti. Dopo una dozzina d’anni l’iter mediatico-burocratico-politico (assai più che tecnico) si concluse con la demolizione del ponte ottocentesco per dare il via al nuovo ponte provvisoriamente intitolato al progettista Meier: ancora un decennio per la costruzione (il vecchio Cittadella ne aveva richiesti solo 3) e infine nel 2016 l’apertura al pubblico che ha comunque lasciato aperte le questioni della sua reale utilità in rapporto sia alla protezione da piene disastrose del Tanaro sia alle esigenze del traffico urbano e suburbano sia al suo discutibile inserimento paesaggistico nel sistema Cittadella.
Chiudendo la parentesi e tornando alle vicende della Cittadella, la trasformazione in base logistica offensiva e difensiva portò alla creazione di un campo trincerato che costituì l’ultimo aggiornamento del sistema di difesa-offesa stanziale alessandrino. L’epoca è il cosiddetto decennio di preparazione: l’età di Cavour, di Vittorio Emanuele II e di Rattazzi, gli anni successivi alla dura sconfitta sabauda nella prima guerra d’indipendenza quando il desiderio di rivincita contro l’Austria era fortissimo. Come nel ’47 l’inaugurazione della villa-castello di Marengo era stata un segnale mediatico fortissimo della volontà del Regno di Sardegna di spezzare lo statu quo imposto da Austria e Francia nella penisola, quest’ultima evoluzione delle fortificazioni d’Alessandria era assai più che un segnale: piuttosto una provocazione diretta e inequivocabile contro l’impero asburgico e la sua permanenza in Italia. Insomma nihil sub sole novum tra il 1728 e il 1859!
La progettazione del campo trincerato – peraltro già dagli anni ’40 s’era avviato il ricupero delle opere più esterne realizzate nell’età napoleonica – doveva risolvere i problemi creati dalla novità strategicamente più rilevante, cioè la strada ferrata Torino-Genova la cui presenza pur facilitando l’invio di rinforzi e rifornimenti costituiva un elemento di debolezza strutturale nel sistema difensivo stanziale dilatando enormemente l’area che necessitava di copertura. Il campo trincerato progettato da Candido Sobrero (fig. 8) prevedeva in una prima versione ben otto forti che, ad una distanza media di 2-3 chilometri dalle mura urbane coronavano la città collegati da una fitta trama di opere staccate minori: il campo realizzato entro il 1859 – l’unico esempio ottocentesco sopravvissuto pressoché integro – in realtà coprì solo il quadrante sud-orientale, cioè quello esposto ad eventuali attacchi dal Lombardo-Veneto austriaco, coi forti: Bormida (a forma semicircolare lungo la strada “Reale di Piacenza” sulla sponda destra del Bormida oltre il ponte); Ferrovia (due forti semicircolari a cavallo della linea Torino-Genova prima del ponte Bormida); e Acqui (a pianta ottagonale nel quartiere Cristo, sulla via Casalcermelli). L’imponente struttura del campo – sperimentato e promosso come base efficiente logistica nel ’59 quando proprio ad Alessandria si assemblò l’armata franco-piemontese – ereditava dalla Cittadella il rango di fortezza di prima classe che conservò sino a fine ‘800, ma che di fatto perse dopo le guerre d’indipendenza del 1859 e del 1866 per lo spostamento del confine al Veneto. Da quel momento non servirono ulteriori potenziamenti: una delle ultime costruzioni ottocentesche, degli anni ’30, è la Palazzina di Cavalleria, cui seguiranno poche aggiunte irrilevanti, mentre gli interventi più invasivi furono quelli del ‘900 quando si aggiunsero nel quadrante occidentale 4 grandi capannoni che segnalavano l’avvenuta trasformazione da base a magazzino logistico e quando le autorità militari alienarono le spianate poi urbanizzate a partire, tra gli anni ’30 e ’50, dal fronte sul Tanaro.
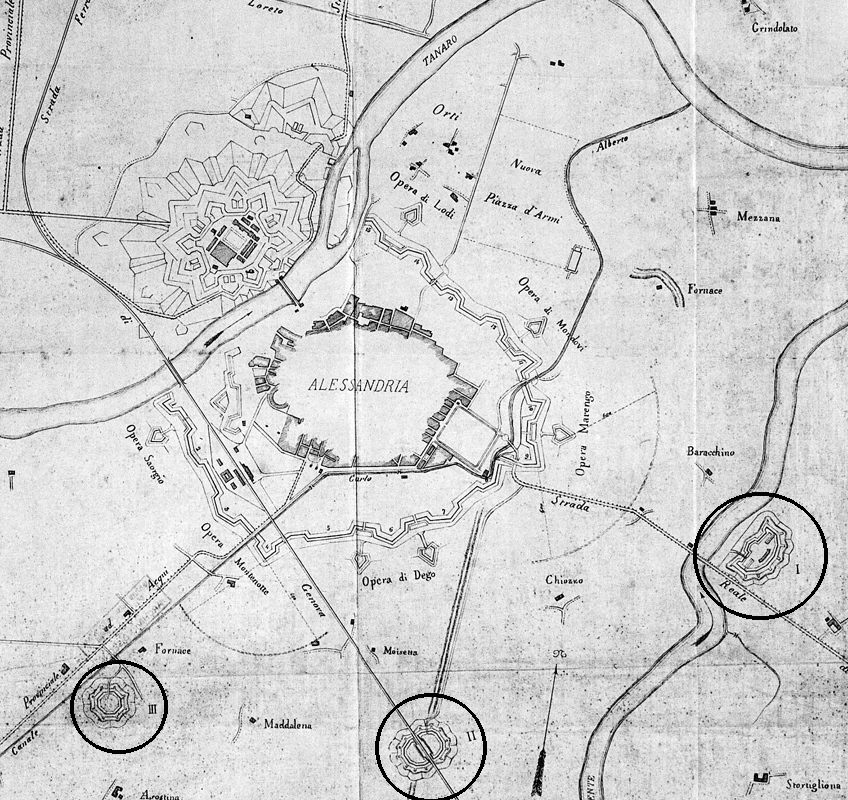
8 – Il campo trincerato nel progetto esecutivo di Candido Sobrero “Piano d’insieme delle fortificazioni d’Alessandria”. Evidenziati da sinistra il Forte Acqui, al centro il Forte Ferrovia e a destra Forte Bormida (da Una Cittadella per l’indipendenza).
Fin qui, parlando del valore simbolico della Cittadella di Alessandria, si è insistito sul messaggio che la fortezza doveva comunicare all’esterno com’era stato fin da principio nelle intenzioni dei Savoia, e s’è solo accennato alla sensazione di occupazione militare che il presidio austriaco nel 1815-16 aveva trasmesso ai “regnicoli” piemontesi. In realtà quel presidio e quella sensazione pesarono non poco sul percorso verso l’Unità d’Italia: in qualche modo la Cittadella, Marengo e Alessandria furono uno di quegli incroci di eventi epocali – l’eterno scontro tra il tedesco Sacro Romano Impero e la libertà della penisola italiana, tra i valori dell’occidente neolatino, carolingio e napoleonico in opposizione a quelli barbarici e autoritari dell’Europa centro-orientale, quanto a dire la ragion d’essere di Alessandria dal medio evo al XIX secolo -, incrocio in cui dal 14 giugno 1800 si andavano incontrando e annodando le linee di crisi della storia europea otto e novecentesca.
Nel primo di questi eventi, cioè nella cosiddetta révolution piémontaise – fase tardiva dei moti costituzionali che percorsero l’Europa tra il ‘20 e il ’21 (e prima ancora) – in genere la scena è occupata da Santarosa, Provana, Moffa di Lisio, Collegno, San Marzano e dalle incomprensioni torinesi con l’italo Amleto quando invece tutto iniziò ad Alessandria nel momento in cui la città militare e la città civile, da sole e insieme, decisero di ammutinarsi per strappare a re Vittorio la costituzione: richiamandosi esplicitamente e per la prima volta ad un’Italia libera e costituzionale, quel tricolore “mandrogno” del 10 marzo 1821 mosse i regi stati deça et dela les monts – da Genova a Fossano, da Savona a Chambéry, da Torino a Nizza Mare – ad accodarsi ad Alessandria, ad entrare nel sogno di militari come Regis, Ansaldi, Palma, Bianco di St. Jorioz o di civili come Rattazzi, Prati, Dossena, Appiani, Vochieri, ecc. Del tutto ininfluente il fatto che in poco più di un mese tutto fosse finito, perché nella Cittadella s’erano subito ripresentati gli austriaci per restarci un paio d’anni: giusto per bloccare sul nascere qualunque discorso di costituzioni o di nazionalità e soprattutto per garantirsi che nell’aquila bifronte asburgica inalberata sulla fortezza, chiunque – non importa se in divisa o in marsina o con la zappa, carbonaro, federato, massone o bonapartista o benestante benpensante moderato – non potesse vedere se non il “giogo” straniero (il cui costo, per inciso, gravò unicamente sulle casse comunali alessandrine).
Consolidatosi nel corso degli anni ’20 per effetto della diaspora degli esuli piemontesi finiti in Spagna a battersi per la costituzione o in Grecia per l’indipendenza, il valore simbolico della Cittadella fu esaltato dalla congiura mazziniana del 1833. La prigionia in Cittadella di Andrea Vochieri e la sua esecuzione (oltre a quelle di 5 ufficiali inferiori e sottufficiali) – un anno dopo la pubblicazione delle Mie prigioni di Silvio Pellico – evocavano, in casa, il carcere dello Spielberg e il martirio di altri italiani per mano austriaca: così la responsabilità della repressione operata in Piemonte fra civili e militari dal regime albertino, nella successiva narrazione patriottica e romantica pur senza assolvere Carlo Alberto finì per gravare soprattutto sulla durezza “disumana” del governatore Galateri e sul sistema poliziesco imposto da Metternich nella penisola. Una quindicina d’anni ancora e il sogno della costituzione sarebbe tornato ad infiammare gli italiani – e non solo loro com’è noto – conducendoli in un conflitto chiuso a Novara il 23 marzo ’49 con una sconfitta cui seguì immediatamente la terza occupazione austriaca della Cittadella in poco più di 30 anni: occupazione brevissima ma non per questo meno importante politicamente perché suggerì – o almeno era questo il messaggio che i più in Italia vollero intendente – che il grandissimo impero austro-ungarico temeva il Regno di Sardegna, la sua grande fortezza e il loro desiderio di rivincita. Desiderio addirittura ostentato negli anni ’50 con i lavori per il grande campo trincerato che comunicavano l’idea che per il figlio di Carlo Alberto, Vittorio Emanuele II, il contenzioso con “Cecco Beppe” non s’era chiuso a Novara: in effetti se dalla via ferrata il viaggiatore poteva godere della vista d’insieme della fortezza, passando per la strada di Torino la percorreva tutta all’interno ed entrava quindi in città accorgendosi d’esser sempre dentro un’unica grandissima struttura militare. All’inizio del 1855 l’assembramento in Cittadella dei 15.000 uomini del corpo di spedizione sardo per la guerra di Crimea trasmise ben oltre i confini del regno sabaudo un’immagine di forza e di coesione tra monarchia, popolo ed esercito che, con il comportamento dei soldati alla Cernaia, consentì a Cavour di denunciare al Congresso di Parigi la brutalità dell’occupazione austriaca nella penisola. Subito dopo, in scenari di guerra sempre meno lontani, si poté misurare l’efficacia del messaggio trasmesso grazie al successo della raccolta di fondi per dotare la Cittadella di 100 cannoni, lanciata da Norberto Rosa attraverso il più importante quotidiano torinese del tempo, la “Gazzetta del Popolo”: “ Trattasi di far “cicare” l’Austria. Ora figuratevi quanto non cicherà essa quando veda che non solo il Piemonte, ma l’Italia tutta, le lontane Americhe e ogni popolo incivilito, portino la loro petra a questo sacrosanto edificio”[6]. La risposta –151.914,21 lire per 127 cannoni – fu immediata così da permettere alle bocche da fuoco nuove di zecca di accogliere il 14 maggio 1859 il comando del Corpo di spedizione francese: anche se le narrazioni storiografica e letteraria nazionale non hanno mai enfatizzato granché questo evento obiettivamente determinante per l’unificazione italiana, il 30 maggio l’imperatore Napoleone III con Vittorio Emanuele II (acquartierato appena oltre i bastioni della fortezza) muoveranno proprio dalla Cittadella per dar l’inizio alla guerra da cui in neppure due anni sarebbe uscito il Regno d’Italia.
Col mutamento del quadro geopolitico dopo le guerre d’indipendenza del 1859 e del 1866 – cioè con l’arretramento del confine orientale di oltre 200 chilometri – sarebbe stato logico attendersi una rapida smobilitazione della città militarizzata ottocentesca chiusa tra la piazzaforte e il circuito invalicabile delle proprie mura (peraltro già sbrecciate dal tracciato ferroviario, da Porta Marengo e in certa misura dalla strada per Torino che passava sempre dentro la fortezza). Invece per ancora trent’anni Alessandria e Cittadella rimasero cerniera dello schema difensivo dell’Italia settentrionale: declassato a deposito logistico nell’89, il complesso restò comunque una base chiave dell’organizzazione territoriale dell’Esercito per poi terminare la sua storia di instrumentum belli tra 1899 e 1905 colla radiazione dalle fortificazioni dello stato delle opere esterne, coll’affrancamento dalle servitù militari di terreni e edifici prossimi alle fortificazioni, coll’alienazione delle spianate e delle mura urbane subito abbattute per creare i grandi viali della circonvallazione. Tuttavia la costruzione su Spalto Gamondio della nuova grande caserma Valfré (ad opera del Comune di Alessandria in cambio di terreni ed edifici all’interno della “cinta magistrale”) se da un lato avviava il risanamento del centro urbano, dall’altro evidenziava l’impossibilità di superare l’impianto socio-economico, urbanistico e persino ideologico della “città militarizzata” ottocentesca: la cui sopravvivenza – coi servizi per l’esercito e coll’industria bellica – in ogni caso costituì per Alessandrina una sorta di ombrello protettivo addirittura superare la grande crisi del 1929. Tornando nella fortezza, se si eccettuano la villetta residenziale (poi centrale termica) e i tre grandi capannoni-officina del secondo dopoguerra, la deviazione della strada per Torino tangenzialmente ai bastioni lungo il Tanaro, la ricostruzione del ponte di Porta Reale distrutto dal bombardamento del 1944 e alcune ristrutturazioni relativamente poco invasive operate dall’Esercito e dal Demanio, la Cittadella – insieme coi fortini del campo trincerato restò sostanzialmente immutata rispetto all’800.
Già utilizzata in età napoleonica come struttura detentiva “ospitando” galeotti destinati ai lavori forzati nelle fortificazioni, e poi nel ’33 come prigione per Andrea Vochieri e i congiurati della Giovane Italia (fig. 9), tra il 1848 e il 1945 venne sporadicamente adibita a prigione militare: nel 1848 per un migliaio di prigionieri austriaci e subito dopo l’Unità per raccogliere prima dell’espatrio i militari degli eserciti preunitari “refrattari” all’incorporazione nell’esercito italiano; campo di prigionia per militari austriaci e tedeschi durante la guerra 1915-18, dopo l’8 settembre 1943 e l’occupazione tedesca, fu campo di concentramento per militari italiani destinati alla deportazione in Germania e prigione di partigiani (6 di loro furono fucilati dietro la polveriera nord all’inizio del 1945). Del periodo bellico va ricordato il bombardamento alleato del 5 settembre ’44 che fece una quarantina di vittime tra i civili.
9 – La cella di Vochieri nel Palazzo del Governatore
Prima della guerra nella fortezza era stato accasermato a lungo il 37° Reggimento di Fanteria che, confluito nella Brigata Ravenna, si distinse in Russia dove fu quasi annientato: al rientro dei superstiti nel maggio ’43 il Reggimento sarà insignito della medaglia d’oro al valor militare. Nel secondo dopoguerra la Cittadella ospitò ancora reparti operativi, ma dagli anni ’60 (nel quadro strategico della ‘Guerra Fredda’ e della modernizzazione dell’esercito) divenne sede del Corpo di Commissariato con funzioni logistiche di magazzino di servizio: cioè le funzioni assolte fino alla terribile esondazione del Tanaro del ’94 quando l’acqua arrivò fin quasi al secondo piano fuori terra e riempì i seminterrati di una spessa coltre di melma non ancora del tutto rimossa. Pur rimessa in funzione dall’esercito nei primi mesi del ’95 con un impegno straordinario, la vulnerabilità alle piene del Tanaro indusse i Comandi militari a trasferire altrove il Centro Rifornimenti per l’alta Italia abbandonando la Cittadella e Alessandria: in una trentina d’anni si concludeva così quel progressivo esodo dalla città della componente militare che lasciava dietro di sé immensi spazi vuoti tuttora da gestire. Per la Cittadella la dismissione dal Ministero della Difesa ed il trasferimento all’Agenzia del Demanio arrivò nel 2007.
L’interesse da parte dello Stato per il suo valore simbolico si era manifestato fin dal ‘43 (col RDL n. 566 del 17 maggio) quando su proposta del Ministero per l’Educazione nazionale, “la storica caserma ‘Maggiore Giuseppe Beleno’ (il Palazzo del governatore) … alla quale si ricollegano molti ricordi del nostro Risorgimento” era stata dichiarata monumento nazionale: nel 1974 il Ministero della Pubblica Istruzione pur confermando l’uso esclusivo da parte dell’Esercito aveva ribadito il vincolo suggerendo ai militari di favorirne la fruizione pubblica. Purtroppo s’era persa da tempo la consuetudine dell’apertura delle caserme per la festa delle Forze Armate o per particolari ricorrenze locali, così la Cittadella si riaprì per gli alessandrini solo nel 1991, per la presentazione de La Cittadella di Alessandria: una fortezza per il territorio dal Settecento all’Unità, il bel volume curato da Anna Marotta per la Cassa di Risparmio d’Alessandria. Da quella giornata prese le mosse un primo tentativo di valorizzazione pubblica del sito (incoraggiato dall’allora presidente del Senato Giovanni Spadolini che aveva presentato il libro): nell’estate ’92 ospitò una prima stagione estiva di spettacoli realizzata dal direttore dell’Azienda teatrale di Alessandria Franco Ferrari grazie all’impegno del Comandante, col. Rizzo; nell’estate ’96 – tra enormi difficoltà e a significare che la Cittadella aveva superato la terribile prova dell’alluvione – si realizzò una seconda stagione che, nonostante l’ottimo successo, non ebbe più seguito. L’uscita di scena dei militari era però imminente e le preoccupazioni per il futuro della fortezza erano ben presenti negli alessandrini come si coglie perfettamente nel progetto di legge 15 ottobre 1996, per fortuna rimasto lettera morta, “di cessione a titolo oneroso alla Provincia di Alessandria del compendio … denominato “ex-Cittadella” e soprattutto negli interventi ai convegni svoltisi nel salone della palazzina comando-foresteria: “Alessandria: Cittadella e Città” organizzato nel settembre ’96 dalla Società per l’Architettura e dalla Camera di Commercio, e “La Cittadella di Alessandria. Un bene tra presente e futuro” curato nel 2001 dalla sezione di Alessandria di Italia Nostra. Intanto, l’8 giugno del 1997 Enrico Patria e chi scrive organizzarono per le associazioni Amici del Liceo Plana e Cittadella 1728, con la collaborazione del responsabile residente, mar. Zanmarchi, la prima giornata di apertura pubblica per gli alessandrini: un convegno storico per le scuole e nel pomeriggio le evoluzioni rievocative del gruppo in costume “Pietro Micca” guidato dal gen. Amoretti attirò tra i tre e i quattromila visitatori. Ancora nel novembre 1999 il salone della foresteria ospitò i relatori e il folto pubblico convenuto per la sessione d’apertura del convegno storico internazionale ‘L’altro Piemonte nell’età di Carlo Alberto’ organizzato col sostegno della Cassa di Risparmio dall’Istituto per la Storia della Resistenza, dall’Archivio di Stato e dal Centro di Cultura alessandrino dell’Università Cattolica. A complemento del Convegno, a gennaio 2000 e con notevole riscontro da parte degli alessandrini, la mostra “Una Cittadella per l’indipendenza” (collocata nel Tinaio degli Umiliati per l’impossibilità di garantire nella palazzina Comando le condizioni atte alla conservazione dei documenti esposti) propose una cinquantina di disegni originali e inediti dell’Istituto di Storia e Cultura dell’Arma del Genio che percorrevano la storia della fortezza e della città: il percorso espositivo si chiudeva con una grandissima tavola (più di 3,5 metri) del ponte Tanaro nel 1775.
Subito dopo l’uscita di scena dell’Esercito e nella “vacanza di diritto” (le competenze dell’Agenzia non contemplavano la gestione di un complesso come la Cittadella e neppure la guardiania lasciata al Comune di Alessandria ma di fatto gestita da volontari) si sono insediate all’interno e in modo “informale” talune attività di volontariato tese ad una valorizzazione “fai da te” della struttura: tuttora operante questa “occupazione” ha avuto sicuramente molti aspetti positivi perché ha supplito alle carenze del pubblico assicurando la manutenzione di talune aree verdi; operando il recupero dei sotterranei della palazzina comando, dell’ospedale e di diversi locali nel palazzo del Governatore; organizzando la gestione delle visite e di apertura e chiusura di Porta Reale; gestendo i servizi di ristoro e accoglienza essenziali; curando le 1500 uniformi del Regio Esercito acquisite nel 2010 dalla Fondazione Cassa di Risparmio; promuovendo nel 2012 la raccolta di firme che assegnò alla Cittadella il titolo FAI di “Luogo del cuore” degli italiani con un contributo per avviare la battaglia contro le piante infestanti. Gli aspetti meno positivi di questa occupazione de facto riguardano specialmente la divisione della Cittadella in aree di gestione rigidamente separate che rendono impossibile un coordinamento operativo peraltro difficile in assenza di direttive strategiche precise in ambito gestionale. Nel 2016 la titolarità sulla fortezza è passata al Ministerno dei Beni e delle attività culturali che ha subito collocato nella caserma Pasubio la sede della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola attribuendole la competenza specifica sulla Cittadella e dotandola di finanziamenti adeguati per progettare ed avviare le prime azioni di recupero.
E’ chiaro che la Cittadella – con i forti esterni del campo trincerato troppo spesso dimenticati nelle discussioni e nelle progettualità molto parziali finora emerse – anche in queste ultimissime fasi della sua vicenda si colloca all’interno del grosso e tuttora insoluto problema ch’era stato evidenziato fin dal Piano regolatore di Alessandria del 1977 e dai suoi studi preparatori: è cioè uno dei risvolti negativi di una demilitarizzazione urbana e suburbana eccessivamente lenta, largamente incompiuta, condotta a livello nazionale unilateralmente senza strategie concordate con le amministrazioni locali e con iniziative estemporanee tese principalmente a far cassa o scaricare problemi, responsabilità e costi da un istituto all’altro (dall’Esercito al Demanio, da questo al Ministero dei Beni culturali, ecc.). Il rischio, per la Cittadella, per Forte Acqui, forte Ferrovia e Forte Bormida è – come temeva Guido Amoretti – soltanto quello di soccombere all’assedio più subdolo, l’assedio del cemento che si protrae ormai dagli anni ’30, e pare stringerla in una morsa senza scampo.
Bibliografia essenziale
La distinta relazione dell’assedio della città di Alessandria (1745-1746), Ed. dell’Orso, Alessandria 1981
Guido Amoretti, La cittadella di Alessandria in “SPABA” n.s. XLIII 1989, Antichità ed arte nell’Alessandrino, p. 473 sgg.
La Cittadella di Alessandria: una fortezza per il territorio dal Settecento all’Unità, a cura di Anna Marotta, Cassa di Risparmio di Alessandria, Alessandria 1991
Guido Ratti, Noterelle storiche e divagazioni sulla cittadella di Alessandria nel ‘700, in “Rassegna economica della Provincia di Alessandria”, fasc. 1/1991, pp.8-23
Alessandria: Cittadella e Città. Atti del Convegno 14 settembre 1996, a cura di Patrizia Robotti e Roberto Livraghi, in ‘Rassegna Economica della Provincia di Alessandria” n.1/1997
Guido Ratti, A modo di provocazione: la Cittadella e la Storia, in “Rassegna economica della provincia di Alessandria”, f. 2 / 1997, pp. 28-38
Cristina BOIDO, Il disegno urbano di Alessandria: le mura dopo le mura. La persistenza del segno della cinta muraria e delle porte della città nell’Ottocento fra rilievo e progetto, Tesi di Dottorato, Università La Sapienza di Roma, XI ciclo, 1999
Una Cittadella per l’indipendenza. Catalogo della mostra storico-documentaria a cura di Gabriele Quaglia, Guido Ratti, Patrizia Robotti (Alessandria, Tinaio degli Umiliati 15-30 gennaio 2000) in L’altro Piemonte nell’età di Carlo Alberto, a cura di Ettore Dezza, Robertino Ghiringhelli, Guido Ratti, Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, 2001
La Cittadella di Alessandria. Un bene tra presente e futuro, Atti del Convegno del 7 aprile 2001 di Italia Nostra – Alessandria, Alessandria 2001
Dario Gariglio, Alessandria: storia della Cittadella, Torino, Omega 2001
Riabitare la fortezza. Idee per la Cittadella di Alessandria, a cura di G. Durbiano e L. Reinerio, Torino, Allemandi, 2002
Guido Ratti, Attendendo un nemico che non sarebbe arrivato mai: la militarizzazione e l’incompiuta demilitarizzazione di Alessandria, in I confini perduti. Le cinte murarie cittadine europee tra storia e conservazione, Bologna, Fond. del Monte di Bologna e Ravenna, 2005, pp. 301-328
Giovanni Cerino Badone, Sulla strada di Fiandra. Storia della Cittadella di Alessandria 1559-1859, Alessandria, FAI – Fondo ambiente Italiano, Delegazione di Alessandria, 2014.
Roberto Maestri, La Cittadella di Alessandria. Un’analisi esplorativa del sito attraverso i secoli: dal quartiere medievale di Bergoglio alla fortificazione dei nostri giorni, Editions Comunica (on line), s.l. ,2014
[Fort Med 2018] Procedings of the International Conference on Modern Age fortification of the Mediterranean coast [Fort Med 2018] vol.VIII, Eds. Anna Marotta e Roberta Spallone, I – Research on built heritage, Torino, Politecnico di Torino, 2018 , I – Research on built heritage
Anna Marotta,Serena Abello, Rossana Netti,Progetti e strategie per la Cittadella di Alessandria: un panorama complesso e incompiuto, in [Fort Med 2018] vol.VIII, p. 721-728
Emiliano Poggio, Il progetto “Bergoglio 3.0 luogo antico – vita nuova” per la Cittadella di Alessandria, in [Fort Med 2018] vol.VIII, p. 815-822
Guido Ratti, Cittadella e cultura: una risorsa fondamentale per la città [di Alessandria], in [Fort Med 2018] vol.VIII, p. 831-838
Matteo Robiglio, Nicola Russi, Elena Vigliocco, The Cittadella of Alessandria. Project fora n adaptive, in [Fort Med 2018] vol.VIII, p. 845-852
Nicola Parodi
Alessandria città ferroviaria
Alessandria era un importante nodo ferroviario già poco dopo la metà del 1800. Di tutte le linee che passano per Alessandria la prima ad essere realizzata é la Torino Genova, i cui lavori iniziano nel 1846 con il tratto Asti-Alessandria-Novi già in esercizio nel 1850. L’intera linea da Torino a Genova-Porta Principe viene inaugurata il 20 febbraio 1854 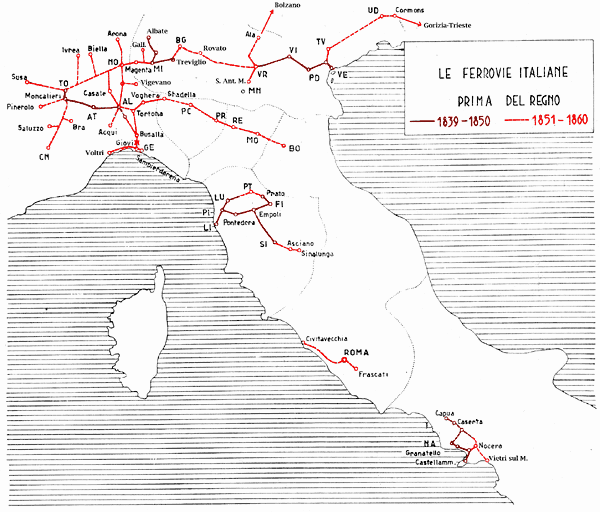 .
.
Gli studi per la linea da Alessandria ad Arona sono avviati nel 1846 e già il 5 giugno 1854 il tratto da Alessandria a Mortara è aperto all’esercizio Il 2 luglio viene aperto il tratto da Mortara a Novara; l’intero percorso é inaugurato il 17 giugno 1855.
Nel 1855 iniziano i lavori per la costruzione della ferrovia da Valenza a Casale a Vercelli. Nel marzo del 1857, in attesa dell’ultimazione del ponte sul Po a Casale, i treni già circolano da Valenza a Casale e da Vercelli al Po. Nel luglio del 1858 l’intera tratta da Valenza a Vercelli é in funzione.
La linea da Alessandria ad Acqui viene aperta nel gennaio del 1858 mentre il collegamento fra Acqui e Savona é aperto solo nel settembre del 1874.
Agli inizi del 1856 iniziano i lavori per la costruzione della linea Alessandria-Stradella (allora nel regno di Sardegna). Il tratto fino a Voghera é inaugurato il primo novembre del 1857; il tratto Voghera-Stradella viene attivato nel luglio del 1858. Nel frattempo il ducato di Parma ha rilasciato la concessione per la costruzione di una ferrovia da Piacenza a Stradella che viene ultimata agli inizi del 1860.
Nel maggio del 1862 viene completato il tratto fra Torre Beretti e Pavia che permette la relazione diretta fra Alessandria e Pavia (il tratto di linea fra Pavia e Voghera é aperto solo a fine 1867 e quello fra Vigevano e Milano agli inizi del 1870).
Il tratto relativo a Cantalupo-Bra, della linea riferibile ad Alessandria-Cavallermaggiore, viene aperto nel maggio del 1865 ( il tratto Bra-Cavallermaggiore era attivo già dal 1855).
Ultima la linea Alessandria-Ovada che fu aperta al traffico il 27 settembre 1907.
Le linee ferroviarie già costruite diventarono un mezzo fondamentale per lo spostamento rapido delle truppe sul teatro di guerra durante la seconda guerra d’indipendenza.
La posizione strategica fece sì che Alessandria assumesse grande importanza come centro di smistamento del traffico merci. Era anche sede di officine per la riparazione delle locomotive, delle carrozze e dei carri. Gli occupati nelle varie attività ferroviarie presenti in città agli inizi del 1970 superavano le 2500 unità. 
Negli ultimi decenni, anche in conseguenza delle riforme dell’organizzazione ferroviaria promossa dall’Unione Europea, è venuto meno l’obbligo che avevano le Ferrovie dello Stato di soddisfare tutte le richieste di trasporto anche di singoli carri merci da e per ogni stazione, facendo venir meno quindi la necessità di selezionare e raggruppare i carri per inoltrarli a destino e rendendo superflue le stazioni di smistamento. Il calo delle attività non ha interessato solo il traffico merci e la stazione di smistamento, ma è anche diminuito il numero dei treni del servizio viaggiatori, non solo per la quasi totale scomparsa dei treni viaggiatori a lunga percorrenza, ma anche per la riduzione dei treni del trasporto locale.
La stazione di Alessandria Smistamento, che occupa un’area di circa un milione di metri quadri, è quasi del tutto inutilizzata. La disponibilità di aree, la rete stradale e la posizione geografica avrebbero potuto permettere alla città di diventare sede di un importante centro intermodale come lo è diventata Novara. Evidentemente qualcosa è mancato. Ma la posizione geografica non è cambiata e prima o poi la città saprà esprimere una classe dirigente che faccia sì che il nodo ferroviario di Alessandria riacquisti il prestigio di prima.
Nuccio Lodato
Dall’Alessandria colpita all’Alessandria scolpita?
Teatro Comunale chiuso ormai da più di otto anni. Tentativi di rimetterlo, in qualche almeno minima misura in funzione, inevitabilmente parziali e sporadici: comunque forzatamente limitati a spazi minori. La denudata e azzerata sala principale, il vero cuore pulsante, presenta problemi tecnici e soprattutto finanziari che ne rendono il riassetto – soprattutto con le arie che tirano e i tempi che corrono – probabilmente irrealizzabile o ipotizzabile a tempo … indeterminabilissimo.
Una ferita virtualmente irrimarginabile e irrimediabile quanto l’impunità assoluta e generalizzata con cui si è conclusa, senza apprezzabili reazioni da parte di chicchessia, l’incredibile vicenda della polluzione di amianto che ha cancellato il teatro: vicenda che, in un paese normale, avrebbe monopolizzato per giorni prime pagine di quotidiani nazionali. Ma che ne cela un’altra più profonda e inguaribile: l’assoluta rassegnazione nei rari casi migliori, indifferenza o ignoranza (nel senso letterale: non sapere dell’esistenza del problema, o magari dello stesso teatro) nei più diffusi e peggiori, che hanno contrassegnato le non-reazioni della cittadinanza alla mutilazione. Mentre Novi Ligure e da un mese persino Voghera, dopo decenni di stasi e stallo, stanno affrontando, con tempistiche diverse, il restauro degli ultimi due teatri storici del vecchio Piemonte oltrepadano ancora irrecuperati, Alessandria è rimasta senza il suo – nuovo – senza colpo ferire e senza che la cosa, al di là delle apparenze, appaia sostanzialmente all’ordine del giorno (e all’orizzonte delle possibili risorse, per essere onestamente oggettivi).
Di tutto questo avevo già avuto modo di parlare in maniera analitica ed estesa (O adesso o mai più, nel volume miscellaneo edito da “Il Piccolo” per i novant’anni della sua storia nel 2015). Ma il periodo ulteriormente trascorso ha fatto incancrenire la questione e il discorso riguardante la fine personale di ciascuno dei quattordici tanto meritori quanto inascoltati dipendenti è caduto a sua volta nel più assoluto silenzio. La tremenda scomparsa prematura di Anna Tripodi, l’ultima e quasi l’unica ad essersi prodigata in senso contrario, ha suggellato emblematicamente la sciagurata vicenda.
Ma altre cose sono andate disperse, oltre alla concretamente e simbolicamente rilevante biblioteca del Fondo Ferrero, polverizzata a sua volta – per probabile forza di cose – nelle lunghe e singhiozzanti operazioni di bonifica seguite alla tragedia. Richiamo non a caso il nome di Adelio perché la cosa preziosa di cui si sono perse in fondo le tracce, senza speranza di recupero, è il documento fondativo da lui steso nel 1972, col cui abbrivio ebbe luogo il dibattito finale sulle modalità di gestione della struttura nel frattempo nascente. Quello sfociato quattro anni dopo nella sofferta ma feconda nascita della primigenia Azienda Teatrale Alessandrina, e altri due più avanti nell’inizio della sua attività spettacolare, protrattasi poi fra alterne vicende, ma garantita per fortuna da una miracolosa unitarietà di fondo per i successivi trentadue.

Certo: la nascita e lo sviluppo del Comunale furono il progetto e il parto di un’élite. E niente più di questo potrebbe risultare, oggi come oggi, irredimibile peccato mortale alla ”opinione pubblica” prevalente. Il teatro fu davvero, via via, imposto alla città, dal lavoro pancia a terra di personaggi dalle dimensioni troppo vaste per essere compatibili col nostro orizzonte odierno. E, con Adelio, ebbero profonda coscienza delle potenzialità, ma anche e soprattutto dei limiti e dei rischi di tale tensione illuministica uomini come Enrico Foà e Delmo Maestri, Giorgio Guazzotti e Ugo Zandrino. Che da un lato ci mancano enormemente, ma dall’altro ci fanno quasi tirare un sospiro di sollievo al pensiero di quanto si siano, senza saperlo, risparmiati.
Quando nel 1999 Paolo Pasquale, con notevole coraggio e forte impegno personale, riportò all’onore del mondo, al Cristo, il vecchio e screditato cinema Cristallo, facendone l’elegante bi-sala Kristalli per fortuna tuttora operante, il dato pareva aggiungersi alla premessa-promessa di un nuovo millennio dalle magnifiche sorti e progressive dello spettacolo in città.
Alla chiusura del cinema Corso, già dolorosamente registratasi in precedenza, si sono invece aggiunte via via, successivamente, quelle del Moderno e del Galleria, oltre che dell’Ambra, accecando contemporaneamente il centro e la periferia delle luci del cinema.
Se non avesse resistito e rilanciato di nuovo Pasquale, rifacendo il suo Politeama Alessandrino e mettendolo di nuovo a disposizione anche quale sala teatrale suppletiva dopo la catastrofe, la città risulterebbe anche da questo punto di vista ancor più depauperata e malridotta di quanto già non sia. Con tutta la stima per le pur notevoli proposte volontaristiche sviluppatesi nel frattempo, ad esempio al “San Francesco” e in quanto rimasto dello stesso Ambra, e il rimpianto per come sia stata lasciata cadere l’intuizione geniale di Anna Tripodi: ricavare una multisala a cinque schermi al Comunale, lasciandone intatta la funzione teatrale.
La storia non si fa coi se, ma forse ci saremmo risparmiati anche l’incubo amianto, la cui vera vicenda appare ancora tutta da scrivere.
Cesare Ponzano
Alessandria “città manifatturiera”: la Borsalino, il Sindacato
La Borsalino rappresenta un intreccio inscindibile tra famiglia, fabbrica, città. Guardandoci intorno vediamo la filantropia dei Borsalino e il loro paternalismo aziendale che lo storico Antonio Gibelli in un suo saggio del 1977 “Movimento operaio e socialista-alcuni documenti sul caso Borsalino”, definisce “dispotismo illuminato”. Guardiamo le realizzazioni per la città.
Il Sanatorio Vittorio Emanuele II (1929-1936) posto oltre il Tanaro, verso Valmadonna, oggi centro di riabilitazione polifunzionale, il Dispensario Antitubercolare (1934-1938), oggi poliambulatorio ‘Gardella’, costruiti per rispondere al divulgarsi di malattie broncopolmonari, non solo tra chi lavora nell’umidità, nelle polveri e con le sostanze chimiche della fabbrica, ma anche per tutta la popolazione alessandrina. Il nuovo acquedotto del 1922 e l’ampliamento della rete fognaria, l’ammodernamento della Casa di riposo di Corso Lamarmora del 1925, l’Educatorio per i figli dei dipendenti del 1922. E ancora la Casa della Divina Previdenza Teresa Michel inaugurata da Teresio Borsalino succeduto al fondatore Giuseppe il 13 giugno 1927. La Fondazione Borsalino Veglio giovani operaie a supporto alle lavoratrici massicciamente utilizzate in fabbrica. L’impiego delle “Borsaline” rappresentò un elemento di emancipazione femminile, sia a causa della promiscuità nel luogo di lavoro, sia per l’autonomia derivante dall’avere un reddito proprio (seppure sempre inferiore a quello degli uomini). L’intreccio fabbrica-città possiamo vederlo anche notando i binari che, fino agli anni ’60, collegavano la stazione ferroviaria allo stabilimento per l’approvvigionamento di materie prime e la spedizione del prodotto.
Sul fronte interno all’azienda la filantropia si sviluppa con una serie di iniziative tra cui la costruzione di una infermeria con il medico di fabbrica (1901), l’istituzione per i dipendenti, tra il 1896 e il 1900, della cassa pensioni, infortuni e malattia, la Casa degli Impiegati (sempre dell’architetto Gardella nel 1952) costruita a poche decine di metri dallo stabilimento, quasi a sancire la “vicinanza” di una parte privilegiata di dipendenti alla proprietà.
L’intreccio economico, culturale, sociale viene anche da altri segnali. Il linguaggio; in fabbrica si parla quasi esclusivamente il dialetto alessandrino talvolta storpiato da lavoratori immigrati dal sud o dalla penisola istriana (non molti, si preferiva mano d’opera locale). La Sirena; storicamente l’orario di lavoro è 8-12/14-18. Una sirena suona due volte alle 7,40 e alle 13,40, una volta alle 7,55 e alle 13,55 per l’avvio. Alle 12 e alle 18 per la fine. La sirena scandisce i ritmi di vita dell’intera comunità alessandrina: negozi, bar, bancarelle, banche, modellano i loro orari sulla sirena, così fanno altri stabilimenti. La sirena suonerà l’ultima volta nel 1983 per salutare il feretro di Teresio Usuelli-Nino, discendente della famiglia che aveva guidato la Borsalino dal 1936 al 1979. L’area di Oltre canale (l’attuale parco Usuelli). Collocata tra Corso T. Borsalino e via R. Wagner, collegata allo stabilimento da una passerella e da un sottopassaggio, adibita a centrale termica e deposito materiali, è caratterizzata da prato e ampio frutteto per fornire la mensa della famiglia. In quell’area, per certi periodi, erano allevati fagiani che venivano liberati nella riserva di Rocchetta Ligure qualche giorno prima delle battute di caccia di cui la famiglia Borsalino era appassionata. La Palazzina. Così è chiamata la villa sita all’angolo tra Via Cavour e Corso 100 Cannoni abitazione della famiglia Borsalino. Si noti la collocazione del cancello, dirimpetto al portone principale dello stabilimento (oggi sede dell’università), per passare dalla casa alla fabbrica e viceversa basta attraversare un incrocio. Ne possiamo dimenticare le colonie estive per i figli dei lavoratori e lo spaccio aziendale, sito in Corso XX settembre, destinato a fornire ai dipendenti derrate alimentari a prezzo contenuto.
Nel suo secolo e mezzo di vita, pur con alti e bassi, la Borsalino ha costituito uno straordinario volano economico diretto e indotto per il territorio alessandrino facendo lavorare migliaia di persone, intere generazioni. Da quando Giuseppe Borsalino (‘u siur Pipen’ nato a Pecetto nel 1834), dopo aver imparato il mestiere in Francia, ha fatto uscire il primo cappello il 4 aprile 1857, la produzione è cresciuta esponenzialmente: 5.000 cappelli nel 1874, 70.000 nel 1890 e, punta massima oltre 2.000.000 nel 1913.

E i dipendenti raggiungono le 3.000 unità. Borsalino è un marchio di qualità, un’eccellenza conosciuta in tutto il mondo grazie all’intraprendenza dei tecnici e la professionalità di lavoratrici e lavoratori. I cappellai, quasi una casta. Non solo, ma la vocazione all’autosufficienza della fabbrica (internamente si produce energia termica ed elettrica utilizzando le acque del canale, si sviluppa ricerca tecnologica, si progettano e si costruiscono in proprio i macchinari, la rete di vendita è autonoma, ecc.) inducono il formarsi di professionalità in campo meccanico, elettrico, chimico, assai utili all’intero tessuto industriale alessandrino.
Passata la crisi del 1929, e la 2° guerra mondiale (la Borsalino fu bombardata nell’aprile, luglio e agosto del 1944 dopo essere stata obbligata dai nazifascisti a produrre indumenti di feltro per l’esercito) e successivamente al boom di produzione del 1947 con oltre 1.000.000 cappelli si avvia una fase di disuso del copricapo, nel 1950 se ne producono 775.000. Nel 1957, centenario della fondazione ricordato anche con la pubblicazione “Omaggio al cappello”, i dipendenti si riducono a 1300. Si avvia un progressivo declino: 1000 addetti nel 1961, circa 500 nel 1976. La proprietà mantiene la volontà di non diversificare la produzione nonostante alcuni significativi solleciti; fu ad esempio organizzata nel giugno del 1977 una conferenza di produzione da parte del Consiglio di Fabbrica ed alcuni Partiti Politici dove si avanzavano proposte di nuove produzioni e si iniziava a pensare ad una rilocalizzazione dello stabilimento ormai vetusto ed obsoleto.
150 anni di vita di un marchio ma anche di storia sindacale. Ben prima della fondazione della Camera del Lavoro di Alessandria (1901) era stata costituita la Lega dei cappellai con finalità di mutuo soccorso e, successivamente, di difesa delle condizioni dei lavoratori. Ricorda ad esempio Giordano Pompilio nella pubblicazione ISRAL “La Camera del Lavoro di Alessandria dalle origini alla prima guerra mondiale” che nel 1887 “a causa delle continue riduzioni di tariffe subite dalle maestranze…vi fu uno sciopero durato diversi mesi”. Nel dopoguerra le rivendicazioni sindacali alla Borsalino hanno riguardato prevalentemente, oltre a richieste salariali, le questioni ambientali, la difesa della salute in fabbrica (emblematica la battaglia per l’eliminazione dei derivati di mercurio dal processo di lavorazione, responsabili di una grave malattia professionale) e la difesa dell’occupazione costantemente minacciata dalle contrazioni di mercato. È da considerarsi fisiologico che la proprietà Borsalino non vedesse con favore le organizzazioni dei lavoratori, spesso nel confronto sindacale la Direzione ha avuto comportamenti intimidatori, discriminatori e repressivi.
Nel 1980 a fronte di continue contrazioni del mercato e quindi calo di produzione e di addetti, l’obsolescenza, l’eccessivo sovradimensionamento e la diseconomicità dello stabilimento di Corso 100 Cannoni, la proprietà subentrata alla famiglia Borsalino-Usuelli-Vaccarino (precedenti detentori del pacchetto azionario) decide la rilocalizzazione nella zona industriale di Spinetta Marengo. Tale rilocalizzazione sarà facilitata dalle istituzioni e dalle forze sociali (con l’acquisizione ed il riutilizzo dell’area dismessa) e avverrà pagando un pesante prezzo occupazionale, anche se gestito in modo non particolarmente traumatico (gli addetti saranno ridotti a poco più di un centinaio). Nell’area prima occupata ha trovato sede l’Università, un supermercato, alcune abitazioni private e, oltre-canale, giardini e sede del Consiglio di Quartiere nei locali della ex “Taglieria del Pelo” (Gardella 1956): La “ciminiera” simbolo della fabbrica e di lotte operaie sarà abbattuta il 28 maggio 1987. Della “ciminiera” un episodio passa alla storia come riporta la stampa dell’epoca: “nel maggio 1961, conclusa una difficile vertenza aziendale, la Direzione della Borsalino mise in atto una serie di azioni repressive nei confronti di chi aveva guidato la lotta. Non potendo colpire direttamente i rappresentanti sindacali, Pietro Balbi, Bruno Tomasetti, Pietro Drago e Rita Forneris (CGIL); Vittorio Bellotti (CISL); Mario Buscaglia, Libero Lenti, esponente degli impiegati (Indipendenti) avviò, adducendo calo di mercato, il licenziamento di 58 dipendenti. Balbi, seguito da uno dei licenziati, Baseggio, decide per protesta di salire sulla piattaforma della ciminiera ed iniziare lo sciopero della fame. La fabbrica viene occupata e, di fronte alla possibilità reale che la Direzione Aziendale chiedesse lo sgombero forzato da parte delle forze dell’ordine, il Sindaco socialista Nicola Basile procedette, con atto di responsabilità, alla requisizione dello stabilimento. La vicenda si concluse con la mediazione del Ministero del lavoro a Roma: dei 58 dipendenti da licenziare, solo otto sarebbero stati scelti fra personale attivamente in servizio e gli altri 79 sarebbero stati tratti da una lista di operai già in pensione o prossimi al pensionamento”.
Nel secondo decennio del 2000 la Borsalino – come riferisce Maria Iennaco della Camera del Lavoro – eventi di carattere finanziario e giuridico di soci bancarottieri, ha visto mettere in forse la sua stessa esistenza tanto da arrivare al fallimento. La successiva acquisizione da parte di una società italo-svizzera (Heares Equita s.r.l.), la mobilitazione dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali, delle istituzioni locali e di una intera città hanno consentito la salvaguardia del marchio e la permanenza dello stabilimento in Alessandria. Non solo, ma l’iniziativa sindacale ha permesso accordi per la salvaguardia dell’occupazione e la professionalità dei lavoratori. Progetti tendenti a far conoscere la storica fabbrica, coinvolgere popolazione e studenti per impedire la perdita di un ulteriore pezzo del tessuto industriale alessandrino, si sono susseguiti per parecchi mesi. Contemporaneamente la proprietà ha sviluppato iniziative tendenti al rilancio a livello nazionale ed internazionale del cappello che è stato sulla testa di Al Capone, Humphrey Bogart, Robert Redfort, Federico Fellini, Alain Delon e Jean Paul Belmondo. Nel 2017, dallo stabilimento che occupa 130 addetti, sono usciti circa 150.000 copricapo.
Renzo Penna
I tragici bombardamenti del 1944. Alessandria con 559 vittime la città più colpita del Piemonte
Nella seconda guerra mondiale i bombardamenti anglo-americani sconvolsero la città di Alessandria provocando 559 morti, danneggiando e distruggendo gran parte delle abitazioni e degli edifici pubblici. Le incursioni più violente si ebbero il 30 aprile 1944 e il 5 aprile 1945. Le sirene che annunciavano gli allarmi-aerei entrarono in funzione oltre mille volte.
Le 559 vittime collocano la città al secondo posto tra i capoluoghi piemontesi, subito dopo Torino (con 2069 morti), e molto al di sopra di Cuneo e Asti (rispettivamente 56 e 54 vittime) oltre che di Vercelli (31 morti) e Novara (una sola vittima). Se però si calcola il rapporto tra la dimensione complessiva della popolazione e il numero dei decessi, si può notare come ad Alessandria si registri la maggiore incidenza percentuale delle perdite umane e come l’estensione delle distruzioni del patrimonio abitativo non abbia quasi paragoni nell’insieme della regione. Pesò, nel collocare Alessandria tra gli obiettivi sensibili del Bomber Command inglese e dell’aviazione americana, il suo carattere di nodo ferroviario di grande rilievo lungo gli assi di comunicazione strategica e la relativa facilità di colpire aree densamente popolate e poco protette.
La zona dell’alessandrino è stata tra le prime ad essere interessata e a scoprire le tragiche conseguenze dei bombardamenti. Il 14 agosto 1940, a poco più di due mesi dalla dichiarazione di guerra del Duce – quella delle ‘decisioni irrevocabili’ – alcune bombe sganciate di notte da aerei inglesi che, partiti per bombardare Milano e Torino si erano dispersi nei cieli della pianura Padana, cadono su Tortona e colpiscono una cascina isolata, la Pistona, tra Spinetta e San Giuliano Vecchio, radendola al suolo. L’intera famiglia dei proprietari, padre, madre e tre figli, rimase uccisa. Due bombe finiscono nel sobborgo di Litta Parodi, causando un morto, altre si spargono tra i campi. Nel frattempo, in piena notte, una bomba inesplosa uccide cinque dei pompieri accorsi alla Pistona e ne ferisce altri sei.
Dopo quella tragedia, che colpisce moltissimo la popolazione e disvela i nuovi terribili rischi di un conflitto che utilizza, come mai nel passato, la forza dell’aviazione e l’impiego distruttivo delle bombe, la città non viene più coinvolta. Quella tregua sarebbe durata sino ai primi mesi del ’44. Dopo l’armistizio dell’8 settembre, la risalita della penisola da parte degli alleati si era arrestata per lunghi mesi al di sotto della Linea Gustav, trovando nelle fortificazioni realizzate dalle truppe tedesche un ostacolo difficile da superare. Anche lo sbarco di Anzio del gennaio ’44 aveva incontrato una forte resistenza non riuscendo a sbloccare la situazione e l’avanzata verso Roma e il centro d’Italia subì una battuta d’arresto.
Per superare queste difficoltà gli alleati si affidarono così nuovamente all’aviazione, puntando ad interrompere, a monte, i flussi dei rifornimenti destinati alle numerose divisioni tedesche schierate a sud di Roma. Si trattava di colpire in modo costante e continuativo l’intera rete ferroviaria, quella stradale e i principali obiettivi erano i ponti, i viadotti, le stazioni e gli scali ferroviari. L’operazione, che prese il nome di Strangle (strangolamento), dal Centro Italia si estese ai più importanti smistamenti delle principali città settentrionali che vennero ingolfati da centinaia di vagoni merci carichi di rifornimenti. Tra i nodi ferroviari che la Wehrmacht considerava di maggior interesse per collegare le proprie truppe, quello di Alessandria figurava insieme a quello di Bologna. Strangle durò quasi due mesi, dal 19 marzo al 12 maggio, e i bombardieri pesanti americani della 9a e 15a forza aerea effettuarono pesantissimi attacchi sulle principali città del Nord. Con questi programmi e queste strategie di guerra, per la città e il territorio alessandrino si stava annunciando un mese di aprile che risulterà tra i più tragici dell’intera sua storia.
Il 30 aprile del 1944 cadeva di domenica, in tutte le chiese di fede cristiana si celebrava il rito della Santa Messa, era una limpida giornata di sole e molte persone si trovavano fuori casa ma, poco dopo mezzogiorno, Alessandria subisce, completamente impreparata, il suo terribile ‘battesimo di sangue’. L’incursione dei bombardieri americani ha come obiettivo principale il grande smistamento ferroviario, ma una buona parte delle bombe cade sulla città e colpisce, in particolare, il quartiere Cristo e il Borgo Littorio, l’attuale Pista. Le vittime accertate furono 239, in maggioranza casalinghe (75), bambini e studenti (45), ferrovieri, operai e artigiani (59). I militari deceduti (12)

Alessandria, Corso Acqui – Bombardamento del 30 aprile 1944
facevano parte della caserma delle ‘Casermette’. Oltre a molte abitazioni vengono gravemente lesionati diversi edifici pubblici e chiese: il duomo, la chiesa di Sant’Alessandro, il palazzo Trotti Bentivoglio, la biblioteca storica del Risorgimento, la casa Michel e la sede della Croce Rossa. In una seconda incursione, lunedì notte, questa volta ad opera dei bombardieri della Raf, viene colpito e distrutto da una bomba incendiaria il teatro municipale, costruito nella seconda metà del settecento, e lo stabilimento della Borsalino.
Lungo tutto il ’44 le incursioni si succedono. Il 21 e 29 giugno, a metà mattinata, vengono bombardati i ponti della ferrovia sui fiumi Bormida e Tanaro. L’11 luglio, alle 10, un bombardamento massiccio investe l’area della stazione ferroviaria e parte della città: il bilancio è di 46 morti. Le incursioni proseguono il 17, 20, 21 e 27 luglio, concentrate sulla ferrovia e sui ponti. Si ripetono in agosto, il 2, 7 e 20, con la demolizione delle arcate del ponte sulla Bormida, e il 21, quando la città viene nuovamente colpita in maniera massiccia e prolungata e i morti assommano a 31. A inizio settembre lo stillicidio prosegue. Il 3 e il 4 nuovi bombardamenti interessano piazza Gobetti (il palazzo della GIL) e le officine del gas. Muoiono altre 8 persone.
Il comando germanico, che aveva requisito per la propria sicurezza i sicuri rifugi anti aerei ricavati sotto i bastioni della Cittadella (San Michele e Sant’Antonio), si era però sempre categoricamente rifiutato di aprirli all’utilizzo della popolazione civile. La quale, avendo visto come nel bombardamento del 30 aprile i rifugi ricavati sotto i palazzi si erano trasformati in trappole mortali, al suono delle sirene si riversava nei giardini o raggiungeva, anche di notte, Piazza d’Armi. Lì attendeva che cessasse l’allarme.
Il 5 settembre la città assiste a un nuovo massacro. In Borgo Cittadella 39 persone avevano cercato riparo in un sottopassaggio situato al di sotto della strada per Torino. Una bomba esplode a una delle estremità del tunnel e scaglia gli occupanti maciullati all’esterno. Per 20 di loro, nell’impossibilità del riconoscimento, verrà redatto un certificato di ‘morte presunta’.
Le incursioni proseguirono sino alla fine dell’anno, il 22 novembre e il 29 dicembre, con altri tre morti. A Spinetta viene colpito lo stabilimento della Montecatini. Diverse famiglie, rimaste senza casa e sfollate, occupano le scuole elementari. Alla fine del settembre 1944, esclusi i sobborghi, risultavano completamente distrutte 360 case, 570 erano gravemente danneggiate e oltre un migliaio presentava danni minori.
Con l’approssimarsi della primavera e della resa definitiva delle forze di occupazione nazifasciste, le strade che collegano la Liguria all’alessandrino assumono un’importanza strategica. L’attività partigiana si estende anche alle zone di pianura mentre si rafforza una collaborazione tra il Comitato di Liberazione Nazionale per l’Alta Italia e il Comando Alleato. Una comunità di intenti che in diverse occasioni aveva avuto successo, ma il 5 aprile 1945 qualcosa nei rapporti, drammaticamente, non funziona e poco dopo le 15 una formazione di bombardieri anglo-americani compare nel cielo della città e, senza nessuna comprensibile ragione militare, scarica al suolo un carico micidiale di bombe. Una colpisce in pieno l’asilo delle suore salesiane di Via Gagliaudo, dove perdono la vita 27 bambini insieme a sei religiose. I morti accertati saranno al termine 160 e oltre 600 i feriti, le case completamente rase al suolo 45, un migliaio gli appartamenti distrutti o resi inabili. Ma ciò che più sconcerta è l’assurdità di tante morti incolpevoli a pochi giorni dal termine del conflitto, ciò che si giustifica solo con l’irrazionalità e la lucida crudeltà che caratterizza ogni guerra. L’aviazione anglo-americana continuò a bombardare e a mitragliare la città dall’alto il 14 e il 24 aprile, con altri sette morti. Al termine del conflitto Alessandria, insieme alle 559 vittime dei bombardamenti, conta 45 giovani immolati nella lotta di liberazione e 36 deportati nei campi di sterminio. E deve fare i conti con la completa distruzione di 4445 vani di case, 3349 vani semidistrutti e 4609 danneggiati.
Nel 70° della Liberazione, giovedì 30 aprile 2015, a parziale risarcimento per il silenzio delle istituzioni e la dimenticanza della città nei confronti delle 559 persone morte a causa dei bombardamenti, l’amministrazione comunale di Alessandria ha inaugurato in una delle sale del municipio un ‘Memoriale’ a loro dedicato. Una grande tela dell’artista Massimo Orsi che riporta, in ordine alfabetico, l’elenco completo delle vittime.
Franco Livorsi
Università in Alessandria: un lungo cammino
Ho sempre creduto – molto prima che nascesse – che la realizzazione dell’Università in Alessandria fosse un obiettivo da perseguire. Nel 1970 ero vicesegretario provinciale del PSIUP alessandrino. Fui incaricato di scrivere e presentare all’assemblea dei nostri iscritti la bozza del nostro programma alle Amministrative. Inserii tra i punti qualificanti quell’obiettivo. Ma fui ripreso dal mio amico, nostro deputato, Giorgio Canestri, che aveva 35 anni, mentre io ne avevo 29. Egli disse che non era detto che fosse bene che l’Università fosse fatta qui perché la scelta avrebbe dovuto essere compiuta in sede di programmazione nazionale, senza rivendicazioni “localistiche”. Tenni il punto. Dopo due anni lo PSIUP si sciolse, in seguito a due gravi disfatte elettorali, e io ed altri amici confluimmo nel PCI. Divenni responsabile della Commissione Scuola e Cultura della Federazione del PCI e, sin dalla fine del 1973, membro della segreteria provinciale. Riproposi subito l’obiettivo dell’Università in Alessandria con grande forza (come si può vedere ampiamente sul “Piccolo” del 13 aprile 1974, su “Lasvolta” del 7 novembre 1974, eccetera). Per allora l’obiettivo era inserito in un’ottica di pura programmazione nazionale, ma con una fortissima accentuazione sui diritti e l’idoneità di Alessandria per una tale realizzazione
In tale quadro il 24 giugno 1975 organizzai un convegno alla Casa della Cultura tra l’Istituto Gramsci piemontese e quello di Alessandria, cui parteciparono, oltre al sottoscritto: l’assessore regionale alla Programmazione, Luigi Rivalta; l’assessore all’Urbanistica, Claudio Simonelli; l’allora direttore del Gramsci di Torino, Gianni Alasia; il senatore Piovano di Pavia, della Commissione Istruzione. Raccolsi gli atti, poi rimasti inediti e pubblicammo pure un impegnativo documento, firmato dai relatori, ma anche dal democristiano Luciano Vandone, su “Il Piccolo”.
Sull’onda di tali incontri riuscimmo a far pronunciare la Regione Piemonte, giunta al termine della legislatura (le Regioni erano nate nel 1970). Si sapeva che il parere delle Regioni avrebbe avuto un gran peso, per legge, in materia di scelta delle nuove Università. Prima che si sciogliesse quella legislatura, il Consiglio Regionale votò infatti un ordine del giorno, concordato con noi, il quale diceva che il Piemonte abbisognava di due nuove Università, con facoltà differenziate tra le due sedi: una nel Piemonte Sud (in Alessandria) e una nel Piemonte Nord (a Novara).
Nel frattempo Novara si era attrezzata da anni per porsi in lista d’attesa, molto quotata come secondo Ateneo piemontese, ottenendo spezzoni di corsi di laurea mutuati dalla Facoltà di Medicina di Pavia e da quella di Ingegneria (e, oltre a tutto, avendo come attivo nume tutelare novarese il potentissimo ministro, poi Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro).
Ad Alessandria non si poteva fare “come a Novara” per il fuoco di fila contro la “disseminazione” dei corsi universitari, i famigerati “spezzoni”, considerati alto tradimento della “programmazione razionale e nazionale” dalla cultura di sinistra della nostra città e, per consenso automatico, da un ceto politico che aveva delegato agli “intellettuali” la capacità di pensare in ambito teatrale universitario e culturale. Tragedia di una città in cui i politici sono quasi sempre “praticoni” pretesi “furbi” e gli intellettuali sono spesso stati letterati poveri di senso politico pragmatico.
Io nel decennio 1975/1985 fui assessore alla cultura e poi capogruppo consiliare del PCI (che contava allora 19 consiglieri su 50). In quella fase avevo maturato due convinzioni forti, la prima delle quali era diversa da quelle degli intellettuali miei concittadini. Innanzitutto, prendendo a occuparmi seriamente della cosa, constatavo che – piacesse o meno – dal 1861 non c’era mai stata nessuna Università che non fosse sorta legalizzando e ampliando realtà universitarie preesistenti (al nostro tempo dette sprezzantemente, dai miei amici, “spezzoni”). In secondo luogo constatavo amaramente che Alessandria stava palesemente decadendo economicamente e che una politica di insediamento di servizi culturali qualificati da un lato avrebbe potuto a poco a poco far crescere culturalmente la città, e dall’altro avrebbe avuto un forte valore anticiclico, cioè di reazione al blocco avvenuto nello sviluppo di questa città, un tempo così importante “in tutto” (più o meno sino al 1960, con sprazzi sino al 1970).
Mi chiedevo se tra la politica da “praticoni” e “clientelare”, pronta a prendere tutto quel che potesse arrivare in ogni campo (in quell’ambito ogni spezzone anche di pochi corsi), e quella palesemente astratta di chi aspettava “Godot”, cioè scelte fatte senza alcun condizionamento locale dal Parlamento o/e Governo, per motivi puramente “razionali”, non ci fosse una terza strada, pragmatica in modo alto, razionale e progressivo. Al proposito a me pareva che, se ad essere decentrati fossero stati interi corsi di laurea o facoltà, non si sarebbe potuto parlare di “spezzoni”, purché venisse fatto in vista di una rapida fondazione “per legge” di un nuovo Ateneo.
Feci a fondo, con altri – tra cui l’assessore e poi vicesindaco Andrea Foco, e poi l’assessore all’Istruzione Margherita Bassini, insieme all’assessore all’Urbanistica Ghe’ e a quello alla Cultura, Gianluca Veronesi – questa battaglia. Spesso dovetti fare una battaglia su più fronti. Si dovettero battere logiche localistiche rozze, come quelle di chi in mancanza dell’Università si sarebbe accontentato di un corso di Urbanistica, ancora neanche esistente a livello nazionale, puntando su un “pezzo grosso” della cultura in architettura, e del riformismo socialista (Astengo). Ma la maggior battaglia la si dovette ingaggiare con taluni intellettuali alessandrini di grido, che caricavano come tori furiosi chi voleva decentrare corsi di laurea, anche completi, dall’Università di Torino. Potei dare una mano diciamo non piccola per vincere tali resistenze solo perché ero capogruppo del primo partito in Consiglio comunale e perché erano d’accordo con me figure chiave del comunismo alessandrino come il segretario di federazione (Enrico Morando) e assessori come quelli che ho citato.
Per parte sua il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca nella legge 590 del 1982, suo piano quadriennale, mise nero su bianco tre punti:
1) che nessun Ateneo avrebbe potuto avere più di cinquantamila iscritti;
2) che il Piemonte era la prima Regione in cui fosse urgente fare un nuovo Ateneo (Torino aveva 60.000 iscritti e strutture capaci per 20.000);
3) che nella scelta dei nuovi atenei si doveva partire da realtà universitarie parziali già presenti sul territorio.
Il terzo punto confermava addirittura con la forza della legge la necessità di far arrivare corsi universitari, che noi volemmo completi, se si voleva far giungere la nuova Università.

Quando Andrea Foco divenne assessore all’Istruzione (1980) fui incaricato, poco dopo, di indicare la rosa dei nomi di una Commissione del più alto profilo per dare gambe al progetto dell’Università anche in Alessandria. Come docente dell’Ateneo torinese qual ero, soprattutto sapendo che sui problemi di gestione e amministrazione nessuno era più capace di Gian Mario Bravo (allora Preside di Scienze Politiche), non potevo certo evitare la mia Facoltà (anche se io al momento della scelta definitiva, dopo i corsi decentrati, a differenza di altri preferii continuare a insegnare a Torino). Così addivenimmo all’idea di coinvolgere Borrello, per poco non eletto Rettore e allora vicerettore, e indiscusso e autorevole Preside della Facoltà di Scienze Fisiche Matematiche e Naturali dell’Università di Torino. Partecipò pure il compianto Franco Ferraresi, collega sociologo e allora prorettore. Evitai pure l’assurdo tentativo di separare i tecnici dai decisori politici, ottenendo che i capigruppo fossero invitati permanenti. Sventai tale tentativo, che avrebbe rotto il cordone ombelicale che univa i politici e il mondo universitario, con l’aiuto degli assessori Ghe’ e Veronesi.
Addivenimmo così al progetto che – in attesa di rapida decisione sulle nuove Università – concordava con l’Ateneo di Torino la nascita qui di Scienze Politiche a indirizzo amministrativo e di Scienze Matematiche Fisiche Naturali. A queste due Facoltà si aggiunse quasi subito una terza Facoltà torinese, Giurisprudenza. Non solo scrissi il documento votato dal Consiglio Comunale e Provinciale e lo illustrai nel Consiglio Comunale nel febbraio 1983 (fu pubblicato sul bollettino “Il Comune” il 2 novembre 1983), ma a Torino fui nominato, con Maurilio Guasco, nella Commissione Tecnica di Facoltà per gestire la cosa (22 ottobre 1985). Mi trovai a stendere la bozza dell’accordo e – in tal caso col professor Negro di Scienze – anche quella dell’atto amministrativo connesso: testi poi firmati di comune intesa dal Rettore dell’Università di Torino, professor Dianzani, dal Sindaco di Alessandria e dal Presidente della Provincia. Intanto qui si formava un Consorzio, o Comitato per l’Università in Alessandria (“in” e non “di”), efficacemente presieduto da Gianluca Veronesi.
In parallelo si muoveva, non certo a caso, la Regione Piemonte. La Regione nell’aprile 1984 votò un documento in cui invitava il Ministero competente “ad istituire una Università policentrica nel Piemonte Orientale, preso atto con favore delle proposte avanzate in materia dalle Province e dai Comuni di Alessandria, Novara e Vercelli”. La Regione auspicava una nuova Università “per poli omogenei nelle aree di Alessandria, Novara e Vercelli” (il testo si può leggere su “La Settimana”, di Alessandria, del 5 aprile 1984).
L’impostazione di un’Università strutturalmente una e trina era originale in Italia, ed era stata pensata e proposta da noi e accettata come buon compromesso da altre città capoluogo, perché sapevamo che Novara, che aveva molte più chances di Alessandria, sarebbe certamente diventata il secondo Ateneo piemontese, avendo ottenuto il decentramento di due importanti Facoltà da anni ed essendo l’area nel cuore del potente Scalfaro. Ma non si trattava solo di efficace tatticismo “pro Alessandria”, pure da non buttar via. Era anche il modo di impedire una cosa sbagliata tramite una cosa giusta, essendo Novara a mezz’ora da Milano. E solo incentrando il nuovo polo nel Piemonte Sud era possibile cominciare a bilanciare un modello di sviluppo tutto risolto nell’area di Torino. Inoltre, lasciare la città più importante del Piemonte Sud al suo malinconico declino sarebbe stato criminale. Non credo che ad Alessandria si sia insediato nulla di più importante della nuova Università, da allora.
Prima di giungere al risultato c’erano e ci sarebbero stati diversi tentativi di far fallire tutto. Tralascio le grida di chi era contro l’accordo per ragioni di principio, cui ho accennato. Ci fu pure un progetto di “sistema universitario piemontese” elaborato dal grande sociologo Luciano Gallino, che voleva che ogni nuovo insediamento facesse sempre capo all’Ateneo di Torino. Lo contestai nell’Aula Magna stessa di Palazzo Nuovo, dicendo che il Ministero stesso aveva posto come prima esigenza in Italia quella del secondo Ateneo piemontese e che l’idea del seguitare a concentrare tutto lo sviluppo del Piemonte a Torino perpetuava uno squilibrio tra capoluogo regionale e province che era invece da superare. Ancora in dirittura d’arrivo ci furono alcuni pericoli che dimostrarono che avevamo agito giustamente. Infatti Novara, comprendendo in extremis che era ormai in dirittura d’arrivo un progetto di Università a tre teste, provò a sganciarsi dall’accordo che avevamo avuto sin lì con essa, ma troppo tardi. Ci fu persino un tentativo della ministra Falcucci di legalizzare l’Ateneo novarese – da me documentato nell’articolo sul “Piccolo” del 14 febbraio 1987 Tutte le ragioni di una scelta su cui si continua a discutere – a prescindere da tutti gli orientamenti di cui si è detto.
Ma l’iniziativa dei parlamentari piemontesi – taluni dei quali contattati – di chiedere tutti insieme, nessuno escluso, persino con progetto di legge firmato da “tutti” i deputati e senatori del Piemonte Sud dal PCI, PSI e DC al Movimento Sociale (3 luglio 1987), sventò la cosa. Ci fu pure una proposta del neoassessore regionale Alberton di dirottare “Scienze” da Alessandria a Novara. Fu assolutamente decisivo che l’accordo con l’Università di Torino fosse stato ormai formalizzato, come lo stesso preside di Scienze ricordò all’assessore regionale in questione.
Tutto questo accadeva tra il 1982 e il 1988 (con i prodromi dal 1972 ad allora di cui ho detto). Il processo fu poi compiuto, con nascita del nuovo Ateneo piemontese tripolare, con la legge del 1998 in cui ebbe un ruolo pure un deputato del PDS già segretario della Camera del Lavoro di Alessandria, Renzo Penna, che su ciò scrisse poi il libro Università, Cronaca di un’autonomia conquistata (Boccassi, 1998).

Dopo di allora molta acqua è passata sotto i ponti. E moltissimo resta da fare. Tuttavia le Facoltà fondamentali sono state quelle tre indicate, finché non sono state sostituite dalla struttura per dipartimenti e corsi di laurea oggi vigente in Italia. Nel 2018, nell’Università del Piemonte Orientale (UPO), gli studenti in Alessandria risultavano 3477, sui 12.974 dell’Ateneo. I laureati del nuovo Ateneo, dal 1998 ad allora, sono stati 28.000. Nella parte alessandrina dell’Ateneo, come ha dimostrato anni fa un interessante studio dell’economista Alberto Cassone, questi laureati sono risultati per lo più figli di persone non laureate: il che indica una significativa spinta alla mobilità sociale, tra l’altro in Facoltà che gli indicatori scientifici hanno posto tra le migliori del Paese.
Inoltre, il decentramento si è fatto sempre più intenso dentro la stessa Università tripolare, tanto che oggi i corsi di laurea operanti in Alessandria, sono i seguenti: Chimica, Economia aziendale, Infermieristica, Informatica, Lettere, Scienze biologiche, Scienze politiche, sociali e dell’amministrazione. Non sembrano risultati di poco conto. E se gli alessandrini si svegliassero dal “sonno dogmatico” dei politici, spesso capaci soprattutto di fare lamentazioni sulla “secchia rapita”, un tempo contro lo strapotere di “Torino” e ora contro “la fatal Novara”, e si decidessero a dare nuovi spazi all’Università, e a sfruttare competenze d’altro livello, e ad aprire foresterie e mense per studenti e docenti, incoraggiando l’espansione in atto, nel giro di pochi anni potrebbe diventare attuale, e persino “naturale”, il passaggio dall’Università tripolare all’Università di Alessandria. Ma accadrà mai “tra il Bormida e il Tanaro” di questa malinconica epoca?
Giancarlo Patrucco
La città delle scarpe e quella degli stivali, da il mensile “la Città”, 15 dicembre 1994, n. 2
Non è facile riflettere su quanto è successo il 6 novembre, L’alluvione è una ferita aperta ed evidente. L’acqua e il fango di quel giorno, insieme alle case, hanno travolto di colpo certezze, progetti, sogni e aspirazioni che ci vorrà tempo per ricostruire
Si capisce bene, allora, come da questa devastazione affiorino per adesso soltanto ricordi frammentati che si mescolano alle rabbie e alle paure che ognuno di noi si porta dentro da allora. Perché ciò si fermi in un quadro dai contorni certi, ci vorrà molto tempo ancora. Eppure qualche considerazione che possa valere per tutti bisogna farla. Ad un mese dall’alluvione, è bene elencare alcune cose almeno, che fanno parte di quella tragica esperienza e di quanto ne seguirà.

Abbiamo bisogno, prima di tutto, di capire bene ciò che è successo. Di conoscere le sue cause recenti e quelle remote, per poter valutare e distribuire i pesi e le responsabilità. Non possiamo accontentarci di ricostruzioni affrettate e dei si dice. Ben vengano allora le inchieste, le perizie, gli accurati accertamenti. Rivendichiamo il nostro diritto ad una ricostruzione chiara e trasparente, che fissi i contorni di ciò che è stato e giunga alle sue conclusioni. Non per dimenticare – perché non potremo dimenticare – ma per evitare che simili situazioni possano ripresentarsi.
Il futuro di Alessandria ha bisogno di certezze da cui partire per trovare le forze necessarie a ricominciare. Abbiamo sentito annunciare più volte che ormai l’emergenza è finita e siamo passati alla fase della ricostruzione. Ce lo confermano i bollettini ufficiali e lo lasciano capire le televisioni, nei servizi sempre più brevi che dedicano alle nostre vicende.
Confessiamo di non capire bene cosa significhino questi annunci. Se sono una forma burocratica o un rituale giornalistico-televisivo, poco ci interessano. Noi sappiamo che non poter abitare le case e ricostituire le famiglie è emergenza. Che stare nell’umidità o vivere in situazioni precarie è emergenza. Ed è emergenza non avere certezze e non intravedere speranze per il futuro. Quando avremo superato questo, allora l’emergenza sarà finita. Allora, non prima.
Dalle televisioni e dai comunicati aspettiamo di sentire impegni certi e rapidi nei confronti di Alessandria, come di tutte le zone colpite. Di soldi, insomma, senza troppi artifici contabili e tanti giri di parole. Le priorità sono facilmente individuabili e riguardano specialmente la casa e il lavoro. Ci sia fornito un finanziamento equo, commisurato ai danni subiti, così come equo e commisurato è sempre stato il nostro contributo al benessere comune. Per il resto, rimboccarci le maniche non ci ha mai spaventato.
Durante queste settimane abbiamo avuto modo di ritrovare tra noi legami di vicinanza e di condivisione che credevamo scomparsi. La solidarietà di tanta gente non potrà essere dimenticata. Essa ci ha consegnato il senso dell’unità, come bene da preservare per il futuro.
L’acqua ha tagliato in due Alessandria. Questo taglio deve essere ricucito. Nessuno deve pensare che la città delle scarpe possa avere un destino diverso da quello della città degli stivali. Il destino di Alessandria è comune e dovremo costruirlo insieme. Evitiamo quindi le linee di divisione, anche quelle più nascoste. Non lasciamo terreno fertile per i furbi e per i disonesti, ma neanche favoriamo le strumentalizzazioni e le ambiguità.
Nei mesi a venire avremo bisogno di trasparenza e giustizia. Non pretendiamo di meno, da noi stessi e dagli altri. L’appello va agli amministratori e a chi riveste cariche pubbliche. Il monito è rivolto a esibizionisti e accaparratori. Non è aria ed è bene scoraggiare subito le tentazioni.
In questo compito, rilevante è il peso che tocca all’informazione. Ad un’informazione corretta e completa spetta il compito di far conoscere i fatti. Tutti i fatti. Ma anche di rafforzare e presidiare quell’equilibrio e quell’oggettività di giudizio che sono indispensabili nelle attuali situazioni. Come giornale appena nato sentiamo in modo particolare questa responsabilità. Cercheremo di corrispondervi sempre.
Mauro Cattaneo
Cronaca di tre giorni, da il mensile “la Città”, 15 dicembre 1994, n. 2
L’alluvione del 4-6 novembre che ha colpito duramente il territorio alessandrino ha avuto origine dalle eccezionali precipitazioni cadute nell’alto bacino del Tanaro, del Bormida, del Belbo e di altri torrenti minori. I primi dati a disposizione indicano precipitazioni dell’ordine di 300-350 mm. nell’arco di 24 ore a partire in alcune zone della notte di venerdì 4.
In una prima fase (il giorno 4) forti piogge a carattere temporalesco hanno interessato il Piemonte meridionale, ai confini con la Liguria.
Il 5 le precipitazioni si sono estese all’astigiano e al cuneese. Nel pomeriggio e nella stessa serata è stata interessata la fascia prealpina fra la Val Pelice e la Val Sesia.
Il letto del Tanaro è stato completamente saturato da un’enorme massa d’acqua che, nella situazione di grave dissesto idrogeologico esistente, ha portato con sé detriti e materiali legnosi di ogni tipo, avviando una disastrosa inondazione del territorio circostante.
L’ondata di piena che ha contribuito alla elevazione abnorme del livello del fiume è transitata presso la città di Asti, allagandola al 30 per cento, attorno alle ore 2 della notte fra il 5 e il 6 novembre.
Quindi il letto del fiume si è allargato enormemente verso valle e ha inondato le campagne di tutti i territori rivieraschi (Castello d’Annone, Rocchetta, Cerro e, in provincia di Alessandria, Masio, Felizzano e Solero) giungendo intorno alle 11-11.30 presso Alessandria.
Qui le acque hanno incontrato ostacoli di ogni sorta: la massicciata della ferrovia, il terrapieno dell’autostrada, eccetera, che hanno contribuito a provocare vortici e rigurgiti.
La piena si è incanalata oltre la sponda sinistra ritrovando spontaneamente l’antico corso del fiume, abbandonato da secoli, e ha investito Astuti e San Michele dopo aver sfondato la massicciata della ferrovia raggiungendo livelli anche di quattro metri.
Verso le 11.30-12.00 iniziava l’inondazione della città a partire dalla Canottieri per proseguire in zona piscina e Lungotanaro; le acque raggiungevano nel primo pomeriggio il centro storico fino a sfiorare piazza della Libertà.
Proseguendo oltre il ponte della Cittadella la piena invadeva i giardini e il Lungotanaro Magenta distribuendosi parte in città e parte agli Orti, arrivando ad allagare il quartiere intorno alle 12.30-12.45. L’acqua entrata in città rifluiva per naturale pendenza verso gli Orti; qui, prendendo una direzione perpendicolare alla sponda fluviale, raggiungeva il campo d’aviazione e tutta l’area compresa tra questo e l’arginatura di Bormida.

Nel frattempo sulla sponda sinistra veniva allagato tutto il territorio a sud dell’autostrada Torino-Piacenza. L’acqua aggirava la Cittadella inondandola e rientrava quindi in Tanaro causando una forte pressione sulla riva opposta.
Lo sfondamento dell’argine di via della Chiatta avveniva solamente verso le 14.30 quando la piena del fiume, probabilmente ostacolata nel suo deflusso da una fila di baracche, tracimava l’argine stesso lesionandolo in più punti e penetrando violentemente nel quartiere.
Il livello dell’esondazione agli Orti cresceva ulteriormente quando parte delle acque che avevano oltrepassato il campo di aviazione, raggiungendo l’argine sulla Bormida rifluiva verso il quartiere già inondato. Parte dell’acqua, però, si espandeva fino al terrapieno dell’autostrada prima della confluenza con la Bormida, superandolo con un’onda di piena che invadeva la sede stradale mentre alte colonne d’acqua si innalzavano per 4-5 metri oltre i passaggi sottostanti l’autostrada.
Verso le 22-22.30 agli Orti il livello delle acque iniziava a scendere al ritmo di circa 10 centimetri all’ora.
Renzo Penna
“Ci dicevano: Non Drammatizzate”,Nuova Rassegna Sindacale del 21 novembre 1994
L’alluvione del 5 e 6 novembre è stata la più grande calamità naturale che si è “abbattuta a memoria d’uomo” sul Piemonte. Le cifre del disastro parlano di 63 morti, decine di feriti, centinaia di Comuni invasi dalle acque e migliaia di persone sfollate in alloggi di fortuna.
Le città di Alessandria e Asti, Alba e buona parte della provincia di Cuneo, Varallo Sesia, Trino Vercellese e alcune località nelle vicinanze di Torino, risultano le realtà più colpite dai lutti e dalla distruzione per un evento in larga parte prevedibile e che invece ha colto di sorpresa e impreparata la popolazione,
Nessuno ha avvertito per tempo la gente, la Protezione Civile non è letteralmente esistita nonostante che le condizioni atmosferiche e l’entità eccezionale delle precipitazioni fossero note da giorni e il maltempo avesse già causato pesanti conseguenze nelle zone di confine del sud della Francia.
La Giunta Regionale ha calcolato nei primi giorni in 5.500 miliardi i danni, ma con il passare delle ore e l’emergere di un quadro più preciso della situazione, le previsioni della catastrofe attestano più credibilmente in almeno 10.000 miliardi l’ammontare delle conseguenze del disastro, mentre sono oltre centomila i lavoratori dipendenti e autonomi rimasti senza lavoro cui si dovrà provvedere con interventi e misure straordinarie.
Personalmente mi è capitato di vivere “da dentro” l’esperienza dell’alluvione di Alessandria, seguirne le tappe tragiche, quasi irreali, di una città completamente indifesa, in poche ore tagliata in due e resa incomunicabile dalle acque e dal fango. Ho assistito nella tarda serata di sabato 5 alla chiusura dei principali ponti sul Tanaro decisa dal Comune per la crescita impetuosa del fiume, e al fatto incomprensibile che nella notte e nelle prime ore di domenica nessuno sia intervenuto per dare l’allarme e provvedere all’evacuazione dei quartieri e delle zone più a rischio, mentre le conseguenze della piena si erano già fatte drammaticamente sentire nelle valli del cuneese, ad Asti, e il fiume fosse uscito dagli argini solo nella tarda mattinata di domenica. Un fatto assurdo per la società dei media, delle comunicazioni, dei “fax e dei telefonini”, su cui riflettere, che ne denuncia le clamorose debolezze strutturali, e ci riporta ad una realtà crudissima tutt’altro che “virtuale”.
Le responsabilità per l’alluvione di Alessandria e delle altre località del Piemonte sono gravissime e colpevole l’incompetenza e la paralisi manifestata dalla Protezione Civile sia nella fase decisiva della prevenzione che nell’organizzazione dei soccorsi. Ancora nel pomeriggio e nella serata di domenica a disastro avvenuto, con il centro della città allagato, le zone più colpite sommerse da oltre due metri d’acqua e la gente arrampicata sui tetti, in Prefettura si invitava a “non drammatizzare la situazione”.
Si dovrà a tutto questo rispondere in maniera convincente, una volta superata l’emergenza, accertando le evidenti responsabilità, in primo luogo per rispettare il dolore e le sofferenze di tanta parte della popolazione, e perché poi una impreparazione e una disorganizzazione così evidente della Protezione Civile – in Piemonte già manifestatasi con l’incidente al pozzo petrolifero di Trecate – risulta in contrasto stridente con le necessità di una società avanzata ed efficiente che può convivere con i rischi solo se questi sono resi compatibili con l’ambiente e la sicurezza delle persone. Da questa prova di gravissima e colpevole inefficienza vanno esclusi e in generale elogiati per l’impegno profuso, il personale dei Vigili del Fuoco, le Forze della Polizia e dell’Esercito che hanno tratto in salvo moltissime persone, e in particolare le Forze del Volontariato che si sono attivate in autonomia e che in questi giorni stanno assistendo gli anziani, gli sfollati, liberando dal fango le strade e le case e supportando le carenze e la confusione dei soccorsi ufficiali.
CGIL – CISL – UIL del Piemonte in maniera del tutto unitaria stanno rispondendo bene a questa evenienza drammatica. Il Sindacato è impegnato con le proprie strutture e le sedi agibili (la Camera del Lavoro di Asti è stata allagata) nella raccolta di indumenti e materiali di primaria necessità e nella organizzazione dei soccorsi.

Alla Camera del Lavoro di Alessandria, trasformata in centro operativo unitario, ho visto arrivare centinaia di lavoratori, moltissimi giovani, molte le ragazze, e impegnarsi per ore nel fango nelle zone più colpite della città dove spesso non era ancora intervenuto nessun aiuto.
La scelta in questo senso compiuta dalle Segreterie Regionali di essere presenti alla manifestazione del 12 novembre a Roma con delegazioni ridotte, dalle realtà colpite, ha risposto ad una necessità morale, all’esigenza di non sguarnire di forze chi più ha bisogno, ed è risultata in piena sintonia con la solidarietà diffusa che si vive in questi giorni dove la disperazione e le sofferenze risultano maggiori.
Lo striscione listato a lutto di CGIL CISL UIL del Piemonte ha aperto, nella straordinaria manifestazione di Roma, il corteo confluito in Piazza San Giovanni, e la delegazione di Alessandria – insieme a quelle di Alba ed Asti – ha ricevuto, lungo tutto il percorso, una commossa attenzione e una vivissima solidarietà.
Per il Piemonte questa alluvione non rappresenta infatti solo un evento tragico, ma “ordinario”, archiviabile come “locale”. Al contrario, la vastità del territorio interessato, la varietà e la ricchezza dell’apparato economico e produttivo distrutto, rischiano di pesare, se non riattivato con misure straordinarie, sulla stessa ripresa del Paese, condizionandola negativamente. Sono centinaia le imprese industriali, grandi e piccole con i macchinari e gli impianti inservibili e da sostituire, è la struttura commerciale di intere città che è stata sconvolta, l’agricoltura di vaste zone cancellata, ma sono numerosissimi gli interventi di ripristino delle infrastrutture sul territorio da realizzare in tempi rapidi (centinaia di ponti e cabine elettriche distrutte, centinaia di frane e interruzioni stradali e ferroviarie, interi ospedali evacuati e resi inagibili).
La piena non ha risparmiato il patrimonio artistico e culturale (decine le chiese allagate, i centri storici distrutti). A Santo Stefano Belbo, nel cuore delle Langhe, il torrente omonimo ha distrutto il Centro Studi “Cesare Pavese” e compromesso in maniera forse irreparabile gli scritti originali dell’autore de “La luna e i falò”. Ad Alessandria preoccupa la stabilità della chiesa di Santa Maria di Castello già in condizioni precarie.
Una volta superata l’emergenza, il problema riguarderà i tempi, la programmazione degli interventi, l’entità delle risorse da mettere a disposizione e la responsabilità della gestione da definire per rendere più utile, credibile e tempestiva la fase della ricostruzione. Bisognerà per il Piemonte in tutti i modi scongiurare il rischio del ripetersi di altre negative esperienze fatte di corruzione e di opere mai completate.
In una fase politica nella quale il “federalismo” è sovente annunciato e gridato, è importante che al governo della Regione sia garantita la piena titolarità nella gestione della ricostruzione. Gli intenti dirigisti e centralisti del Governo, già evidenti nei primi comportamenti, vanno scongiurati perché predestinati ad affondare nelle clientele e nei meandri della burocrazia e a diluire gli interventi con una tempistica insopportabile.
I tempi degli interventi devono essere rapidissimi, e le decisioni conseguenti hanno bisogno di procedure semplificate e straordinarie che sono possibili solo a ridosso dei problemi. Nell’assegnazione delle risorse e dei contributi necessari si dovrà ad esempio dare assoluta priorità a chi intende nei diversi campi riprendere l’attività economica ed i lavoro.
Si può davvero sperimentare e mettere in pratica per il Piemonte un progetto di “federalismo fiscale di emergenza” (come sostiene Mario Deaglio) nel quale, sino a ricostruzione ultimata, le imposte pagate in Piemonte vengano spese in Piemonte. Questo risulterebbe credibile per una Regione che non è mai stata assistita, che versa in una condizione eccezionale, che non è debitrice verso lo Stato e non intende venir meno ai doveri di una solidarietà più generale.
Per il Piemonte, che attraversava ancora una fase di ripresa molto debole e senza nuova occupazione dopo anni di una crisi non congiunturale del suo apparato produttivo, l’alluvione è stato un colpo durissimo. La volontà dei singoli non è in discussione, ma il “rimboccarsi le maniche” invocato dal Presidente del Consiglio non è sufficiente e non può bastare.
- Da Una Cittadella per l’indipendenza. ↑
- [Trad. dal dialetto piemontese] “Gli Spagnoli coi Francesi (i gallispani) – ci son stati sotto cinque mesi – per far nient’altro che i Fanfalucchi – e poi trovarsi a mani vuote (… …) – Con la loro gran armata – stavano facendo i panada – non hanno mai voluto muoversi, – andar sotto ad annusare – gli sembrava un po’ rischioso – avvicinarsi troppo al fuoco – limitandosi, cosa che gli stava a cuore, – a tastare come ladri – quella povera Cittadella – senza neanche sverginarla!”, cfr. La distinta relazione dell’assedio della città di Alessandria (1745-1746), p.10-11 e 37-38. ↑
- Journal d’Alexis Delisle 1806. ↑
- Ivi. Diverse altre citazioni analoghe in Maestri, La Cittadella e in Cerino, La strada di Fiandra. ↑
- Da Una Cittadella per l’indipendenza. Catalogo della mostra storico-documentaria. ↑
- Maestri, p. 85 ↑

